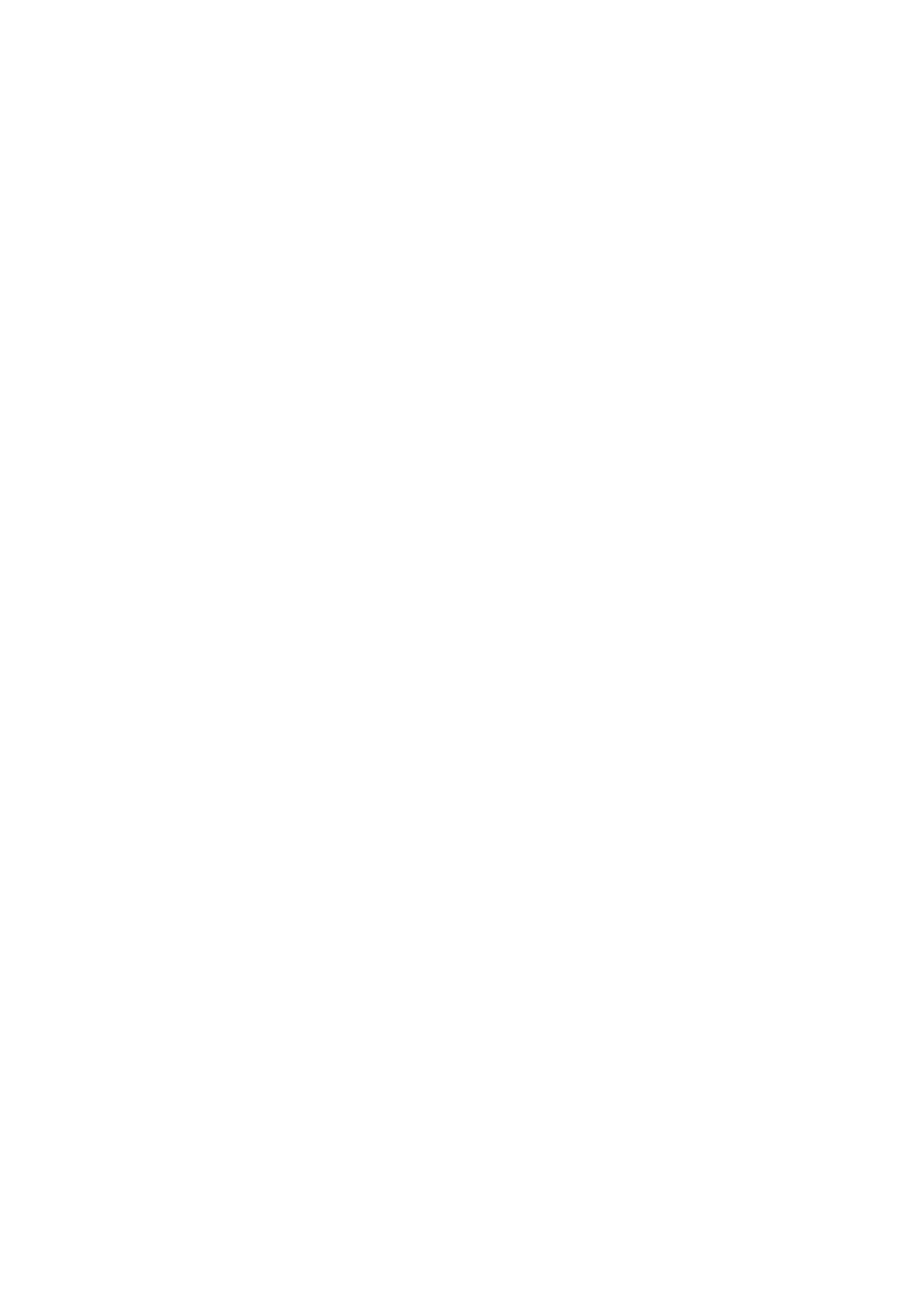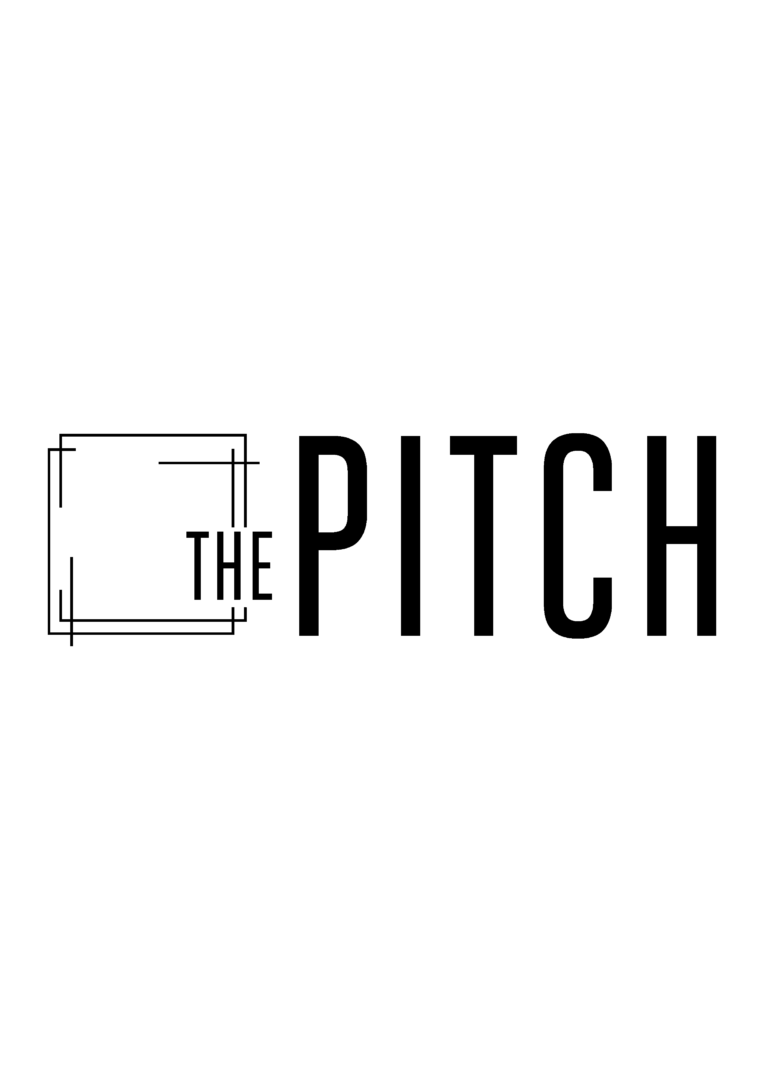Antonioni e il tempo dell’attesa
È indubbiamente strano inaugurare una rubrica sullo Slow Cinema in un momento in cui siamo costretti a rallentare per via del coronavirus. E lo è ancora di più parlare di un film come L’eclisse di Antonioni, una pellicola che mostra di fatto un lungo “tempo morto”, di attesa, della sua protagonista Vittoria (Monica Vitti).
Si è parlato a proposito, nell’introduzione a questa rubrica, dell’esigenza da parte di un certo cinema di restituire alla pellicola un nuovo “tempo”, non più contaminato dalla frenesia e dall’imposizione di correre da un’azione all’altra. Antonioni è stato senza dubbio uno degli ispiratori di questa tendenza, ponendosi come uno dei precursori dello Slow Cinema. Nella cosiddetta «tetralogia esistenziale» dei primi anni ’60 (composta da L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto Rosso) l’esigenza di voler esplorare non tanto l’azione, quanto il “decentramento” di essa, è proprio il motore principale che muove i film. Si è spesso parlato riferendosi a questo ciclo di film di temi come l’incomunicabilità, o la «malattia dei sentimenti»; temi che per arrivare allo spettatore nella loro natura confusa vanno inevitabilmente a intaccare il ritmo e la centratura della narrazione.

L’eclisse (1962) rappresenta probabilmente l’epicentro di questa crisi, e il punto più alto nell’estremizzazione del linguaggio filmico della tetralogia; un linguaggio che perde progressivamente il suo centro fino a uscire integralmente da sé nella parte finale.
Come far arrivare allora questa perdita del centro e trasmetterla a chi osserva? Proprio attraverso l’annullamento di un intreccio narrativo forte e il rallentamento estremo della narrazione stessa. Del resto, i primi 40 minuti di film sono occupati da sole tre scene. La prima di queste, che apre la pellicola, ne detta già il ritmo ibernato. È una coppia che si lascia in una casa, alle prime luci dell’alba. Lei ha già deciso. Lui, per quanto consapevole della scelta, non si è ancora arreso. Sono gli ultimi venti minuti della loro relazione, e noi li vediamo senza tagli o abbellimenti, in tutta la loro incongruenza: silenzi, contraddizioni nelle parole, difficoltà a dirsi le cose come stanno, lenti tentativi di chiudere il rapporto nella maniera migliore possibile. Se canonicamente una scena del genere avrebbe potuto risolversi in una manciata di dialoghi e in un paio di minuti di botta e risposta, qui il ritmo è quello ondivago della realtà: non si trasmette più attraverso le battute dei personaggi, quanto tra i silenzi tra una battuta e l’altra. È la fatica di parlare, la fatica di andare e lasciare andare, a trasmettere la fine del loro rapporto, più che le parole e le battute del dialogo. Senza il rallentamento e la messa in scena corporea (quindi spaziale e temporale) di questa difficoltà, non sarebbe stato possibile far arrivare così prepotentemente i sentimenti contraddittori dei personaggi.

Non è un caso che la lunga scena successiva, in Borsa, mostri un clima all’esatto opposto. Caos e frenesia, nessun istante per respirare e interrompere il flusso. Lo sguardo esterno di chi osserva fatica a cogliere un centro, un senso. E la prima a osservare spaesata è proprio Vittoria: è l’inizio per lei di una serie di situazioni in cui più che sentirsi parte attiva si troverà agita. Ed è sintomatico da questo punto di vista il passaggio a vuoto della scena: Vittoria è lì per dire alla madre, che si è riscoperta giocatrice di borsa, della fine della sua relazione ma, non sentendosi ascoltata, se ne va senza dire nulla. La scena di per sé non ha nessun valore narrativo, se non per l’incontro che Vittoria fa con Piero (Alain Delon), un ragazzo che ha la madre come cliente e con il quale Vittoria comincerà successivamente a frequentarsi. Il valore reale della scena non sta nel significato delle azioni quanto in ciò che non sta accadendo perché non c’è comunicazione reale tra i personaggi. E questa incapacità di chiarire i propri sentimenti e comunicarli all’altro porterà alla serie di “uscite a vuoto” di Vittoria, e ai diversi tentativi di ritrovare una strada, andando a tentoni e lasciandosi trasportare dalla corrente degli eventi.

Gli unici eventi reali e significativi che Vittoria vive sono quelli che riguardano le attese, i silenzi, i momenti di contemplazione: il rumore delle barre metalliche o delle foglie degli alberi mosse dal vento, lo sguardo sulle architetture cittadine, o su oggetti insignificanti incontrati lungo la strada, come il pezzo di legno dentro un secchio pieno d’acqua che scandisce i suoi incontri con Piero e sembra avere una correlazione diretta con il suo stato emotivo. Perciò il significato delle immagini passa attraverso la sospensione, togliendo progressivo spazio all’intreccio narrativo; un intreccio che di per sé ha un significato che “esce fuori” dal vissuto dei personaggi e per questo motivo viene messo da parte, come un corpo estraneo.

L’uscire fuori dei personaggi si fa effettivo nel finale del film: sette minuti in cui lo sguardo della macchina ha perso per strada Vittoria, uscita realmente di scena. Non c’è più nulla da raccontare, o forse non c’è più motivo di in-seguire i personaggi. Rimangono le architetture del quartiere dell’EUR a Roma, in una città deserta all’alba; restano i luoghi dove i personaggi si sono incontrati, che raccontano per scarto e per assenza. Mostrano di fatto l’apice della sottrazione messa in atto da Antonioni.

Vedere le strade vuote e i luoghi che parlano per sottrazione non può che far venire in mente lo strano isolamento a cui siamo vincolati in questo periodo. Un’imposizione al rallentamento, che se però provassimo a vedere in una maniera attiva, di riscoperta, potrebbe riportare sostanza anche a ciò che accade fuori scena. E chissà, farci rivalutare alcune piccole cose che nella frenesia di tutti i giorni avevamo messo da parte.
Risuona una strana eco nella parole di Antonioni in questa intervista del 1969 di Roger Ebert: «Spesso i miei personaggi sono isolati; sono individui alla ricerca di istituzioni sociali che li supportino, di relazioni personali che li assorbano. Ma molto più spesso trovano poco che riesca a sostenerli. Sono in cerca di una casa».