Dell’inammissibile, del subumano
Il giorno in cui il professor V ci lasciò per andare in pensione fu di una grande tristezza per tutti.
Era il 14 Luglio del 2063 – giorno della presa della Bastiglia! – non smetteva di ricordare, con un sorrisetto compiaciuto sotto i baffi. Il professor V aveva insegnato Storia e Filosofia al liceo Linguistico di Bari per quarant’anni. Era entrato di ruolo a trent’anni tondi tondi ed ora se ne andava, pago e felice, forse, delle sue settanta candeline sulla torta.
Il signor V aveva sempre amato le cifre tonde e chiare, come precise, ragionate e ponderate erano state le sue lezioni per una vita intera. “Spiegare con chiarezza”, “stimolare”, “rendere creativi e ragionanti gli allievi”: questi erano i suoi pilastri per l’insegnamento. Colleghi e alunni, collaboratori e dirigenti: tutti gli volevano bene per la sua professionalità, affabilità, cortesia.
Era un uomo sempre disponibile e sempre cordiale. Nonostante i settant’anni, non sembrava risentisse degli affanni della vecchiaia e camminava svelto, per i corridoi, dinoccolato, con i suoi libri immancabilmente sotto braccio, “come in Francia i francesi con le baguette”, aveva ironizzato una volta un’alunna.
I colleghi si chiedevano cosa si sarebbe escogitato il professore dopo la pensione: quell’uomo infatti pareva essere forgiato dello stesso materiale dei corridoi, delle aule, le scale, i laboratori; col tempo la sua figura si era talmente e profondamente stanziata in quella scuola, da apparire parte integrante non solo del personale, ma della struttura: come uno scalino, un corridoio, una colonna portante.
*
Quel giorno arroventato di Luglio festeggiavamo in aula insegnanti la fine degli esami, il congedo di V ed io, silenziosamente (non lo avevo detto a nessuno dei colleghi) brindavo a mia moglie e alla bambina che sarebbe nata verso la fine dell’estate.
Erano le cinque del pomeriggio, il caldo insopportabile – il ventilatore buttato all’angolo della sala in un turbinio di polvere gelata lanciava raffiche di sollievo miste all’agonia del sudore che si spiccica e condensa sulla schiena, lungo le vesti madide – ma nonostante lo spiacevole umidiccio, sembravamo tutti felici e in vena di bagordi. C’erano salatini, pizze, panini farciti, pasta fredda, birra, gin tonic, succo di mango e papaya…Il professore sorseggiava del succo di frutta, mangiucchiando con appetito un’insalata di farro.
Mi avvicinai a lui:
“Gradisce un po’ di gin tonic, professore?” “No grazie, sono al quinto” “Ma è succo di frutta!”, risposi io, scosso da un breve singulto. Lui rimbeccò, tonante, con ironia ampollosa: “Certo, questo è succo di frutta, però i quattro bicchieri di gin tonic che ho assunto nel corso della festa, non possiamo ignorarli”. Abbassando il tono della voce, con una lieve malinconia aggiunse: “Mi creda, collega” – con la mano mi fece segno di avvicinarmi: “sono ubriaco lercio, e questo è male, molto male!”
Lo osservai attento: in effetti il professore aveva un vago odore di gin addosso, i suoi occhi erano meno vispi del solito e un fastidioso tic lo portava a leccarsi le labbra in continuazione. Dettagli attribuibili all’età, non necessariamente a uno stato di ebbrezza.
Sospirai, comprensivo e paterno come se mi rivolgessi a un bambino un po’ discolo, ma in fin dei conti amorevole: “Beh, professore, quattro gin sono un po’ tanti… però devo ammettere che li regge bene!” “Certo che reggo bene!”, esclamò lui: “Ci faccio colazione tutte le mattine, col gin!” e scoppiò in una risata fragorosa. Io risi a mia volta di cuore, rimbrottando: “Eh professore, sempre il solito burlone! La sua sbornia grazie al cielo è molto più gradevole rispetto a quella di altri”. Dicendo questo lanciai uno sguardo alla Rocchi, di inglese, una collega con la quale in passato c’era stata una vaga attrazione e che ora rideva sguaiatamente tenendo Mercatelli, il collega di matematica, sotto braccio.
Il professor V sembrò non aver notato la mia distrazione, e continuò a parlare: “Eh Stefanelli Stefanelli… dopo quarant’anni di servizio, chissà come diventerà lei, cosa sentirà dentro, come vedrà questo mondo, gli studenti, i docenti…” Senza avvedermene lo interruppi di colpo: “Non lo so proprio. Lei come si sente?”
Qui il professor V parve sorpreso e ferito al contempo. Nessuno della scuola gli aveva mai posto una domanda del genere, infatti rispose: “Come mi sento… come mi sento…” quasi a voler soppesare quelle strane parole fra sé e sé, prima di rispondere: “Come mi sento adesso è irrilevante: ho la gola secca, e so che starò male per le prossime due settimane, ma so anche che potrò permettermi di stare a letto, perché tanto non avrò nulla da fare”. Poi continuò: “Ciò che conta, è come mi sono sentito in questi anni, come mi sono evoluto, dai trenta ai settant’anni. Ma è una lunga storia, non voglio tediarla” Sbriciolando un tramezzino e quasi sul punto di strozzarmi, tempestivo lo smentii: “Le assicuro che non mi disturba affatto. Conversare con lei è sempre un piacere” Il professore, più statico e ieratico che mai, sentenziò: “Se mi presta questo atto di fede, comincerò”.
Ingollò l’ultimo sorso di succo di frutta, ripose il bicchiere sul tavolo e si asciugò le labbra col dorso della mano. Schioccando la lingua, cominciò il suo racconto:
“Sa Stefanelli, quando mi iscrissi all’università, 51 anni fa, non avevo nessuna intenzione di insegnare. Amavo la filosofia e quello che cercavo era un ambiente dove incontrare persone con cui condividere le mie passioni, stimolare l’intelletto, nella speranza (anzi, nell’assoluta certezza) che là avrei potuto insediarmi nel fertile terreno che m’avrebbe permesso di diventare un’importante voce della mia epoca, uno scrittore, un conferenziere, un filosofo… Ma dopo il terzo anno di studi angustianti, capii che la mia carriera universitaria era finita. Dopo la laurea triennale non volli più proseguire”
“Come mai, se non sono indiscreto?”
“Perché il clima universitario si rilevò soffocante. Altro che libero dialogo, fertile terreno dove innaffiare teneri germogli di pensiero… i miei colleghi si rivelarono terrorizzati, lobotomizzati, sodomizzati dagli esami: non era possibile discutere apertamente di problemi filosofici senza rientrare nel dubbio ancestrale del cosa avremo fatto dopo l’università e del come avremo potuto conseguire un voto di laurea alto per stracciare tutti nei punteggi delle graduatorie. Molto avvilente…stimolante: per nulla. Io allora, che non volevo essere uno schiavetto ma che oramai lo ero diventato – impanicato, tachicardico, nevrastenico – dopo la laurea triennale smisi di studiare e girai un paio d’anni come sassofonista in qualche locale notturno dove la maggior parte delle volte m’esibivo gratis. In effetti ero un pessimo musicista, completamente privo di talento: ogni volta che suonavo mi mancava il fiato e mi tremavano le mani. Alla fine l’ansia si prese tutto: a causa dell’ansia smisi gli studi e iniziai le tournée e sempre per l’ansia smisi le tournée e ricominciai gli studi, col risultato che mi ritrovai meno motivato su ogni fronte e ovunque più solo e sperduto. Non so per quale motivo vissi così male la mia giovinezza. Non avevo trovato l’ambiente adatto, ecco, ed ero anche molto scoraggiato: tutti mi ripetevano che sia la musica che la filosofia rappresentavano strade difficili, che mi avrebbero escluso dal mondo”.
Qui il professor V si fermò, fissando con occhi vitrei un punto imprecisato a terra. Io, molto dispiaciuto per la sua tristezza, cercai di infondergli un po’ di coraggio: “Mi scusi se la interrompo, ma poi lei entrò di ruolo e fu una grande presenza per questo liceo!” Lui sollevò lentamente lo sguardo: nelle pupille nere come il carbone era tornata a ardere la fiamma intelligente e acuta di sempre: “Sì, alla fine con molta amertume presi anche la seconda laurea e divenni professore, mi impegnai molto, perché in quella fase della mia vita pensavo che il professore fosse il mestiere, la mansione sociale, il compito e la missione che dovevo assolutamente ricoprire. Avrei tentato di ricreare in classe, con i miei allievi, quel clima culturale di cui ero in cerca durante i primi mesi universitari. Volevo che gli studenti si interessassero alla filosofia, prima di correre a studiarla mnemonicamente sui libri. Ma era molto difficile insegnare: alcuni, rarissimi, erano interessati e studiavano. Altri non erano interessati e non studiavano. Altri ancora non erano interessati ma studiavano; i migliori, ma i più deludenti, erano quelli interessati che però non studiavano, o studiavano male. Questi ultimi erano molto difficili per me da gestire. Quando correggevo i loro compiti in classe mi sentivo male. A volte piangevo per la disperazione. Comunque… noi insegnanti siamo tanto bravi a farcirci la bocca di nozioni quali “studio” “mansione” “correttezza” “disciplina” quando in fondo, siamo proprio noi che manchiamo in primis ai nostri compiti” “Quali compiti?” “Stefanelli, il nostro compito è quello di non arrestarci al livello d’un adolescente. Abbiamo una missione: insegnare le basi, per coltivare in noi la specializzazione. Ma sono pochi quelli che dopo sei ore di lezione, riunioni, compiti da correggere – hanno poi la voglia di accrescere la propria cultura. Così anche noi insegnanti ci rimbecilliamo, assieme agli studenti, che diventano sempre più imbecilli in relazione al progredire delle tecnologie”. “Allora per lei gli studenti sarebbero degli idioti?!” “Ma certo! Cosa crede! In una classe c’è sempre uno o una decente, mentre la massa… è deficiente! Lei insegna lettere, dovrà saperlo no? Quel volgo disperso, che nome non ha… Il paternalismo di Manzoni cos’è, se non un aristocratico sentimento di superiorità?! E a buona ragione! La gente si stupisce dell’ignoranza del paese, quando è logico che le cose siano così deprimenti quando si parla di italiano medio, di istruzione di massa… gli italiani sono stupidi. Per diventare migliori, bisognerebbe togliersi dalle strade, togliersi dalla massa, creare scuole a numero chiuso a partire dagli undici anni, dimenticarsi dell’esistenza di una classe politica abbruttente… quindi, in poche parole, suicidarsi. L’ho sempre saputo, fin da ragazzo. Ma poi… eccomi, buttato fra la mischia urlante, a ventisette anni, laureato senza speranze e senza più interessi, ad arrovellarmi con domandi quali: “mi suicido, o accetto questa supplenza?” In quel disastrato paesaggio di morte dell’anima il lavoro… rappresentò una nuova speranza, subito castrata nei confini di una ricerca esigua e solitaria… tuttavia, posso considerarmi deluso sì, ma non fallito.” “Ci mancherebbe! Fallito, lei…” “La smetta Stefanelli di leccarmi i piedi con i rumori delle benevoli dicerie che girano sul mio conto. Io sono un alcolizzato. Ogni mattina per sopportare tutto questo bevevo. Comunque le stavo dicendo… deluso sì, ma fallito, nossignori! Forse quello che volevo fare con il mio mestiere, era soltanto tranquillizzare i ragazzi. Aiutarli a capire che la vita può essere anche piacevole, che ci si può trovare un lavoro sulla scia delle proprie inclinazioni, tempi e ritmi… certo è necessaria precisione, costanza e determinazione, tutte cose che io ho perso per strada, in una solitudine che non mi spiego, in una delusione, una delusione… per tutta la vita ho cercato di trasmettere ciò che non sono mai stato in grado di concretizzare… bell’affare! Non mi sono saputo ascoltare. Tutto qui. Bene o male adesso c’è lei che mi ascolta, e il problema non si pone”
All’improvviso il professor V ed io fummo riportati alla realtà da un baccano fragoroso: la Rocchi e la Sanpietrini di educazione fisica, per non so quale legge discordante di gravità, avevano ribaltato il tavolo del rinfresco e adesso giacevano l’una a gambe levate sopra una montagna di tramezzini, l’altra invece starnazzava – il viso una maschera di commedia – dal fondo della ciotola super maxi di noccioline. Entrambe erano in preda a un riso convulso, senza ombra di dubbio alcolico.
Qualcuno commentò: “Non è possibile! Siete peggio della terza B!” Mi accorsi che il professor V mi stava tirando l’orlo della camicia, sussurrandomi all’orecchio: “Da domani in poi, anche io sarò come loro, ventiquattrore su ventiquattro però – sempre al bar – gin tonic, vino, birra, martini dry… non mi sono mai impegnato abbastanza, non ho mai voluto portare avanti la ricerca fino in fondo, nel mezzo del deserto è difficile, il sonno e la spossatezza vincono su tutto… le rondini del nostro bel cielo sono i corvacci, i condor e gli sciacalli che aspettano di posarsi su una massa di carogne ambulanti qualsiasi. I progetti di cultura, gli slanci, il dialogo sensato… ghiande per i porci comodi, sterco per i campi asiatici! Allora tanto vale dormire no?” Poi, con occhi assenti, spiritati sospirò: “Di tutte le piccole intime cose che mi sono familiari, i nipotini, ad esempio, non resta che lo sfascio abbruttito di questo proliferare continuo, senza senso, in seno a una nazione che non esiste, se non nell’insquallidimento progressivo della specie” Con un filo di voce, poi, aggiunse: “Conosco solo due cose: la perfezione di un reale sognato in un dormiveglia che mi appartiene, e l’inferno di una vita non mia”.
Detto ciò uscì dalla sala docenti, barcollando leggermente. Io non potei fare a meno di pensare che il professore era molto stanco, e che l’indomani si sarebbe dimenticato tutto. Dopo quarant’anni di insegnamento e una stima incommensurabile, chi avrebbe mai sospettato che per il professor V il suo ruolo rappresentasse solo un tiepido, vergognoso ripiego?
Sicuramente ero un uomo troppo semplice e senza ambizioni, ma proprio non riuscivo a capirlo.
Senza meno, l’indomani gli avrei telefonato.
Erano le sette di sera. Fuori dalla finestra un implacabile azzurro e qualche rondine sparsa mi fecero pensare a Marta, che ora doveva essere sul terrazzo, a guardare le rondini, con le mani affusolate sul pancione. Avevo una voglia matta di tornare a casa, baciare mia moglie, cenare in giardino con le zanzare, i grilli e gli strilli del vicinato. Tutto questo mi allettava. Anch’io, senza salutare nessuno e barcollando leggermente, uscii dalla stanza, all’aria aperta, e subito mi si impresse nelle narici l’odore dell’erba un po’ secca, l’aria dell’estate, il vento caldo; un leggero velluto di benessere e pace s’annunciava fra le rondini, le zecche e le zanzare, nel cielo un po’ arrossato delle sette emmezza. Anch’io – pensavo – come il professore abito nello stesso deserto. Nel medesimo desolato scenario l’unico piacere per noi, che dispensiamo cultura consapevoli della povertà estrema che ci circonda e che ci abita dentro, si palesa nella luce estiva di un momento, nell’amore di una donna, in una cena all’aperto, e in tutte le piccole intime cose a cui ci si aggrappa quando la cultura intera di un paese si degrada ai limiti del nulla, dell’inammissibile, del subumano.


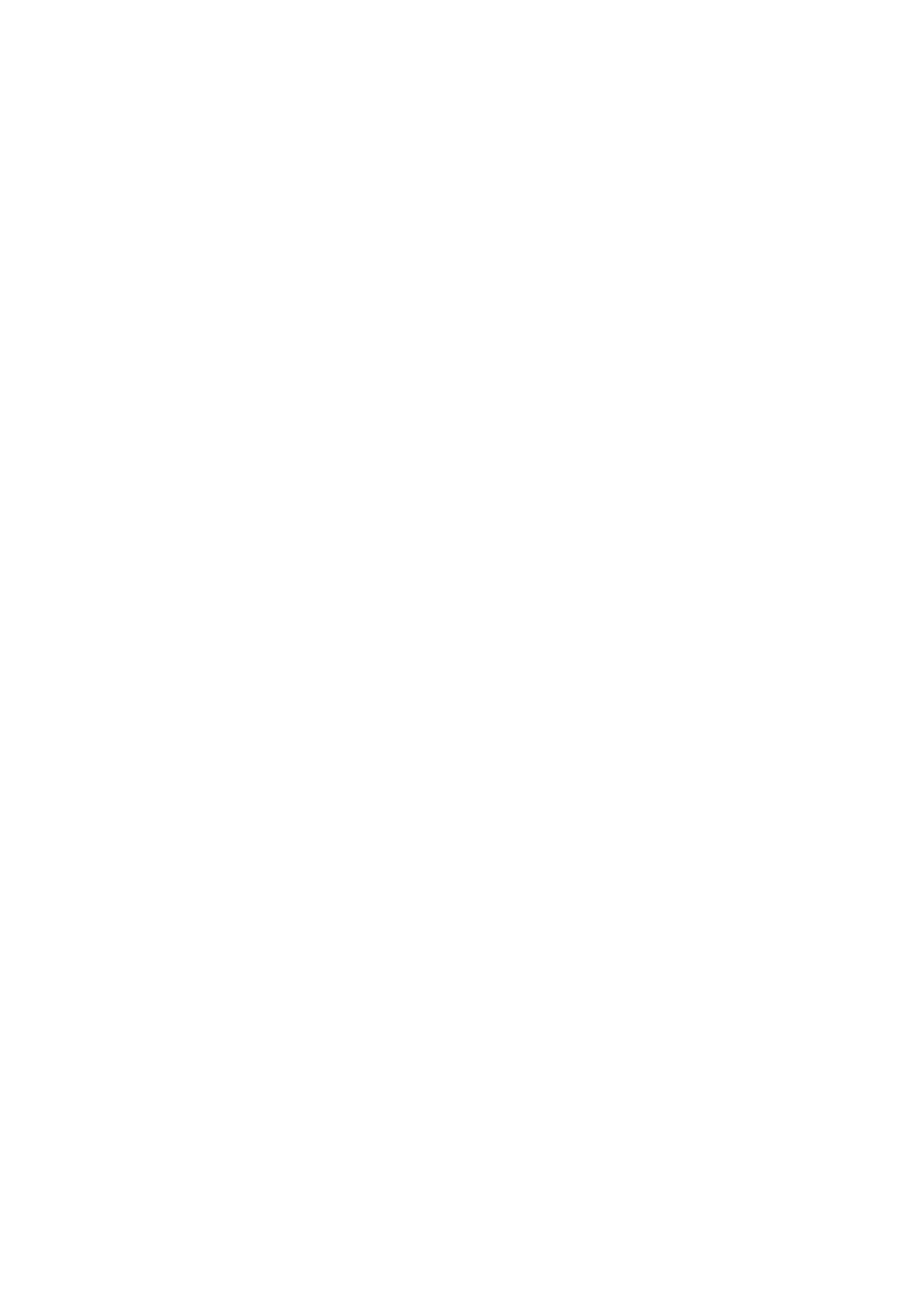
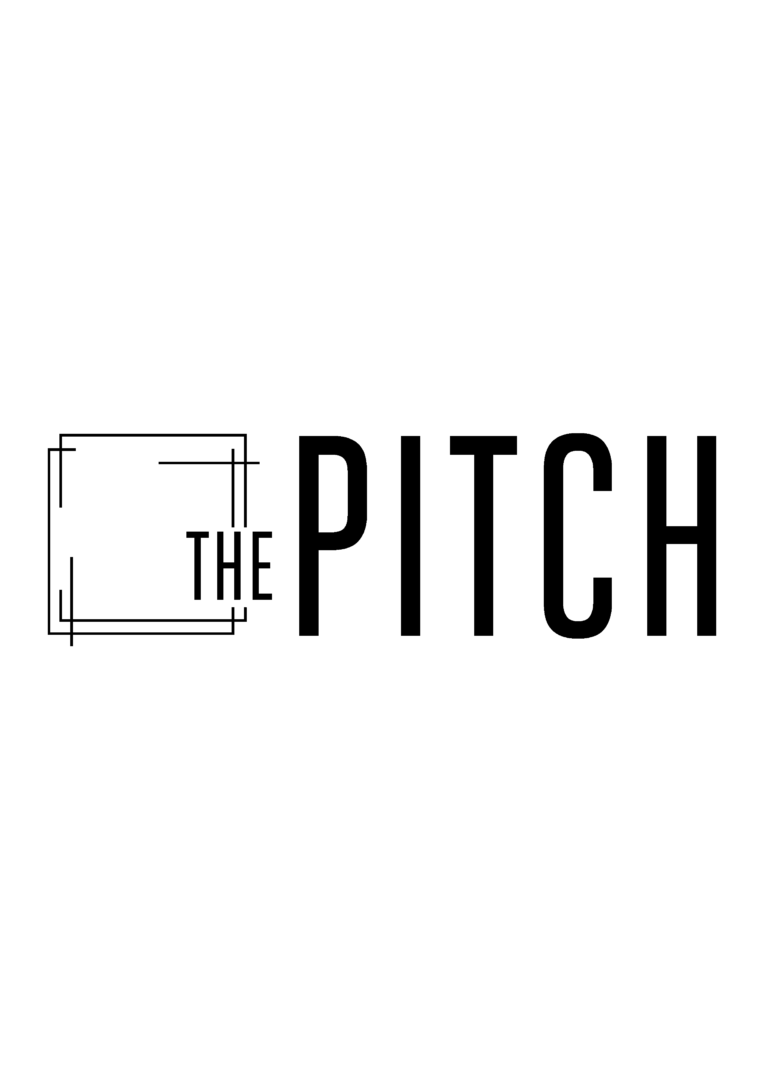
Post a comment