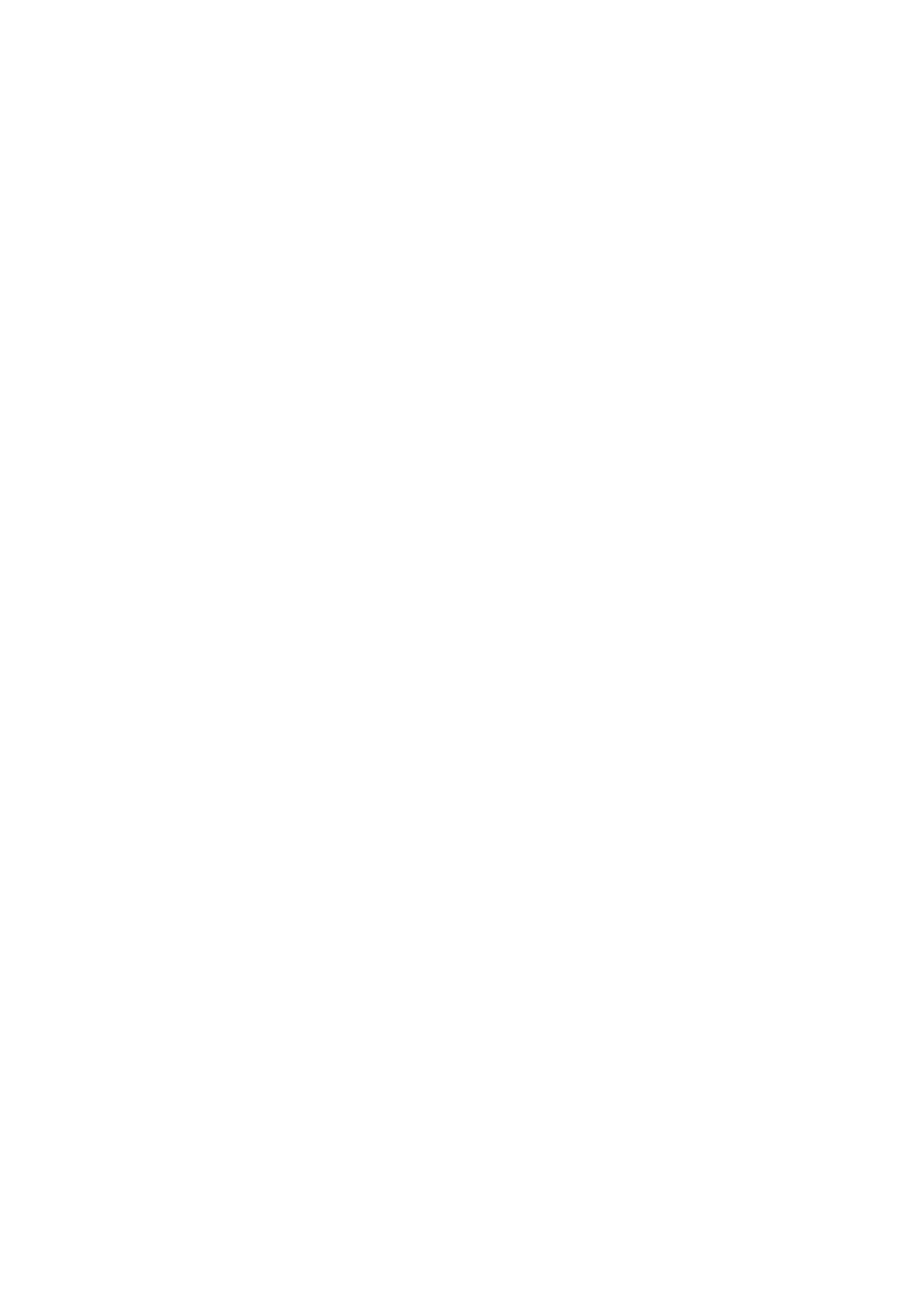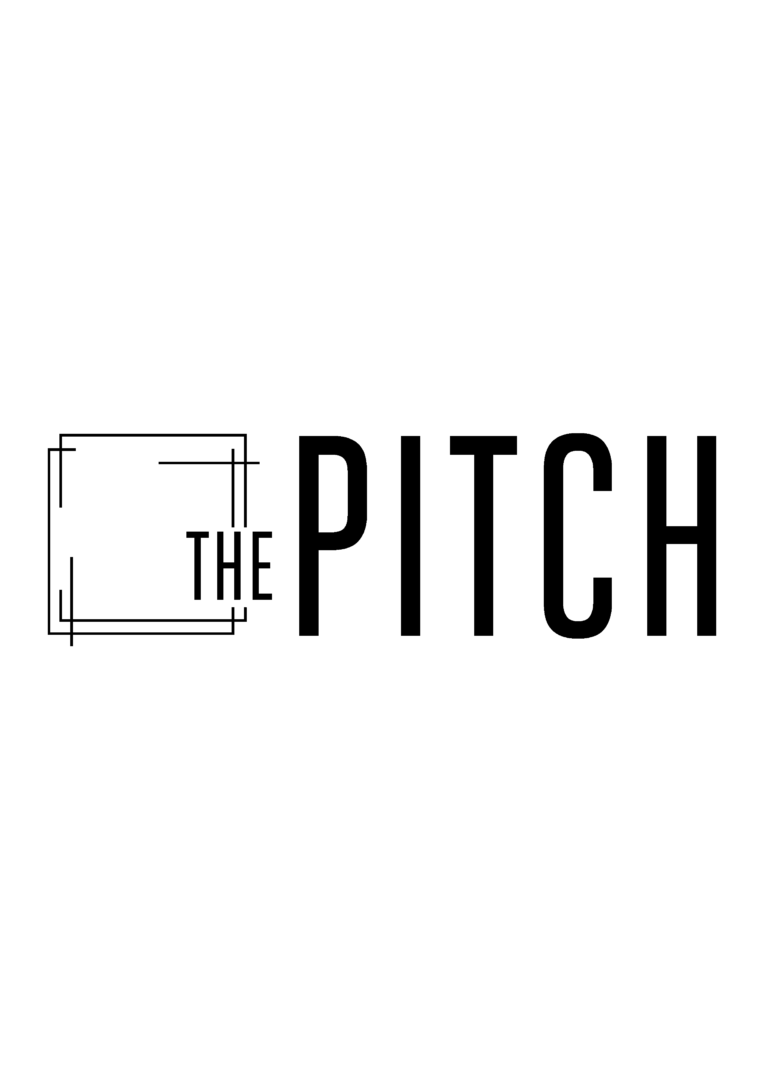Félix Gonzales Torres balla col virus
Félix Gonzales Torres non è particolarmente conosciuto al popolo che mastica arte per provolare con le ragazze o per dimostrare la propria cultura in un’accesa conversazione tra amici. Non appartiene al novero degli artisti ovunque mal citati e sovraccaricati di interpretazioni come Wahrol o la Kahlo, ma, vi stupirà sapere, che è una delle pietre miliari dell’arte contemporanea, o meglio, di quel tipo di arte che viene chiamata “relazionale”.

Immigrato da Cuba agli Stati Uniti, ha vissuto la sua carriera nella New York degli anni ’80, in cui gli omosessuali e i sieropositivi hanno iniziato una rivoluzione culturale di cui ancora oggi vediamo gli effetti. Su quel suolo danzavano i brulicanti e infetti omini di Haring e l’arte murale di Basquiat svelava in colori vividi i sogni retrogradi di un’America che aveva ormai quasi dimenticato la rivoluzione artistica degli anni ’60.
Come Haring, Torres iniziò in quegli anni a dialogare con il virus dell’HIV che lo stava uccidendo insieme al suo fidanzato Ross. L’artista vide morire nel ’91 il suo compagno, cinque anni dopo lo seguì, ma non prima di aver dedicato una profonda riflessione artistica al tema dell’amore, della malattia e del flagello che condannò le loro vite.
Torres ammise candidamente e a più riprese che le finalità della sua arte, che tanto ha contribuito a far riflettere intere generazioni sull’HIV, erano mosse semplicemente dall’amore per il suo compagno. La lotta politica e sociale era solo la risultanza di una necessità emotiva, personale: Torres ha voluto trasformare in arte l’amore per una persona e per il suo corpo, il terrore di perderlo e di vederlo smagrire, mangiato dalla malattia. Si tratta di una visione intima e allo stesso tempo desolante.
Nel ’91, l’anno della morte di Ross, compaiono nelle zone più trafficate di New York ventiquattro cartelloni che ospitano una fotografia scattata da Torres al loro letto matrimoniale, ormai rimasto vuoto: i cuscini sformati, il piumone appena disfatto, le impronte lasciate da un corpo ormai scomparso; la resa fotografica di un silenzio, di un’assenza che assorda. Untitled 1991, è un manifesto di amore e dolore che urla il proprio disagio senza voce in mezzo a Time Square.

Nello stesso anno espone una coppia di orologi identici che sono fermi alla medesima ora (Untitled, Perfect Lovers). La riflessione inizia così a spostarsi più apertamente sul corpo, sull’infezione, sull’espressione più fisiologica del dolore e dell’amore: Ross prima di morire consunto dall’AIDS pesava 80 kg, Torres decide allora di installare 80kg di caramelle colorate in un angolo della Andrea Rosen Gallery, invitando il pubblico a portarsi via i dolciumi e a consumarli. Ogni spettatore sottraeva un brandello metaforico del corpo del suo amante. Questo gioco amaro era basato sulla condivisione del dolore, sulla com-passione, e ricorda a tratti l’idea classica dello sparagmòs, un rito dionisiaco descritto anche dalle Baccanti di Euripide, considerato da alcuni studiosi un precedente pagano del rito eucaristico cristiano.

La riflessione sulla malattia raggiungerà il suo apice con Untitled Blood. L’artista cubano crea una tenda alta più di tre metri, composta da lunghi fili di perline rosse che a scadenza regolare si alternano a un singolo filo bianco. Il rapporto matematico di questa alternanza è il medesimo che sussiste tra i globuli rossi e quelli bianchi di un malato di AIDS. La tenda è posta all’inizio dell’esposizione, e lo spettatore è costretto a valicarla, a sentire il peso di quelle perle leggere sul viso e sulle spalle. È una soglia, l’ingresso in una dimensione corporale e medica, la metafora di un sangue malato che nelle esposizioni viene attraversata e smanacciata da bambini divertiti, che si rincorrono annodandosi in quei fili.

Si parla di “arte relazionale” perché queste opere dipendono dalla partecipazione diretta dello spettatore: sono opere che si attivano attraverso il tocco, il passo; sono installazioni da rubare, da masticare e da inghiottire. È la semplicità di un’arte che è viva e attiva tanto per l’artista quanto per chi la osserva. I Greci usavano il teatro tragico come uno strumento che permetteva la catarsi, l’esternazione collettiva delle angosce, delle ossessioni, dei vizi individuali che, venendo rivissute attraverso storie di altri, lasciavano l’animo libero, purificato dalle paure. Torres, allo stesso modo, usa le caramelle e le tende di perline, potenziando il proprio dolore e rendendolo collettivo. Al centro di tutto il suo amore, e la necessità di elaborare una perdita, l’ingiustizia di un’infezione incurabile, trasmessa, per paradosso, proprio da un atto d’amore:
«L’amore ti dà una ragione di vita, ma è anche un motivo di panico, si ha sempre paura di perdere quell’amore. […] Freud ha detto che mettiamo in scena le nostre paure per diminuirle. In un certo senso questa generosità – il rifiuto di una forma statica, della scultura monolitica, a vantaggio di una forma fragile, instabile – era un modo per mettere in scena la mia paura di perdere Ross, che scompariva a poco a poco davanti ai miei occhi».
L’infezione da HIV, mentre Torres diceva queste parole, equivaleva a una condanna a morte. Il perbenismo godeva nel veder falcidiare tossici e omosessuali da questa malattia che era considerata alla stregua di una punizione divina. Torres poneva davanti a sé il proprio dolore, lo esprimeva lasciandosi andare tra le sue spire, dialogandoci, ossessionandosi con esso: l’artista Torres si fermava a dialogare con i fantasmi di una casa infestata, con quella malattia che contaminava un corpo, la sua vita e il suo amore. L’elaborazione del dolore si contrappone alla rimozione: l’artista danza con il fantasma, l’ironista lo scaccia, rifugiandosi in un cerchio protettivo, in una risata apotropaica che umilia lo spettro. La speranza dell’ironista è che la formula magica «ridiculus!» faccia apparire un cappellino di seta e un paio di giarrettiere all’orrore. Ma, purtroppo, molte volte, la morte sa essere molto più ironica di qualsiasi uomo.
Molti artisti hanno chiesto all’AIDS un ultimo ballo, prima di sparire con essa. Gli artisti di oggi saranno capaci di fermarsi a ragionare sull’aspetto tragico di quello che sta avvenendo, saranno capaci di potenziare le emozioni e i significati di questa pandemia, o lasceranno campo libero alla rimozione, all’ironia, al gioco che dimentica il dolore? Potrà il coronavirus diventare arte, oppure una risata ci seppellirà tutti? Chiedetelo a Toto Codogno.