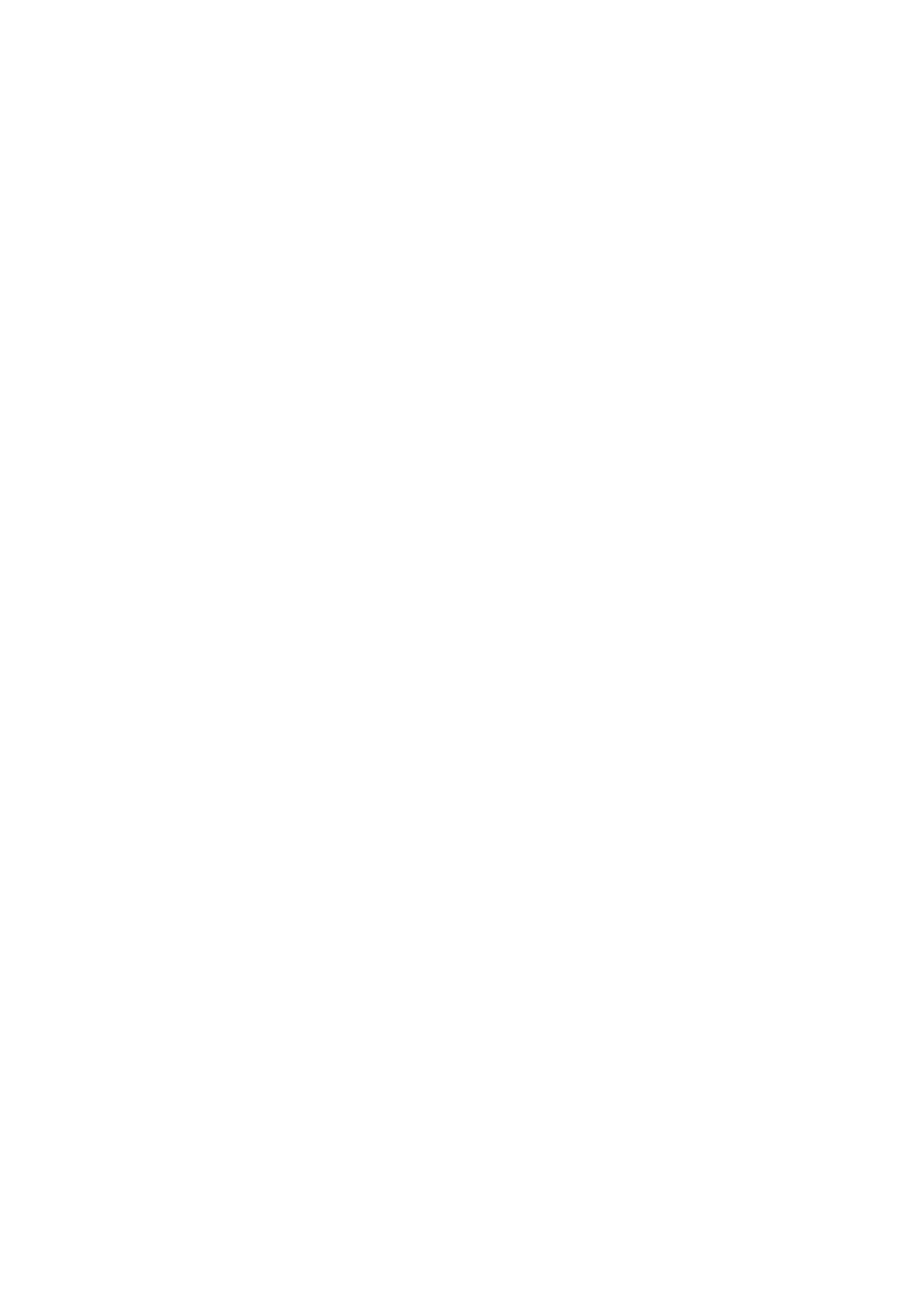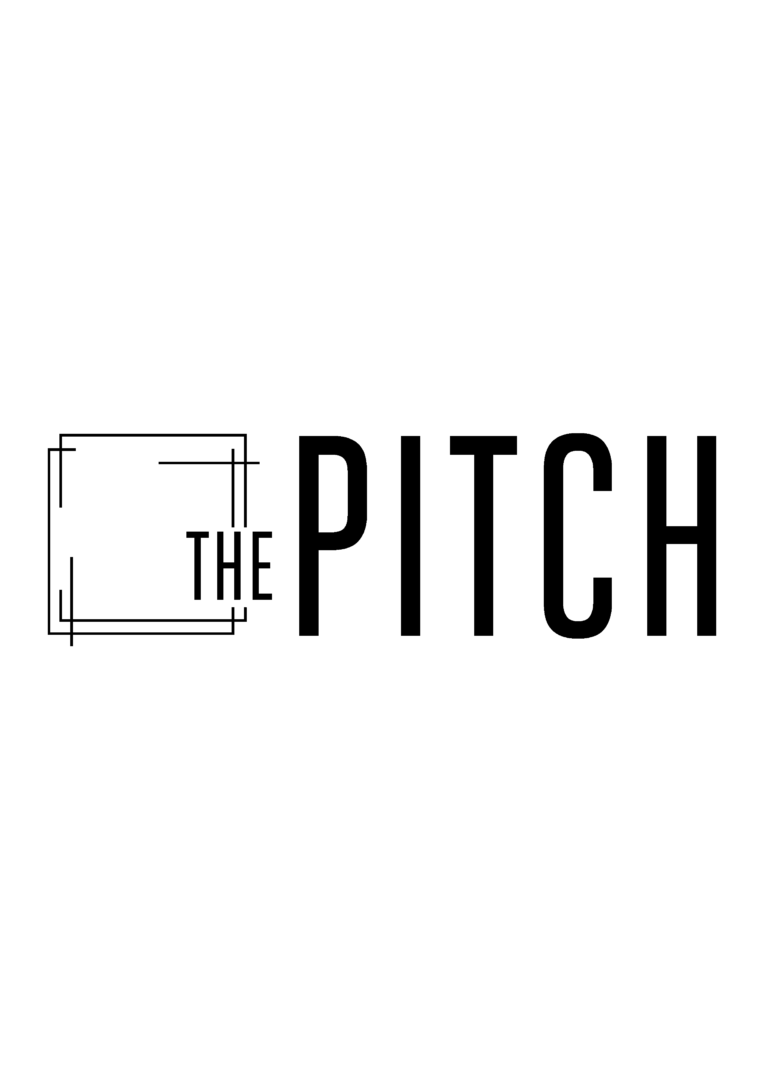Israele tra crisi e normalizzazione
Da diverse settimane le principali città dello stato di Israele sono attraversate da manifestazioni di protesta che hanno come bersaglio principale la figura di Benjamin Netanyahu, il premier più longevo nella giovane storia del paese. I motivi della protesta sono in primo luogo riconducibili alla cattiva gestione del governo israeliano dell’emergenza coronavirus: le autorità sono sotto accusa per la prematura riapertura delle attività economiche e delle scuole, che ha causato un aumento dei casi e un peggioramento delle condizioni sanitarie nel paese. Israele ha da poco superato la Cina come numero totale di casi: oltre 95.000 con 692 decessi.

I manifestanti, tra le altre cose, hanno esibito striscioni e scandito slogan facendo riferimento alle accuse di corruzione e frode per le quali il premier israeliano è tuttora sotto processo. A differenza di quanto accaduto in passato, le proteste hanno portato in piazza gruppi di persone di estrazione sociale e politica eterogenea che hanno dato vita ad un movimento che accusa Netanyahu di aver sfruttato strumentalmente l’emergenza Covid per tornare al potere e, una volta raggiunto l’obiettivo di formare un nuovo governo, di aver fatto ripartire troppo in fretta l’economia e aver accantonato irresponsabilmente le necessarie misure di contenimento della pandemia.
In difesa del premier sono scese in piazza le frange più estreme dei supporter del Beitar Gerusalemme, note come “La Familia”. La Familia, oltre ad essere un gruppo di tifosi che sostiene il Beitar, è un’organizzazione di estrema destra nota da anni per il proprio razzismo e per l’intolleranza verso gli arabi, e che si rifa al movimento sionista revisionista. In passato, l’acquisto da parte della società di due giocatori ceceni (e quindi musulmani) aveva portato ad una dura reazione da parte della Familia, la cui intransigenza aveva scatenato una campagna di odio e razzismo.

Fonte DW
La squadra del Beitar, di cui Netanyahu è tifoso, è indissolubilmente legata alla destra estrema e al revisionismo sionista di Vladimir Žabotinskij, poi confluito nel movimento Herut, che viene a sua volta considerato una delle principali componenti politiche alla base della nascita, nel 1973, del Likud, partito del premier che domina la scena politica israeliana da diversi anni.
Molti dei manifestanti scesi in piazza per protestare contro le politiche del governo hanno denunciato di essere stati aggrediti dai membri della Familia, che hanno tra l’altro attaccato e minacciato i giornalisti presenti sul campo.
Le proteste e l’escalation di violenza si inseriscono in un periodo particolare per la storia e la politica israeliana: il governo insediatosi a maggio grazie all’imprevedibile e fragile alleanza tra il Likud di Benjamin Netanyahu e Kahol Lavan (Blue e Bianco) di Benny Gantz, infatti, ha posto fine ad un periodo di altissima instabilità e incertezza che aveva portato alle urne i cittadini israeliani per 3 volte in meno di un anno (aprile e settembre 2019 e marzo 2020). L’accordo di governo, tra l’altro, prevede l’alternanza dei leader dei due partiti nel ruolo di primo ministro. Prima delle elezioni le posizioni tra i due partiti erano decisamente distanti: Gantz ha impostato la propria campagna elettorale proponendosi come alternativa a Netanyahu e accusando il premier di corruzione, ed è abbastanza evidente che l’alleanza tra i due è stata resa possibile unicamente dalla necessità di avere un governo stabile per affrontare la pandemia.
Prima dello scoppio delle proteste e del riacutizzarsi dell’emergenza Covid, il tema più scottante in Israele e nella regione era relativo allo status dei territori occupati in Cisgiordania. In ognuna delle ultime campagne elettorali, Netanyahu ha ribadito varie volte la propria volontà di procedere all’annessione di nuovi territori. Inizialmente le attenzioni del premier israeliano si limitavano alla Valle del Giordano. In un secondo momento, Bibi ha puntato sull’inclusione di tutti gli insediamenti della Cisgiordania, in conformità con il piano di Trump per il Medio Oriente reso noto alla fine di gennaio.
Le nuove mire espansionistiche di Israele hanno portato a secche reazioni da parte di gran parte della comunità internazionale. Il re giordano Abdullah ha apertamente parlato del rischio di un conflitto armato in caso di annessione. Il trattato di pace tra Giordania e Israele risale al luglio del 1994, quando il premier israeliano Rabin e il monarca hashemita Hussein misero fine alla storica ostilità tra i due stati. Da allora i due paesi intrattengono soprattutto buoni rapporti economici, con un’ampia fornitura di gas garantita da Israele al paese confinante.
Negli ultimi anni, Israele intrattiene buone e proficue relazioni con l’Egitto di Al Sisi, l’altro stato della regione con cui lo stato sionista ha concluso un trattato di pace (nel 1979, sotto la presidenza egiziana di Sadat). I rapporti tra i due paesi si basano sul comune interesse al contenimento della minaccia jihadista nel Sinai (e indirettamente a Gaza) e sui comuni interessi energetici alla luce delle recenti scoperte di nuovi giacimenti di gas nel mediterraneo orientale. L’annessione dei territori in Cisgiordania potrebbe complicare i rapporti tra i due paesi e rompere il fragile equilibrio di uno dei pochi scenari di stabilità presenti nella regione.

All’elenco dei paesi arabi che hanno concluso un accordo di pace con Israele si sono aggiunti proprio nelle ultime ore gli Emirati Arabi Uniti: la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra i due stati, che riguarda le materie di turismo, commercio, tecnologia e sicurezza e che è avvenuta grazie alla mediazione offerta dagli Stati Uniti di Donald Trump, rappresenta il coronamento di un processo avviato anni fa che ha portato disgelo nelle relazioni tra lo stato sionista e le monarchie del golfo. L’accordo va inteso come un ulteriore tentativo di rafforzare l’asse anti-iraniano nella regione, e rappresenta inoltre la dimostrazione dell’intesa privilegiata che si è consolidata negli anni tra il presidente americano e il principe ereditario Mohammed bin Zayed. La sensazione è che la normalizzazione delle relazioni tra i due paesi possa generare un effetto domino nella regione e che in futuro prossimo anche le altre monarchie del golfo possano seguire l’esempio degli Emirati. Lo stesso Jared Kushner ha definito “inevitabile” una futura normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabi Saudita.
L’accordo tra i due paesi, giunto in maniera del tutto inaspettata, rappresenta anche un messaggio alla Turchia di Erdoğan, le cui relazioni con gli Emirati Arabi Uniti sono ai minimi termini per via dell’impegno su fronti opposti in Libia. Se da parte israeliana il rafforzamento dell’asse anti-iraniano rappresenta una priorità assoluta, nell’agenda politica della piccola monarchia del golfo il contenimento delle ambizioni di Ankara nel mediterraneo orientale e dell’Islam politico nella regione sono punti imprescindibili. Un’intesa, dunque, che giova ad entrambe le parti e che si concretizza a pochi mesi dalle elezioni americane, che potrebbero portare ad un avvicendamento alla Casa Bianca e quindi ad una situazione diplomatica ben diversa.
Tra le altre cose, l’accordo prevede la sospensione dei piani di annessione dei territori occupati in Cisgiordania. Al momentaneo abbandono delle mire espansionistiche dovrebbe fare seguito, secondo Donald Trump, una fase di apertura diplomatica verso i paesi arabi della regione.
Il dato di fatto che emerge dall’accordo è l’ormai totale accantonamento della questione palestinese dalle agende politiche dei paesi della regione. La decisione di mettere in stand-by l’annessione, per dare la priorità alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche con alcune delle maggiori potenze della regione, consente ora ad Israele di agire “alla luce del sole” e di scongiurare almeno parzialmente le possibili reazioni a livello internazionale ad una modifica dello status quo in Cisgiordania. Gli equilibri geopolitici, evidentemente, stanno prevalendo sulle considerazioni relative al rispetto dei diritti umani, l’autodeterminazione e il diritto alla terra.
Le varie fazioni palestinesi hanno stilato un comunicato congiunto respingendo in toto l’intesa tra Israele e Emirati. Secondo i palestinesi, la normalizzazione delle relazioni rappresenta l’accettazione de facto, da parte dei paesi arabi delle modifiche dello status dei territori in Cisgiordania. Già nei mesi più caldi del lockdown l’autorità palestinese aveva rifiutato gli aiuti umanitari provenienti dal piccolo stato del Golfo, interpretandoli come un tentativo di dare legittimità ad una più stretta collaborazione con Israele. Sia Iran che Turchia, chiaramente, hanno da parte loro condannato energicamente il l’avvicinamento tra i due paesi accusando gli Emirati, rispettivamente, di “stupidità strategica” e di “comportamento ipocrita”. Ankara è arrivata a minacciare il ritiro del proprio ambasciatore e la chiusura delle relazioni diplomatiche con Abu Dhabi .

L’accordo rappresenta senza dubbio un grosso successo diplomatico per Donald Trump, che ha condotto in prima persona la telefonata con i capi di stato dei due paesi coinvolti e che può presentarsi in campagna elettorale come “stabilizzatore” delle relazioni diplomatiche mediorientali. Sul fronte interno, il ministro degli esteri emiratino ha cercato di presentare l’accordo come una sconfitta per Israele, costretta per il momento a mettere da parte le velleità di annessione. La normalizzazione delle relazioni con Israele viene quindi fatta passare come una mossa tattica volta a contrastare l’espansionismo territoriale dello stato sionista. Netanyahu ha però negato di voler cambiare i propri piani, nonostante i termini dell’accordo prevedano chiaramente la sospensione di ogni progetto di ampliamento territoriale. E’ evidente come il vincitore assoluto sia proprio il premier israeliano, che ha saputo intavolare un negoziato mettendo sul tavolo la sospensione di un’annessione che difficilmente si sarebbe conclusa in tempi brevi anche senza i termini dell’accordo appena concluso con gli Emirati Arabi Uniti. La minaccia di espansione territoriale, dunque, è stata utilizzata strumentalmente da Bibi Netanyahu per giungere ad un importante successo diplomatico, senza che in questo momento ci fossero le condizioni a livello internazionale e domestico per procedere effettivamente con l’annessione.
La mossa, oltre a rappresentare una violazione del diritto internazionale, avrebbe enormi ripercussioni sul piano interno, con la plausibile prospettiva di un’enorme sollevazione popolare che, secondo molti, potrebbe ricordare sia nei metodi che nelle proporzioni la Seconda Intifada che ha scosso il paese nei primi anni 2000.
L’annessione, che in base al piano “Vision for Peace” di Trump interesserebbe circa il 30% della totalità della Cisgiordania, sancirebbe la conversione dei territori occupati da Israele dopo la guerra dei 6 giorni del 1967 in parte integrante dello Stato sionista. Come avvenuto con le alture del Golan contese con la Siria, dunque, Netanyahu starebbe cercando di sfruttare a proprio vantaggio la copertura garantita dall’amministrazione Trump per procedere ad una modifica dello status quo.
Se applicato il piano di Trump renderebbe impossibile la creazione di uno stato Palestinese, dando vita a piccole comunità senza continuità territoriale e circondate da checkpoint. Si è diffusamente parlato di apartheid per descrivere il trattamento che verrebbe riservato ai palestinesi, scenario che diverrebbe tragicamente reale in caso di un’effettiva annessione. Uno dei temi più scottanti è quello della cittadinanza. Il rischio è che una modifica dello status quo determini, inoltre, un’ulteriore diminuzione della possibilità di movimento dei palestinesi abitanti in Cisgiordania.
Sul piano interno negli ultimi giorni la maggioranza di governo è sembrata sull’orlo del collasso per le nette divergenze tra i due partiti di governo a due settimane dalla scadenza per l’approvazione del budget di Stato. Per l’ottava settimana consecutiva gli israeliani sono scesi in piazza, radunandosi a migliaia di fronte alla residenza del premier a Gerusalemme per chiederne le dimissioni. Netanyahu, che non ha tardato a dichiarare l’estraneità di Israele dalla catastrofica esplosione di Beirut e che sperava di placare gli animi della piazza con lo storico accordo con gli Emirati, è addirittura sembrato sul punto di spingere per avere nuove elezioni, previste dalla legge se non si dovesse trovare un accordo tra le parti. Le divergenze in materia economica (riguardanti in particolare la durata del bilancio) rischiano di essere la cartina tornasole della fragilità di accordo di governo. La prospettiva di nuove elezioni, chiaramente, spaventa molti dato il momento di forte instabilità economica e la crisi sanitaria. L’unico a poter spingere il paese alle urne è proprio Bibi, che a novembre 2021 sarebbe costretto a cedere il potere all’attuale ministro della difesa; opponendosi alla redazione del budget biennale prevista dagli accordi di governo, l’attuale premier potrebbe forzare la situazione e sfruttare la legge che prevede elezioni anticipate in caso di mancato accordo sul bilancio. Se ciò dovesse accadere, si tratterebbe dell’ennesimo colpo di scena e numero ad effetto della carriera politica dell’uomo che da anni guida la scena politica in Israele.

Da giorni, nel frattempo, sono ripresi i bombardamenti dell’aviazione israeliana sulla Striscia di Gaza, come risposta al lancio di palloncini incendiari dall’enclave palestinese che hanno causato una serie di incendi senza vittime sul suolo israeliano. La stessa Hamas ha effettuato un lancio di razzi verso il mare: lo scopo è mandare un segnale alle autorità israeliana riguardo alla necessità di aumentare il flusso di aiuti umanitari verso Gaza. Come reazione, Israele ha chiuso il valico di Kerem Shalom che regola l’afflusso delle merci verso Gaza, limitando il passaggio di cibo e carburante. Il presidente egiziano Al Sisi si è così trovato costretto ad aprire a sua volta per tre giorni il valico di Rafah, chiuso da Aprile e che collega Gaza all’Egitto, nonostante i rapporti non certo buoni tra la leadership egiziana e Hamas.
Lo stesso Qatar, tra i principali sostenitori di Hamas, ha dichiarato apertamente di aver incontrato delle difficoltà nel recapitare gli aiuti umanitari a Gaza. Nonostante la forte instabilità politica, le proteste interne, le difficoltà economiche e l’emergenza sanitaria Israele non sembra aver cambiato atteggiamento nei confronti di Gaza: il recente bombardamento di una scuola di UNRWA da parte dell’aviazione è solo l’ennesima conferma. Le priorità, al momento, sembrano essere altre, ma è fondamentale che la ricerca di una soluzione accettabile per tutti torni ad essere un punto cardine dell’agenda politica della comunità internazionale e in particolare dell’Unione Europea. Piani di Trump e delle monarchie del Golfo permettendo.