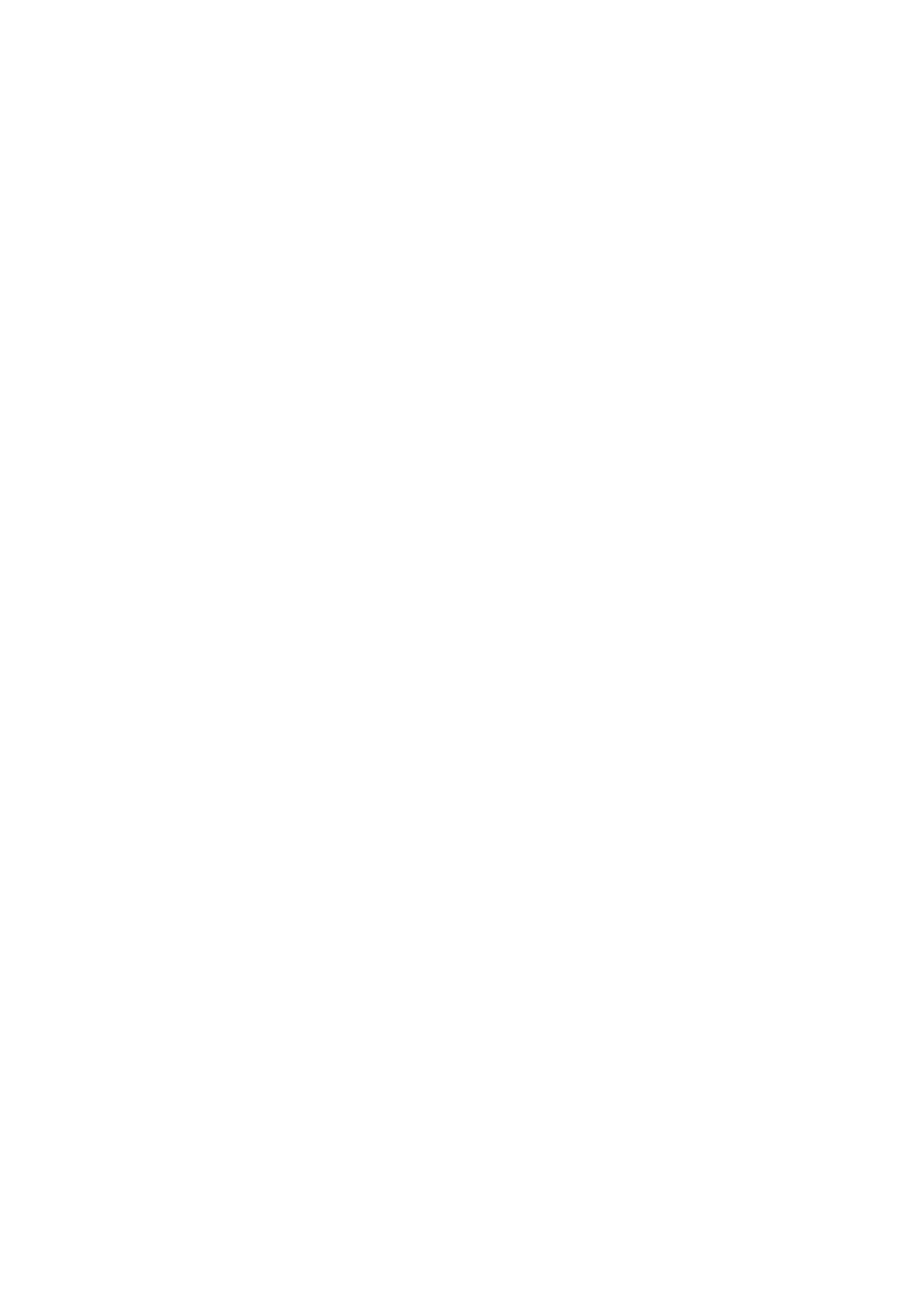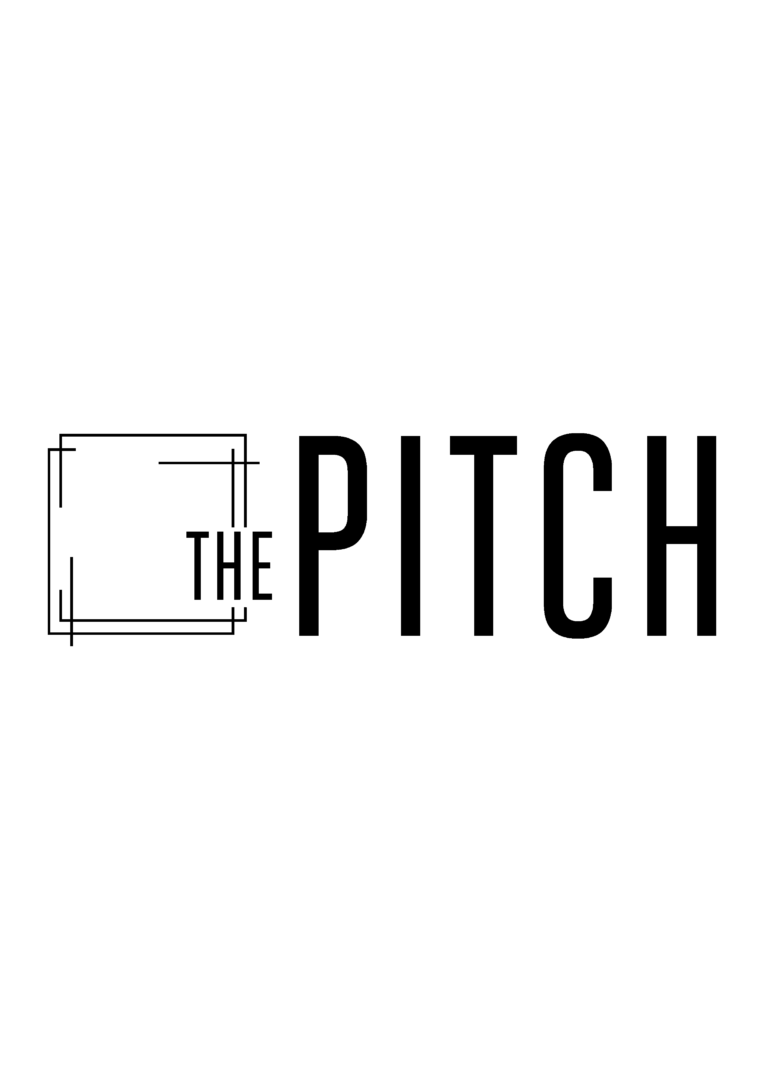La rotta balcanica e le politiche dell’UE
Con un’ordinanza dello scorso 18 gennaio il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimi i respingimenti di migranti al confine con la Slovenia in quanto contrari agli obblighi costituzionali e al diritto internazionale. Secondo la corte, la decisione del Ministero dell’Interno di non aprire le proprie frontiere ha esposto i migranti a “trattamenti inumani e degradanti” e alle torture perpetrate dalle forze dell’ordine croate.
Il tribunale si è espresso in seguito al ricorso presentato, attraverso avvocati italiani, da un cittadino pakistano che dopo aver raggiunto Trieste nel luglio del 2020 è stato intercettato dalla polizia italiana e riportato alla frontiera per essere schedato e rilasciato in territorio sloveno. Il respingimento, avvenuto in territorio italiano, ha innescato un effetto a catena che ha portato il cittadino pakistano a vivere in condizioni degradanti a Sarajevo, in Bosnia, a causa del congestionamento del campo di Lipa.

Da qualche anno a questa parte, la regione dei Balcani rappresenta uno dei principali canali di ingresso in Europa per i migranti. Una delle caratteristiche della rotta balcanica è data dalla peculiarità del percorso da seguire: nel corso del loro viaggio, infatti, i migranti si trovano in un primo momento ad entrare nell’Unione Europea (in Grecia e Bulgaria) per poi uscire dall’Unione stessa per attraversare paesi come Bosnia e Serbia. Infine, una volta giunti al confine con la Croazia, gli stessi migranti tentano per la seconda volta di entrare in un paese dell’area UE. E’ bene sottolineare, inoltre, che tra i paesi dell’area solamente Slovenia e Grecia sono parte dello Spazio Schengen.
Il trattamento dei migranti e l’approccio con cui si è deciso di gestire il flusso di persone sulla rotta balcanica hanno subito negli anni un’evoluzione che è segnata da una serie di date spartiacque. Nel novembre del 2015, un paio di mesi dopo che la morte di Alan Kurdi scuotesse le coscienze dei cittadini europei, la Macedonia del Nord ha chiuso l’accesso dal confine meridionale con la Grecia a chiunque non fosse siriano, afghano, o iracheno. Di lì a poco è sorto, sul versante greco del confine con la Macedonia del Nord, il campo di Idomeni, diventato uno dei simboli del fallimento delle politiche europee nella gestione dei flussi migratori.

Nel marzo del 2016, poi, l’accordo tra Unione Europea e Turchia ha cambiato completamente lo scenario e ha lasciato decine di migliaia di persone bloccate nei paesi Balcani nel tentativo di raggiungere l’Europa continentale. L’accordo, che presenta una serie di criticità tra cui la possibilità di espulsioni collettive e la violazione del principio cardine di non-refoulement, costituisce un tentativo di esternalizzare le frontiere dell’UE. Il meccanismo alla base dell’accordo comporta che per ogni migrante siriano riammesso in Turchia un altro siriano sarà reinsediato in Europa. Una logica di “uno per uno” che, oltre a dettare una chiara discriminazione sulla base della nazionalità, non tiene conto delle specifiche vulnerabilità degli individui. Il riconoscimento della Turchia come paese terzo sicuro, inoltre, solleva chiaramente ben più di una perplessità.
Nel 2017 la costruzione del “muro” tra Serbia e Ungheria, fortemente voluto da Viktor Orban, ha ulteriormente complicato la situazione per i migranti. L’intransigenza dei paesi del blocco di Visegrad, guidati dallo stesso Orban, ha creato uno scenario all’interno del quale la possibilità di accedere all’Unione Europea attraverso una via legalizzata è pressoché nulla. Uno degli effetti dell’intransigenza, oltre allo spostamento verso ovest della rotta balcanica, è la sempre più diffusa tendenza a sottrarsi alle procedure istituzionali e a tentare il cosiddetto “game”, cioè l’attraversamento della frontiera attraverso le foreste di confine che spesso espone i migranti ai pestaggi e alle violenze della polizia.
Sono sempre più numerose le testimonianze degli abusi e dei trattamenti degradanti nei confronti dei migranti, e in questo scenario di maltrattamenti le forze dell’ordine croate vengono indicate come le più violente e aggressive. A questo proposito, la Commissione Europea ha aperto un’inchiesta, nello scorso novembre, per fare chiarezza sulla brutalità dei respingimenti effettuati dalla polizia croata e sull’utilizzo dei fondi europei per la gestione dell’emergenza migratoria da parte di un paese che ambisce a entrare nell’area Schengen. Decisivo, in tal senso, è stato ancora una volta il ruolo di Amnesty International, che per anni ha raccolto e documentato le numerose violazioni della autorità di frontiera. Il Danish Refugee Council, inoltre, ha pubblicato attraverso il Guardianun reportage sui respingimenti illegali effettuati in Croazia tra il 2019 e il 2020.

La nuova rotta balcanica, inaugurata nel 2018 in seguito alla chiusura della frontiera ungherese, prevede che i migranti passino in un primo momento dalla città di Sarajevo, dove registrarsi come richiedenti asilo, per poi procedere principalmente verso le città di Bihać e Velika Kladuša. La Bosnia, paese ancora indebolito dal conflitto degli anni ’90 e frammentato in una divisione amministrativa tripartita, non è in grado di affrontare un’emergenza umanitaria di grossa portata come quella che si è configurata negli ultimi anni. L’impegno bosniaco nei negoziati per la pre-adesione all’Unione Europea ha garantito al paese una serie di fondi finalizzati al miglioramento della strategia in materia di migrazioni, ma in un contesto di fragilità istituzionale e di corruzione diffusa una delle poche soluzioni a disposizioni della Bosnia è stata rimettersi al lavoro dell’IOM (Organizzazione internazionale per le migrazioni).
Il lavoro dell’IOM in Bosnia si è concretizzato soprattutto nella creazione di Centri di accoglienza temporanea, come quello di Lipa, a pochi km dalla città di Bihac, aperto nel 2020 nel corso dell’emergenza Covid. Parallelamente, l’azione delle autorità locali di fronte all’aumento del numero dei migranti ha portato alla creazione di luoghi dell’orrore come il jungle camp di Vučjak, costruito dove una volta sorgeva una discarica e all’interno del quale sono state ammassate oltre mille persone i condizioni disumane.
L’apertura dei nuovi centri ha contribuito, tra le altre cose, a creare un clima di intolleranza e esasperazione nella popolazione locale, e la gestione della situazione in base al sistema hotspot ha ancora una volta fatto emergere uno squilibrio tra la portata economica degli investimenti (in gran parte provenienti dai fondi UE stanziati per la pre-adesione della Bosnia) e i risultati ottenuti in termini di reale soluzione e normalizzazione dell’emergenza.

L’approccio hotspot, inaugurato nel 2015 dalla Commissione Europea nella sua Agenda per la migrazione, si basa sul ricorso a centri di identificazione, screening e prima assistenza. All’adozione di questa nuova strategia non ha fatto seguito il ricorso a adeguate normative per l’allestimento delle strutture hotspot, e già negli scorsi anni la stessa Amnesty International aveva denunciato il legame tra la nuova strategia e l’aumento delle violazioni dei diritti umani nei confronti di rifugiati e migranti.
L’arrivo del Covid e delle misure di contenimento della pandemia adottate dalla Bosnia hanno causato un ulteriore peggioramento di una situazione umanitaria già al limite. La decisione di aprire il campo di Lipa, sotto la gestione dell’IOM, è stata presa proprio nel contesto della crisi sanitaria legata al Covid, nel corso della quale il numero delle persone costrette a vivere all’aperto fuori dai campi era aumentato vertiginosamente e era emersa ancora una volta l’inadeguatezza delle strutture di accoglienza bosniache. Negli ultimi mesi la situazione è precipitata: alla chiusura del campo di Bira, a causa delle proteste di associazioni locali contrarie ad ogni forma di accoglienza, ha fatto seguito il trasferimento di centinaia di migranti verso il campo di Lipa, già sovraffollato e inadatto ad accogliere un numero così alto di persone.

Il peggio si è raggiunto a fine dicembre 2020 quando, nel corso dell’evacuazione di Lipa decisa dall’IOM per la totale inadeguatezza della struttura in cui mancavano acqua e elettricità, i tendoni con i letti hanno preso fuoco radendo completamento al suolo il campo. Da allora centinaia di migranti non hanno un luogo in cui andare, e sono lasciati a sé stessi nel bel mezzo dell’inverno senza che da parte delle autorità bosniache ci sia la reale intenzione (né la capacità) di trovare una soluzione accettabile alla situazione. L’esercito bosniaco ha montato delle tende improvvisate, ma dopo il rogo di Lipa la situazione dei migranti è chiaramente fuori controllo.
A fine gennaio una delegazione di eurodeputati italiani ha visitato di persona il confine tra Bosnia e Croazia. Dopo essere stati inizialmente bloccati al confine dalla polizia croata, i parlamentari europei sono riusciti a parlare con l’IOM e con le altre ONG attive sul campo. La speranza è che l’attivismo dei singoli possa riportare l’attenzione dell’Europa sulla situazione dei migranti e che si possa trovare un modo per condividere la responsabilità dell’accoglienza. In questo momento l’attenzione dei governi è anche comprensibilmente rivolta alla crisi sanitaria e alle difficoltà di gran parte dei comparti economici. Non è pero accettabile che l’Europa si trasformi in una fortezza invalicabile e che i migranti vengano dimenticati e lasciati a sopravvivere in condizioni disumane in violazione delle più basilari norme del diritto internazionale.