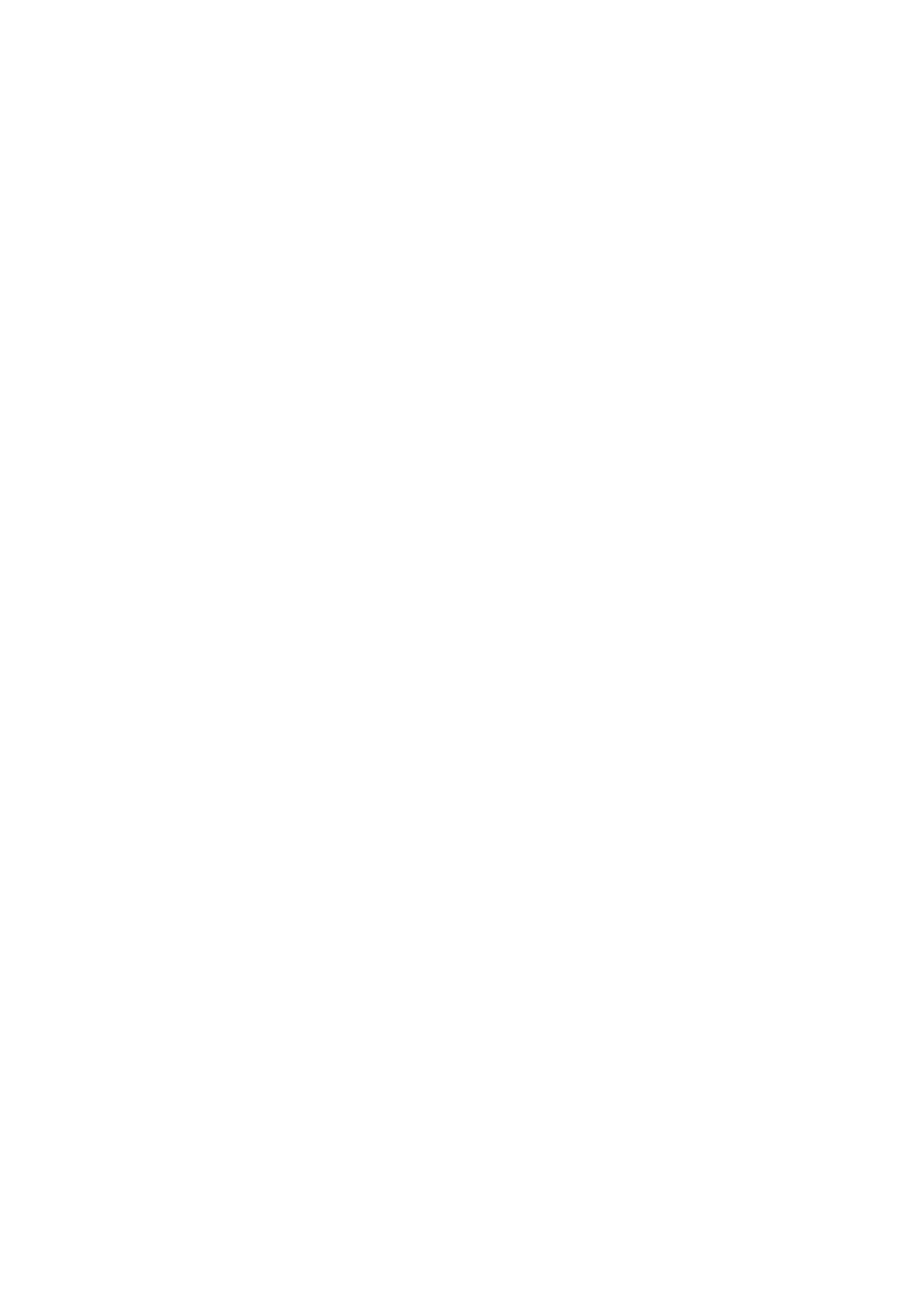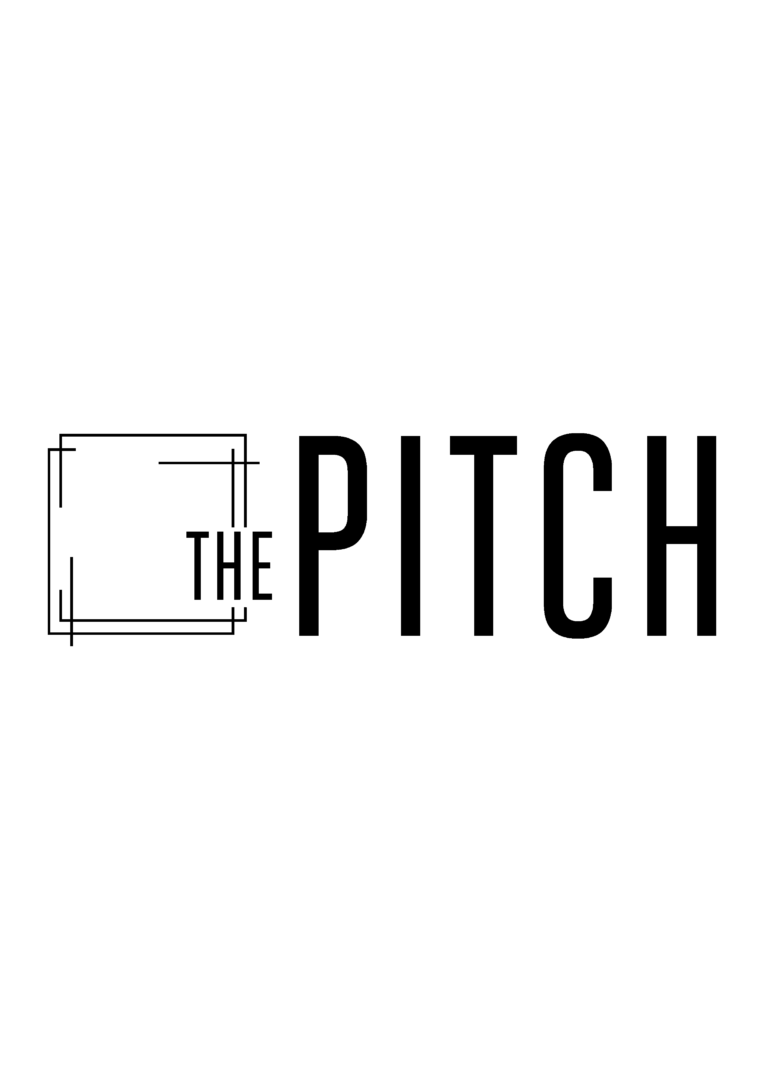L’Argentina alle urne mentre il Sudamerica brucia
Pobreza zero. “Povertà zero”: con questa due semplici parole quattro anni fa il liberista Mauricio Macri era riuscito a fare breccia nel cuore degli elettori dei ceti medio-bassi, storicamente sensibili al fascino del peronismo, e a riportare i conservatori alla guida del Paese per la prima volta dai tempi del default del 2001. Allora il 29% degli argentini viveva sotto la soglia di povertà e, dopo 12 anni di dominio incontrastato della famiglia Kirchner (ai quattro di Néstor erano seguiti gli otto della moglie Cristina Fernández), la promessa dell’ex presidente del Boca Juniors, unita all’impegno di rivitalizzare l’economia, aprendola nuovamente al commercio internazionale, aveva colto nel segno: con quasi 700 mila voti di vantaggio sul candidato kirchnerista Daniel Scioli, il 56enne imprenditore di origini calabresi era riuscito a ribaltare al ballottaggio il risultato del primo turno.
Sono passati 1.400 giorni e la povertà è lungi dall’esser stata azzerata: l’Argentina chiamata oggi alle urne è un paese in cui il 35,5% della popolazione non riesce a sopravvivere con le proprie risorse. Un numero destinato a salire al 37% entro fine anno, stando ai dati dell’Osservatorio per il debito sociale dell’Università cattolica di Buenos Aires. È in questo contesto che sono tornati utili molti degli ammortizzatori sociali messi in campo nell’era Kirchner, dai sussidi per i disoccupati agli strumenti di sostegno alla genitorialità, dai prezzi calmierati degli affitti fino ai comedores populares, le mense sociali che il governo Macri si è visto costretto a potenziare lo scorso maggio con un’apposita legge per porre argine alla vera e propria emergenza alimentare che affligge molti sobborghi di un Paese in cui un terzo della popolazione vive nell’area della capitale.

L’attuale presidente, candidato di Propuesta Republicana ma alla guida del cartello elettorale “Juntos por el cambio” (riedizione del “Cambiemos” che gli ha portato fortuna nel 2015), rischia di pagare a caro prezzo il conto della recessione che da un anno e mezzo ha colpito l’Argentina. Colpa dei «conti pubblici disastrosi» lasciati in eredità dai Kirchner, accusa Macri, che però i sondaggi continuano a dare staccato di ben 20 punti dal candidato del Partido Justicialista Alberto Fernández. Che dal canto suo, se riuscisse a confermare il 48% delle primarie – che in Argentina sono obbligatorie e costituiscono una sorta di antipasto delle elezioni – dell’11 agosto, potrebbe anche essere eletto al primo turno, dove è necessario il 45% dei consensi ma basta il 40 se i punti di vantaggio sul secondo sono più di 10. Nessuna chance per gli altri candidati: insieme non superano il 15% nei sondaggi.
Sotto la macro-etichetta di peronismo ricadono tutte le esperienze politiche, di destra come di sinistra, che si rifanno al Partido Justicialista di Juan Domingo Perón, presidente dell’Argentina dal 1946 al ’55 e poi nuovamente tra il 1973 e il ’74. Difficile trovare tratti comuni in un movimento così sincretico, spesso troppo frettolosamente relegato tra i populismi: punti fermi sono un patriottismo talvolta esasperato e un dirigismo economico d’ispirazione keynesiano-corporativista caratterizzato da una capillare macchina assistenziale. In politica estera si distingue per un generico rifiuto dell’influenza storica degli Stati Uniti sul continente.
L’eventuale ballottaggio è fissato per il 24 novembre ma per Macri raggiungerlo sarebbe già un traguardo. L’inflazione arrivata ormai a sfiorare il 60%, il debito estero cresciuto dell’80% durante il suo mandato e la necessità di chiedere un nuovo prestito da 57 miliardi all’Fmi rendono l’Argentina un Paese nuovamente a rischio default. Motivo per cui il favorito Fernández sta facendo di tutto per presentarsi come alternativa credibile e affidabile al liberismo macrista. Pur non essendo un kirchnerista ortodosso, il 60enne ex capo del Gabinetto dell’omonima Cristina sa che il peronismo non gode dei favori della comunità internazionale: una prova fin troppo evidente si è avuta il giorno dopo le primarie, quando il peso ha perso in poche il 35% del proprio valore. E, per un Washington Post che si scaglia contro «il ritorno del populismo», c’è tutto attorno un intero continente che brucia.

Dal Cile all’Ecuador, passando per Bolivia, Brasile e Perù e senza mai dimenticare la sempre delicatissima situazione venezuelana, alla fine dell’estate il Sudamerica si è risvegliato avvitato in una spirale di vibranti proteste sociali. Scioperi e marce pacifiche (da ultima quella monumentale di venerdì a Santiago del Cile), ma anche barricate e violenti scontri con le forze dell’ordine, non privi di momenti drammatici e di palesi violazioni dei diritti umani. I paragoni con le primavere arabe si sprecano ma che negli ultimi anni le «vene aperte dell’America Latina» di cui parlava quasi mezzo secolo fa Eduardo Galeano si siano ulteriormente divaricate appare sempre più chiaro: alle storiche tensioni socio-economiche, vecchie quanto il continente stesso, si sono aggiunte più di recente questioni cruciali per il futuro del pianeta come ambiente e immigrazione.
E se in Bolivia la causa scatenante sono stati i presunti brogli operati alle elezioni di domenica scorsa dal presidente uscente Evo Morales, al potere dal 2006, nel vicino Perù è in atto un braccio di ferro tra l’ormai ex presidente Martin Vizcarra e il potentissimo “clan” dei Fujimori, che si ripercuote in scontri di piazza tra le due fazioni contrapposte. In Brasile sono il futuro dell’Amazzonia e i raid della polizia nelle favelas (1.250 morti solo dall’inizio dell’anno, in gran parte giovani poveri e di colore) a causare tensioni e scontri, mentre a Quito le proteste di inizio ottobre contro la sospensione dei sussidi sulla benzina, in vigore da 40 anni, si sono presto trasformate in un’aspra critica alla politica del presidente Lenin Moreno che, dopo aver decretato lo stato di emergenza, si è visto costretto a ritirare il provvedimento di austerity caldeggiato dal Fondo monetario internazionale.

A suscitare le maggiori preoccupazioni in questo momento è però la situazione cilena. Da una decina di giorni il secondo paese più ricco del continente (dopo l’Uruguay) è messo a ferro e fuoco dai manifestanti. Le proteste, scatenate dall’aumento del prezzo dei biglietti della metropolitana di Santiago, si sono presto allargate a tutto il Paese e hanno via via esteso le richieste. Barriere nell’accesso a servizi sanitari e istruzione, un sistema pensionistico privato e diseguale, la corruzione dilagante e l’impunità delle forze dell’ordine i principali argomenti sollevati dalle centinaia di migliaia di persone scese in piazza nei giorni scorsi. Il controverso presidente Sebastián Piñera non ha esitato a imporre il coprifuoco e a dispiegare l’esercito nelle strade: 11 il bilancio provvisorio dei morti e centinaia i casi di presunti stupri e torture messi in atto dagli agenti.
Quella che per il presidente è una «guerra contro un nemico potente e implacabile che non rispetta nulla e nessuno» per i manifestanti costituisce un pericoloso richiamo alla terribile epoca della dittatura militare di Augusto Pinochet, durata dal 1973 al 1989. Due decenni, i Settanta e gli Ottanta, a cavallo dei quali anche altri paesi latino-americani sperimentarono feroci regimi di estrema destra: già allora, dall’Argentina dei colonnelli al Brasile dei Gorillas passando per l’Uruguay di Bordaberry e Méndez, il Sudamerica mostrò di muoversi spesso su sentieri politici paralleli. Omogeneità ribadita all’inizio del nuovo millennio con le vittorie a ripetizione di partiti e movimenti progressisti e di sinistra (da Lula ai Kirchner, da Chavez a Morales, dalla Bachelet a Correa) e riconfermata oggi dalle proteste che stanno scuotendo da nord a sud un continente che non ci sta più a essere “dimenticato”.