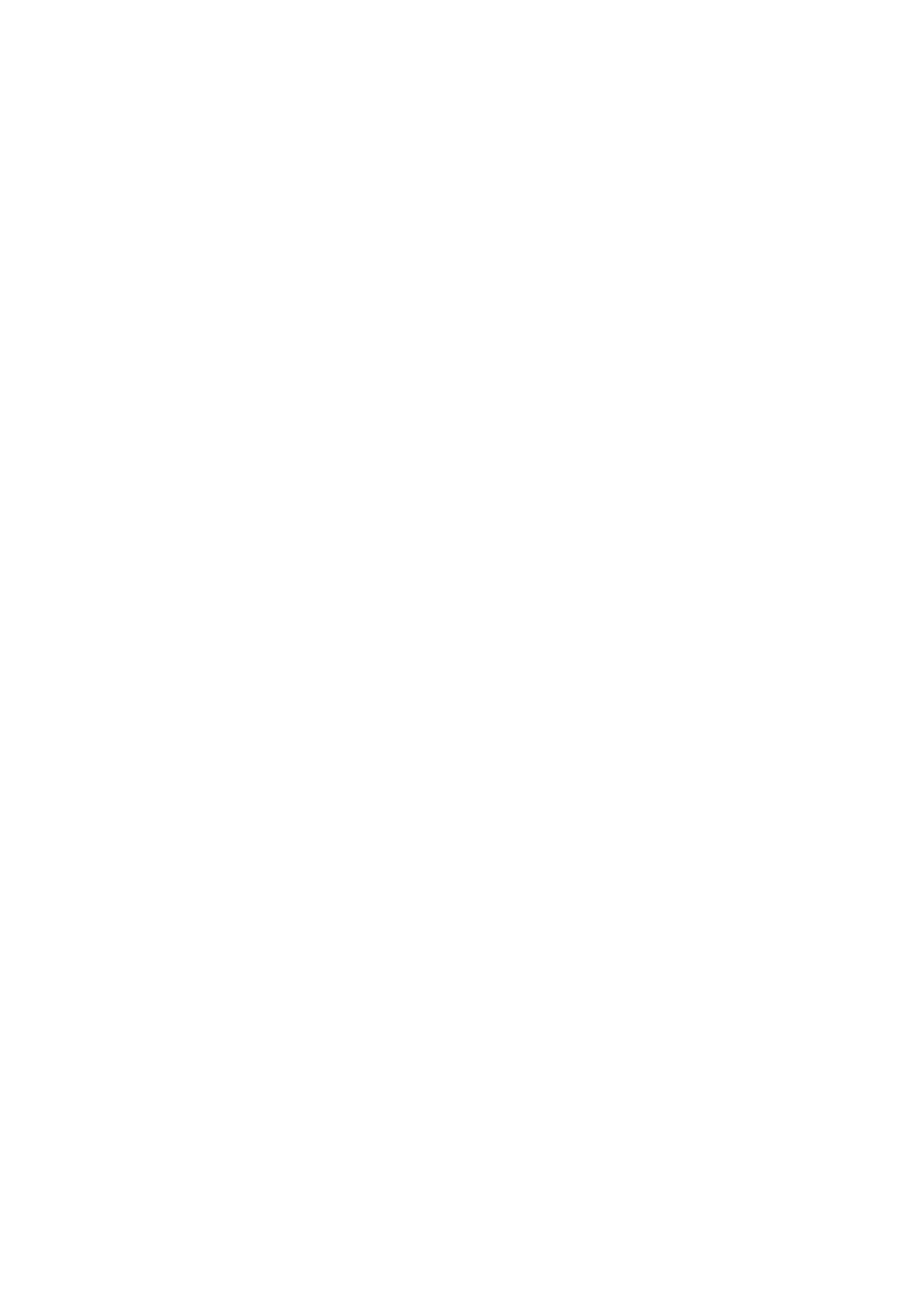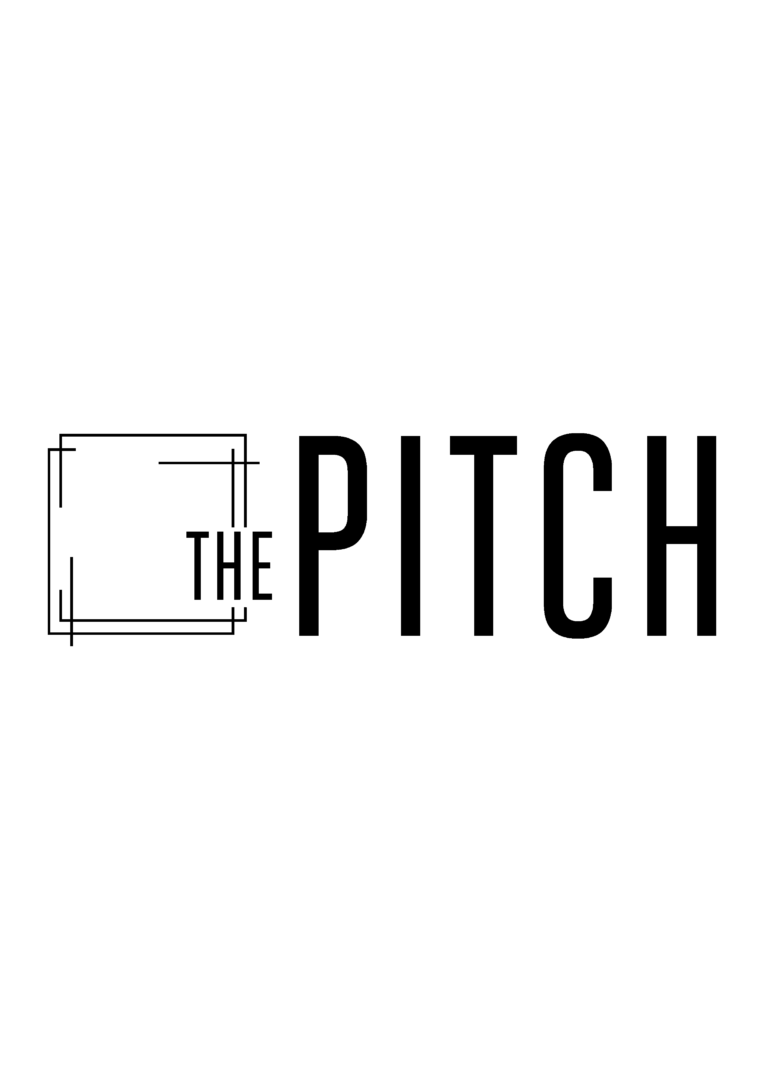L’età d’oro del cinema italiano
A cura di Giacomo Somazzi
Parte II: l’apice (1944-1960)
Nell’immediato dopoguerra il sistema produttivo italiano è, similmente al resto del paese, allo sbando: Cinecittà è occupata dai profughi, le uniche macchine da presa e i riflettori rimasti sono quelli che pochi cineasti sono riusciti a nascondere, la pellicola è scarsa e spesso scaduta, la corrente manca. Eppure in Italia si continua a girare film.
Il motore economico di questa volontà di ripresa è l’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche ed Affini). Fondata il 10 luglio 1944, promuove il cinema italiano sia sul territorio nazionale che all’estero cercando di arginare la solita invasione di film Hollywoodiani e l’azione del PWB (Pshychological Warfare Branch, Divisione per la guerra psicologica): un organismo del governo militare anglo-americano incaricato di esercitare il controllo sui mezzi di comunicazione di massa italiani, fino ad allora considerati uno strumento del regime fascista.
Più critiche le condizioni, meglio i film riescono. Sempre più registi e sceneggiatori tornano o iniziano a fare cinema. Uno dei motivi principali è la voglia di riabilitazione dal recente passato e la necessità di indagare un presente in cui mancano punti di riferimento. Opera cardine di questo comune sentire è Roma città aperta (Rossellini, 1945) che ottiene un enorme successo di critica e pubblico, rimanendo nel palinsesto di alcuni cinema addirittura per due anni. Rossellini ha il merito di avere uno sguardo imparziale e dimesso nei confronti dei temi trattati, non prende le parti di nessuno dei personaggi ma si limita a raccontare le loro storie. Grazie a questo nuovo punto di vista imparziale, alla povertà dei materiali, spesso reperiti al mercato nero, e all’impiego di gente comune invece che di attori professionisti, si inizia a costruire un nuovo linguaggio cinematografico. Un po’ per necessità e un po’ per ispirazione nasce il Neorealismo.
Non è una gestazione semplice e da subito iniziano a coesistere opinioni diverse all’interno del gruppo di registi e sceneggiatori che vengono indicati come neorealisti. In realtà non è mai esistito un vero e proprio movimento neorealista, ma solo la necessità di raccontare temi comuni a tutta la popolazione e a riflettere sul presente. Il cinema diventa lo specchio di un paese e, per la prima volta in Italia, le persone si guardano sullo schermo: non ci sono più le grandi saghe mitologiche degli anni del muto, né i coraggiosi e forti eroi della propaganda fascista, ma solo uomini e donne che tentano una difficile rinascita tra le rovine della guerra e gli orrori del fascismo, che molti di loro avevano sostenuto.
Anche se accomunati come neorealisti, registi come Rossellini, De Sica e Visconti hanno pochissimo in comune e ognuno di loro vede il cinema a modo suo. Rossellini ha uno stile minimale e oggettivo, usa sia attori professionisti che non e, quando può, gira in teatri di posa: enormi spazi al chiuso dove si ricostruiscono ambienti reali per poter meglio controllare tutti gli elementi della messa in scena, dalla luce al suono. Diverso il discorso per De Sica che utilizza principalmente attori non professionisti presi dalla strada e location vere all’interno della città. Visconti invece è un perfezionista, riempie l’inquadratura di rimandi letterari e teatrali e nulla è mai fuori posto: è leggendaria la sua precisione nel disporre gli oggetti di scena, tanto da voler stipare di vestiti cassetti e armadi anche se non verranno mai inquadrati.
Parlando di De Sica non si può non citare i due film di maggior successo creati insieme allo sceneggiatore di una vita, nonché capostipite e trait d’union del Neorealismo, Cesare Zavattini: Sciuscià (1946) e Ladri di biciclette (1948). Il primo è un poetico racconto d’infanzia sull’abbandono e la violenza da parte di tutte la autorità, dalla famiglia fino alla polizia e allo stato; mentre il secondo è una fine analisi del rapporto tra un padre e un figlio, oltre ad essere un documento fedele e vivido sulla vita all’indomani della guerra. Fu premiato con l’Oscar. Anche se di minor successo, Miracolo a Milano (1951) costituisce sia uno splendido esempio di realismo magico nella miglior tradizione zavattiniana, che di profonda critica alla società e, al contempo, una prova dell’estrema ecletticità narrativa del Neorealismo.
Visconti, dopo aver fatto da spartiacque nella storia del cinema italiano col suo film Ossessione (1943), continua a dirigere le sue opere con uno stile ricco e zelante che pone al centro della storia l’essere umano. Ne La terra trema (1948) e nel successivo Bellissima (1951), pur parlando di realtà infinitamente diverse, il regista analizza prima la vita povera e aspra dei pescatori siciliani, utilizzando la macchina da presa come testimone di contesti sociali lontani e dimenticati, e poi quella di una madre ossessionata dall’abbagliante mondo dello spettacolo e disposta anche a sacrificare la figlia per realizzare i suoi sogni.
Accanto a questi tre autori, spesso identificati come numi tutelari del neorealismo, vi sono una moltitudine di altri grandissimi registi che hanno contribuito al cinema italiano in misura altrettanto importante. Anche se in questa sede non c’è spazio per trattarli tutti, cercherò almeno di elencarne il più possibile insieme ai loro film più significativi. Il primo è Alberto Lattuada, già attivo negli anni della guerra, che gira capolavori come Il bandito (1946), Il mulino del Po (1949) e La spiaggia (1954). Lattuada sembra avere una visione ottimistica per il futuro dell’Italia e la sua ispirazione di matrice letteraria e cinematografica, soprattutto il cinema francese di Carné e Renoir, lo rende uno dei registi più originali del neorealismo.
Uno sguardo invece più concentrato sui personaggi e sul loro relazionarsi con lo spazio circostante è quello di Giuseppe De Santis che raggiunge il successo nazionale e internazionale con Riso amaro (1949), a cui seguono Non c’è pace tra gli ulivi (1950) e Roma ore 11 (1952), storie diverse ma accomunate dall’intenzione dell’autore di raccontare la realtà sfaccettata di un paese in cambiamento.
Cambiamento che riguarda anche il mondo femminile, trattato sia nei film di De Santis che da quelli di Antonio Pietrangeli, il quale con lo splendido Adua e le compagne (1960), storia di quattro giovani prostitute che si trovano senza prospettive all’indomani della legge Merlin e la chiusura delle case di tolleranza, rappresenta con dignità e senza moralismi una storia di emancipazione e indipendenza da una società iniqua e perbenista.
In questo multiforme panorama si muove anche Pietro Germi, un regista che tratta di problemi come la migrazione interna ne Il cammino della speranza (1950), critica a un’Italia ostile e feroce, e umani ne Il ferroviere (1955). Anche nel suo Un maledetto imbroglio (1959), tratto dal romanzo di Gadda Pasticciaccio brutto de’ via Merulana, Germi continua a cinementarsi con temi e generi diversi, in questo caso un giallo anomalo, dimostrando la sua grande capacità di muoversi attraverso tutti gli aspetti del cinema.
Un capitolo a parte andrebbe dedicato a Francesco Rosi, regista che ha regalato agli spettatori film di una qualità tecnica e profondità di contenuti ancora oggi difficilmente eguagliabile. Il suo esordio con La sfida (1958) presenta già in parte i temi e lo stile dei suoi prossimi film, che negli anni a venire lo renderanno uno dei registi italiani più interessanti e politicamente schierati.
Michelangelo Antonioni gira il suo primo documentario nel 1943, Gente del Po. A pochi chilometri dal set di Visconti, che sta girando Ossessione, Antonioni sta già imboccando una via diversa rispetto all’interpretazione del neorealismo degli altri registi suoi contemporanei, una via che troverà pieno sviluppo durante gli anni ’60. Con Cronaca di un amore (1950) Antonioni pone già le basi per tutta la sua filmografia futura: dall’osservazione imparziale e distante all’ambientazione in una città fredda e a tratti onirica, doppione psicologico dei personaggi. Ne La signora senza camelie (1953) il regista continua a proporre la sua poetica e con Il grido (1957) attua una rottura nei confronti dei suoi film precedenti, iniziando così la sua fase di maggiore ispirazione.
Sceneggiatore a Roma per più di dieci anni, firmatario di una parte di Roma città aperta (Rossellini, 1945), esordiente come co-regista nel film Luci del varietà (Lattuada, 1950) e poi come regista vero e proprio con Lo sceicco bianco (1952) è Federico Fellini, che da allora non si fermerà più per i quattro decenni successivi. Autore di alcuni dei film più significativi e rappresentativi degli anni ’50: I vitelloni (1953), La Strada (1954), Il bidone (1955), Le notti di Cabiria (1957) e La dolce vita (1960). Quest’ultimo vero e proprio spartiacque che segna la fine ufficiale del Neorealismo, ormai imploso per la molteplicità di temi e film a cui non corrisponde un’unità né ideologica né produttiva, e l’inizio di un nuovo fecondo periodo della storia del cinema italiano. Periodo di cui si parlerà nel prossimo articolo.
Certamente non privo di critiche nei confronti della nostra società, il cinema assunse comunque il ruolo di ambasciatore della cultura italiana grazie al forte spirito innovatore e all’altissimo livello artistico raggiunto dai suoi autori. Tutto ciò contribuì a riabilitare l’Italia agli occhi del mondo e ad esportare un’idea di eccellenza e qualità, fornendo un solido appoggio alla ripresa dell’industria e alla conseguente creazione del concetto di Made in Italy. Per concludere, va ricordato come i nomi sopracitati non erano in quel momento solo tra i registi di punta del cinema italiano, ma anche del cinema mondiale. Prova ne è l’enorme impatto che i film di questo quindicennio hanno avuto sul resto dei cineasti, facendo da guida per i contemporanei e ispirando le generazioni future.