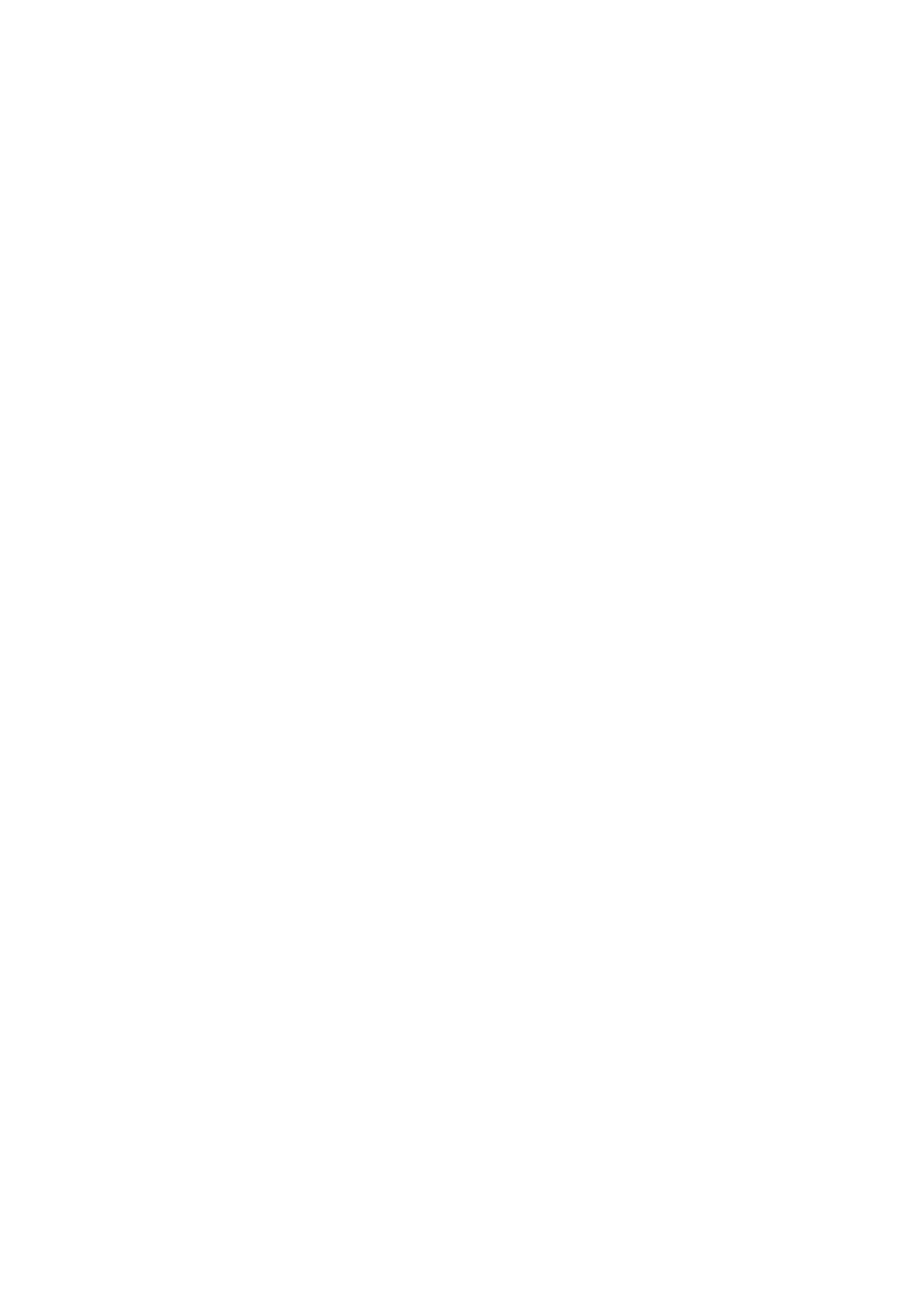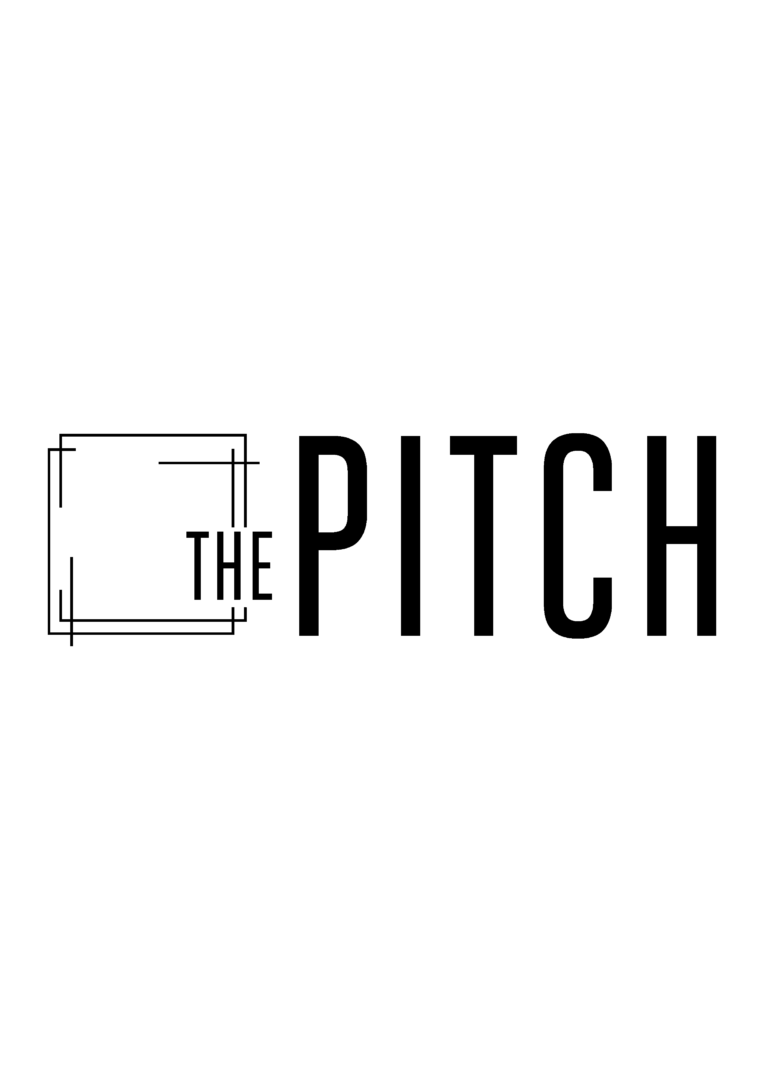Miracolo sul parquet
Ho avuto una vita felice. Ma se Dio mi concedesse di tornare indietro, per una volta, non avrei dubbi: chiederei di poter rigiocare una partita. Quella.
Douglas Collins
Dal Secondo Dopoguerra in poi, le competizioni sportive internazionali sono contrassegnate dalle tensioni politiche. La XX Olimpiade, che si svolge a Monaco di Baviera nel 1972, raggiunge però un picco che non si ripeterà neppure a Mosca 1980 ed a Los Angeles 1984, le due edizioni caratterizzate dai boicottaggi. Già, perché l’Olimpiade tedesca sarà ricordata esclusivamente – e giustamente – per il “Massacro di Monaco”. È la notte del 5 settembre, quando la lotta per la libertà del popolo palestinese fa irruzione violentemente sul palcoscenico globale: un commando dell’organizzazione “Settembre Nero”, formato da otto terroristi palestinesi, penetra nel Villaggio Olimpico uccidendo undici membri della delegazione israeliana. L’attentato è una carneficina, anche per la discutibile gestione della crisi da parte degli organizzatori e delle autorità tedesche. Ma mentre il mondo intero ancora sente rimbombare i colpi delle pistole e non riesce a dimenticare le immagini dei corpi massacrati, il controverso presidente del CIO, Avery Brundage, ha già deciso che “the show must go on”, che la fiamma olimpica non si può spegnere. Così, dopo un solo giorno di sospensione per commemorare le vittime, le competizioni ripartono.

Gli anni ’60 sono caratterizzati da un desiderio di supremazia militare ed economica delle due superpotenze che si dividono il mondo. Nel 1961 inizia la costruzione del Muro di Berlino, l’anno successivo si rischia seriamente lo scontro armato tra USA e URSS durante la Crisi missilistica di Cuba e nel 1965 gli americani intervengono militarmente a sostegno del Vietnam del Sud, impegnato in una guerra contro lo stato comunista del Vietnam del Nord sostenuto dai sovietici e dalla Cina. La tensione si fa sempre più palpabile, almeno fino alla fine del decennio, quando Nixon e Breznev inaugurano il periodo della distensione, caratterizzata dagli accordi sulla non proliferazione nucleare. Così, negli anni ’70 il teatro dello scontro si sposta in ambito sportivo. Si arriva così ai Giochi di Monaco 1972, dove nella finale del torneo olimpico di basket le due superpotenze si sfidano sul parquet, in quello che sarà poi considerato l’inizio della “Guerra Fredda sportiva”.
Alle Olimpiadi invernali di Lake Placid 1980, sul ghiaccio dell’Olympic Center Ice Rink, i collegiali americani riescono a sconfiggere il temibile squadrone sovietico imbattuto da 42 partite consecutive, riuscendo a mettersi la medaglia d’oro al collo. È la partita del famoso «Do you belive in miracles? Yes!», pronunciato dal telecronista statunitense Al Michaels. Ecco, la finale di basket del 1972 è lo stesso tipo di partita. Solo che a parti invertite.
Le regole olimpiche vietano espressamente che i cestisti selezionati siano professionisti – come avviene oggi nel pugilato –, ragion per cui i giocatori NBA non possono rappresentare la nazionale statunitense, che è quindi composta solo da promettenti giovani provenienti dalle squadre dei college. La selezione a stelle e strisce viene comunque considerata la favorita del torneo, vista la tradizione vincente di cui si può fregiare: da Berlino 1936, edizione in cui la pallacanestro è stata inserita nel programma olimpico, gli USA hanno conquistato tutte e sette le medaglie d’oro, con un record che recita 63 vittorie e zero sconfitte.
La selezione sovietica, invece, già da parecchie edizioni sfrutta la regola sul professionismo a proprio vantaggio, classificando i propri atleti come soldati o lavoratori. Questo stratagemma permette di schierare una squadra di giocatori molto esperti e che per l’intero anno si è allenata solo in funzione della manifestazione a cinque cerchi. Al di fuori dei Giochi Olimpici, l’URSS ha conquistato, solamente l’anno prima, l’ottava edizione consecutiva dei Campionati Europei e nel 1967 era stata la prima nazionale del Vecchio Continente a conquistare il titolo mondiale. La squadra del 1972, allenata dall’emergente Vladimir Kondrashin, ha la sua stella in Sergej Belov, il miglior giocatore del basket europeo e già vincitore da MVP di due Coppe dei Campioni con il CSKA Mosca. A fargli da sparring partner ci sono il capitano Modestas Paulauskas, Gennadi Vol’nov, alla sua quarta partecipazione olimpica, e Alexander Belov, che di quell’edizione diventerà l’eroe.
9 settembre 1972. Sono passati solo quattro giorni dalla strage che ha sconvolto il mondo. Ma gli interessi sportivi – anche se sarebbe meglio dire economici – si sono già riappropriati della scena. Alla Rud-Sedlmayer-Halle di Monaco di Baviera sono le 23:45 quando inizia la finale olimpica tra Stati Uniti ed Unione Sovietica. L’orario insolito è stato scelto per accontentare le potenti reti televisive americane, che vogliono trasmettere l’evento in patria ad un orario accettabile. La partita è fin da subito molto tesa: un riflesso degli scontri e delle tensioni extra-sportive che accompagnano qualsiasi incontro tra le due superpotenze.

© Getty Images
Solamente una settimana prima, a Reykjavìk, si è concluso il Mondiale di scacchi, che per la prima volta ha visto trionfare uno statunitense. Bobby Fischer ha sconfitto il sovietico Boris Spasskij in quello che, fin da subito, viene definito come “l’incontro del Secolo”, ponendo così fine al domino dell’URSS che durava dal 1937. Una vittoria dalla grande risonanza propagandistica, visto che permette agli Stati Uniti di affermare a gran voce la loro superiorità sportiva. Un predominio che, però, dura solo una settimana.

Fin dalla palla a due messa in palio dall’arbitro brasiliano Renato Righetto, i giovani americani restano sorpresi dal gioco intimidatorio della squadra sovietica, il cui unico obiettivo è vincere a qualunque costo. Non stanno semplicemente giocando la finale olimpica, ma stanno combattendo la Guerra Fredda e sono motivati da un odio ideologico, ancor prima che sportivo. Dopo essere stati in svantaggio per tutto il primo tempo, ad inizio ripresa le ambizioni degli Stati Uniti subiscono due brutti colpi: prima Jim Brewer s’infortuna a seguito di una spinta volontaria di Alexsander Belov, poi Dwight Jones si fa espellere per una reazione alle provocazioni sovietiche. Un uno-due che metterebbe KO qualsiasi squadra ben più esperta, ma l’orgoglio e la vergogna di dover passare alla storia come la prima nazionale americana a non vincere l’oro olimpico mette le ali ai ragazzini. La rimonta li porta fino al -1 ad una trentina di secondi dalla sirena finale. Ai sovietici basterebbe temporeggiare ancora qualche momento per lasciar scorrere il tempo e segnare un ultimo canestro che li porterebbe ad un punteggio irraggiungibile, visto che il tiro da tre punti ancora non esiste. Ma, con ancora sette secondi ancora da giocare, Doug Collins – che sarà poi l’allenatore dei Chicago Bulls di un giovanissimo Micheal Jordan – recupera un pallone che gli permette di involarsi verso il possibile canestro del sorpasso. Non ha però fatto i conti con Zurab Sakandelize, che pur di vincere è disposto ad abbattere Collins con un montante che lo lascia per terra tramortito. Mancano tre secondi e gli Stati Uniti hanno a disposizione due tiri liberi. Ma da questo momento la narrazione della partita smette di essere semplicemente sportiva, entrando in una dimensione dell’epica: saranno i tre secondi più lunghi della storia del basket.
Doug Collins si reca in lunetta segnando il primo tiro libero, ma mentre si appresta a tirare il secondo improvvisamente suona la sirena. Il tiro entra, portando gli americani in vantaggio, ma è l’inizio di una catena di eventi che lascerà questi ultimi tre secondi impantanati nelle polemiche per sempre. L’allenatore sovietico ha lasciato l’area tecnica per avvicinarsi al tavolo dei giudici: protesta perché sostiene di aver chiamato un time-out che non gli è stato assegnato. Dal momento che questo non può essere chiamato dopo il secondo libero, i russi sono costretti a rimettere velocemente la palla in gioco. Mentre Zharmukhamedov passa il pallone a Sergeij Belov, Righetto fischia l’interruzione della partita, visto il disturbo arrecato da Kondrashin al tavolo. Il cronometro si ferma con ancora un secondo da giocare. La panchina dell’URSS insiste, sostenendo di aver chiamato il time-out appena Collins ha subito il fallo, ma dopo aver ascoltato le loro motivazioni Righetto decide comunque di non concederglielo, anche se ormai il minuto trascorso per decidere come procedere ha dato modo a Kondrashin di escogitare uno schema di gioco. La non-decisione dell’arbitro brasiliano fa si che il gioco debba riprendere da quando è stato interrotto, ovvero con un solo secondo da giocare. Ed è in questo momento che entra in scena un altro personaggio fondamentale di questa partita: il presidente della FIBA, William Jones. Con tutta l’autorità che si sente addosso, ma di cui in realtà non dispone, scende dalle tribune per imporre che il gioco riprenda dalla rimessa sovietica dopo il secondo libero segnato da Collins, ovvero con ancora tre secondi sul cronometro. Il tutto, naturalmente, non senza la disapprovazione statunitense. L’arbitro consegna il pallone per la ripresa al sovietico Jadeska, senza rendersi contro che il cronometrista sta ancora lavorando per riportare il tempo sul tabellone ai famigerati tre secondi. La pressione asfissiante portata sulla linea di fondo dal centro americano McMillen, costringe il sovietico ad una rimessa corta in direzione del compagno Paulauskas. Il suono della sirena, quando il pallone deve ancora giungere nelle mani di quest’ultimo, fa pensare a tutti i presenti – ed anche ai telespettatori – che l’incontro si è concluso. Gli spettatori invadono il parquet e i cestisti statunitensi saltano di gioia per la vittoria conquistata in extremis.
William Jones interviene con ancor più veemenza, perché il tempo di gioco non è stato ristabilito correttamente dal cronometrista, un certo Joseph Blatter – sì, proprio quel Blatter che nel 1998 diventerà presidente della FIFA e vi rimarrà in carica fino allo scandalo che lo vedrà coinvolto nel 2015. I direttori di gara ordinano di sgomberare il campo e di ripetere gli ultimi tre secondi. Gli americani sono talmente furiosi da pensare, per un momento, di abbandonare il parquet. L’allenatore Henry Iba torna però sui suoi passi temendo che un’azione del genere porterebbe ad una squalifica. Si riparte con il terzo tentativo di rimessa. McMillen va ancora in pressione, ma mentre il secondo arbitro – il bulgaro Artenik Arabadjian – si prepara a rimettere il pallone in gioco, fa un gesto al centro americano, che indietreggia di pochi metri. McMillen dichiarerà in seguito che Arabajdian, in quel frangente, gli aveva ordinato di arretrare e che, nonostante non esistesse una regola a riguardo, aveva deciso di conformarsi per non rischiare di incorrere in un fallo tecnico. A quel punto Jadeska, senza più pressione, ha una linea di passaggio molto chiara verso Alexsander Belov, che si trova dall’altra parte del campo. L’azione sarà poi raccontata dallo stesso Belov: «Ho fatto una finta, poi ho rapidamente voltato le spalle e sono corso verso il canestro. Il passaggio è stato perfetto. Ero l’unico sotto canestro. Mi sono persino girato, nessuno era vicino a me. E con la mano destra ho tirato con cura». Sono i due punti che valgono la medaglia d’oro olimpica.
Gli Stati Uniti si sentono rapinati e, nella notte di Monaco, consegnano un ricorso dettagliato alle autorità competenti. È una giuria di appello della FIBA, composta da cinque membri, a dover giudicare la validità della richiesta americana, che però viene rigettata. A lasciare molti dubbi è la formazione di quella commissione, che vede tre componenti provenienti da nazioni “filosovietiche” (Ferenc Hepp dall’Ungheria, Andres Keizer da Cuba e Adam Baglajewski dalla Polonia) e due da nazioni “filoamericane” (Rafael Lopez da Porto Rico e Claudio Coccia dall’Italia), alimentando così il sospetto che il conteggio si sia basato più sulle appartenenze politiche della Guerra Fredda, piuttosto che sul regolamento FIBA. I giocatori americani continuano a ritenere di essere stati derubati e decidono all’unanimità di non presentarsi alla cerimonia di premiazione e di rifiutare le loro medaglie d’argento, che ancora oggi sono contenute nel caveau di una banca di Losanna e che nessuno ritirerà mai. Già, perché secondo le regole del CIO per decidere di ritirarle serve che ogni componente di quella squadra dia il proprio assenso. Kenny Devis arriverà al punto di inserire nel proprio testamento una clausola che vieta espressamente ai suoi eredi di ritirarla dopo la sua morte, perché – come ha spiegato nel documentario di ESPN “Silver Reunion” – «quelle medaglie non sono nostre, non ci appartengono. Noi abbiamo vinto l’oro».

L’Unione Sovietica rivendicò quella vittoria non solo a livello politico, ma anche come prova della superiorità sportiva, in particolare del basket socialista su quello capitalista. La caduta degli imbattibili giganti americani, per quanto rocambolesca e piena di polemiche, portò grandi conseguenze nella pallacanestro mondiale: ci fu la presa di coscienza che i cestisti statunitensi, per quanto fortissimi, non erano invulnerabili. Il 9 settembre 1972 l’imbattibile nazionale di basket degli USA perse la sua prima partita olimpica, ma fu anche il giorno in cui le truppe a stelle e strisce cominciarono un lungo e doloroso ritiro dal Vietnam, che andava avanti da oltre 15 anni. L’invincibilità cestistica e militare americana cadde quel giorno.