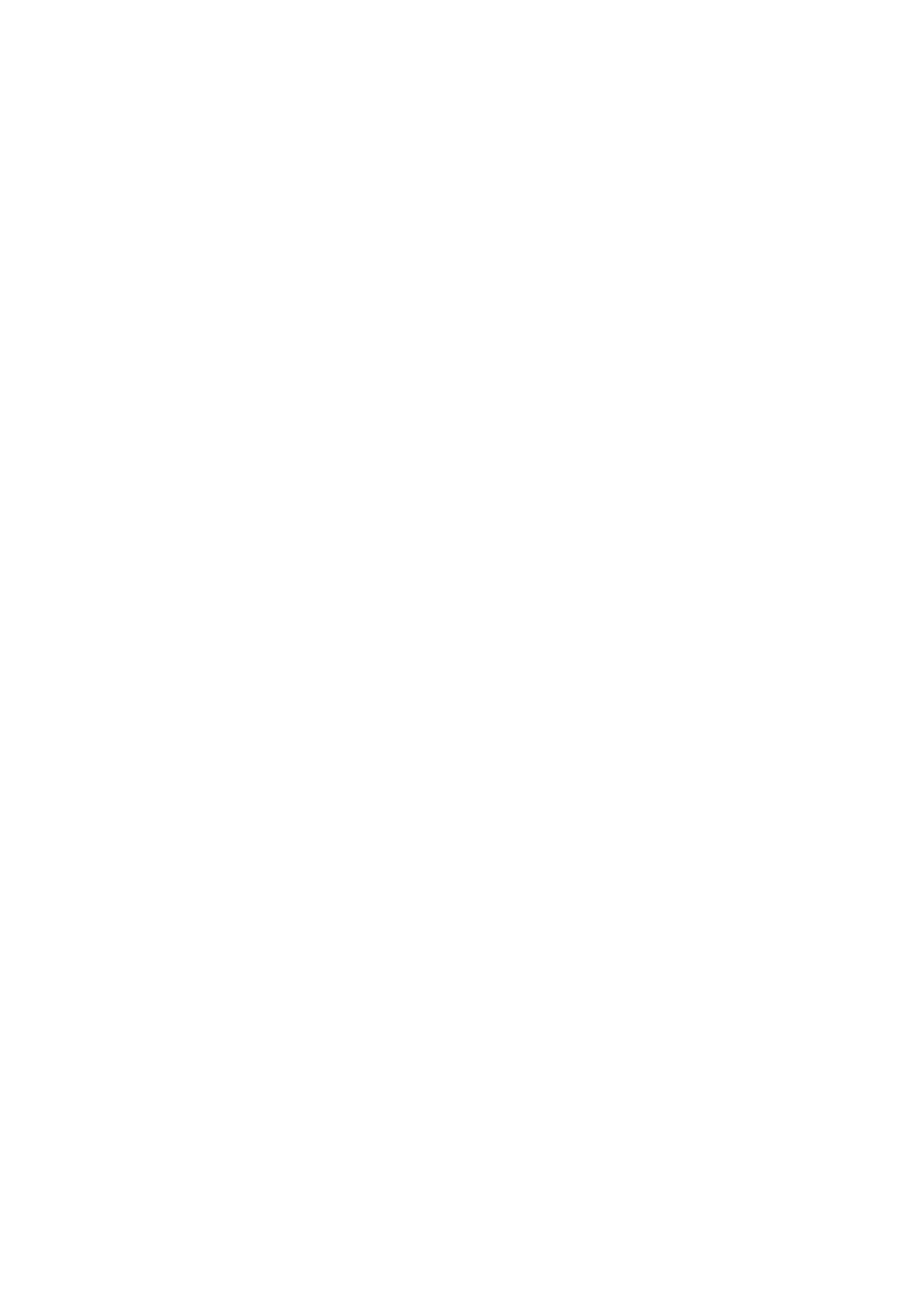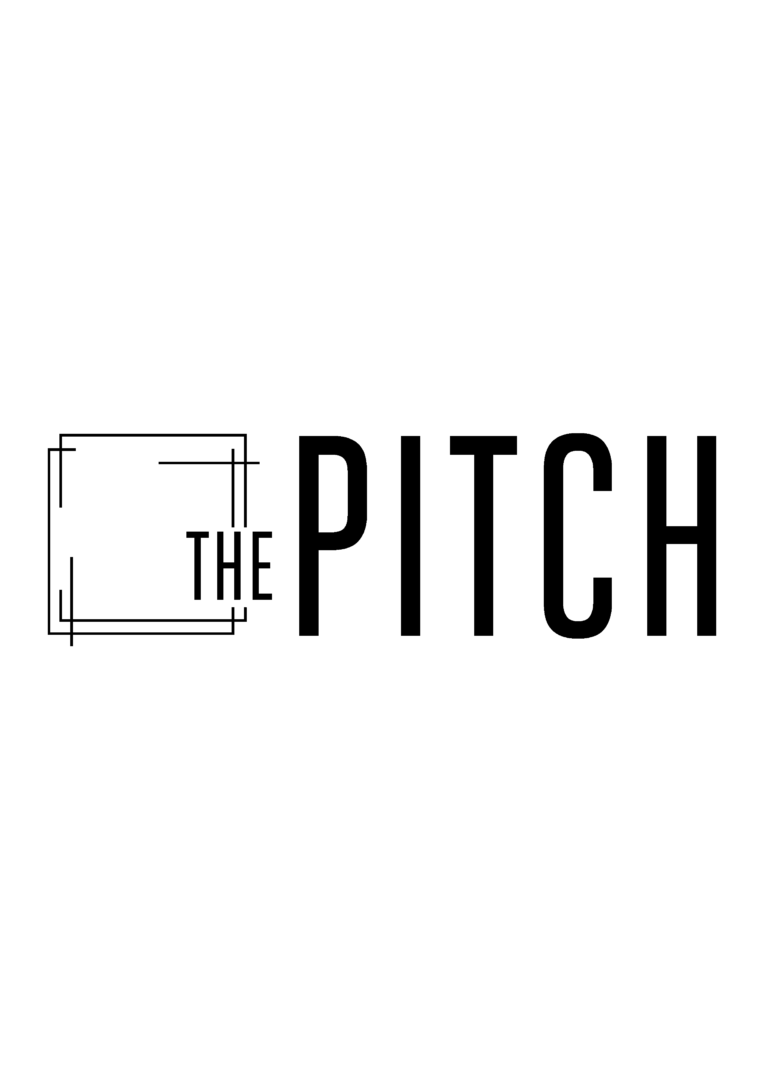Tutti partecipano al grande gioco mediorientale
Un territorio montuoso e privo di sbocchi sul mare, perno del cosiddetto “Grande Medio Oriente”, l’Afghanistan è stato definito diverse volte come “il cimitero degli imperi”, per le enormi difficoltà incontrate da chiunque abbia provato a conquistare questa terra.

Tra fine ‘800 e ‘900 (negli anni in cui Rudyard Kipling scrisse la poesia “Il fardello dell’uomo bianco”) gli inglesi provarono diverse volte, con scarso successo, a invadere l’Afghanistan, per mettere al sicuro la perla del loro impero coloniale: l’India.
Nel 1979 fu la volta dell’Unione sovietica, che si impegnò in un complicato conflitto che di fatto rappresentò il suo Vietnam, prima di dissolversi all’inizio degli anni ’90.
A partire dall’ottobre del 2001 ad essere impegnati in un lungo ed estenuante conflitto in Afghanistan sono stati invece gli Stati Uniti d’America, alla guida di una coalizione internazionale sotto l’egida NATO e autorizzata dalle Nazioni Unite. Scopo della campagna, avviata dal presidente repubblicano George W. Bush nell’ambito della “guerra al terrorismo internazionale”, era la rimozione di Al Qaeda e la cattura di Osama Bin Laden, considerato il principale responsabile dell’attacco al World Trade Center dell’11 settembre del 2001.
Il conflitto ha attraversato numerose fasi, e di recente è stato raggiunto un accordo che dovrebbe portare al completo ritiro delle truppe americane entro il maggio del 2021. Secondo il NY Times, il ritiro potrebbe addirittura concretizzarsi in maniera definitiva prima delle elezioni americane che avranno luogo il prossimo novembre.
Si tratta, ad ogni modo, della guerra più lunga combattuta dall’esercito americano, e l’invasione dell’Afghanistan, insieme alla Guerra all’Iraq di Saddam Hussein iniziata nella primavera del 2003, rappresenta senza dubbio uno spartiacque nella politica estera americana, in particolare modo con riferimento al Medio Oriente, unanimemente considerato l’area geografica più instabile del pianeta.

Da sinistra a destra: Saddam Hussein, Hafiz al-Assad, Abdelaziz Bouteflika e il vice presidente siriano Abd al-Halim Khaddam
A partire dagli anni ’90, con il crollo dell’Unione Sovietica e l’improvvisa fine della guerra fredda e del bipolarismo che aveva caratterizzato il secondo dopoguerra, gli Stati Uniti hanno inaugurato una nuova era della politica estera in Medio Oriente. Questa fase si è aperta, idealmente, con l’attacco all’Iraq di Saddam Hussein nel gennaio del 1991, che aveva invaso il Kuwait. Gli Usa si sono ritagliati un ruolo da potenza egemone, grazie a tre principali direttrici in politica estera: il simultaneo contenimento di Iraq e Iran (protagonisti negli anni ’80 di un’estenuante conflitto immediatamente successivo alla rivoluzione iraniana), il rafforzamento della presenza militare in Arabia Saudita e il tentativo di favorire il processo di pace tra Israele e Palestina.
Gli attacchi dell’11 settembre alle Torri Gemelle hanno rappresentato, nel più crudele e spietato dei modi, la pietra tombale sulla politica estera mediorientale portata avanti dall’amministrazione statunitense nel decennio precedente. Il supporto militare ai mujaheddin afghani durante l’invasione dell’Unione Sovietica del 1979 (tramite l’operazione Cyclone, fortemente voluta da Roland Reagan) ha contribuito a mettere le basi per una successiva crescita di gruppi estremisti islamici nella regione, e l’eccessivo dispiegamento di truppe in Arabia Saudita nel corso degli anni ’90 ha poi creato le condizioni per un ampliamento delle fila di Al Qaeda.
I successivi tentativi del presidente George W. Bush di “esportare la democrazia” in Medio Oriente si sono rivelati, nel giro di pochi anni, altrettanto fallimentari. Le cause che hanno determinato la completa débâcle della politica a stelle e strisce nella regione sono molteplici, ma si possono ricondurre in primo luogo alla fragilità strutturale del sistema mediorientale, la cui configurazione e divisione tra Stati non è il frutto di un processo di autodeterminazione ma di una secolare imposizione dall’alto. Una serie di accordi hanno spartito la regione in sfere di influenza a partire dai tempi della “Questione orientale”, avvio al tramonto dell’Impero Ottomano nel XIX secolo.
Il sistema statale mediorientale è giovane e si basa sulla condivisione di un patrimonio identitario non ancora del tutto stabile e definito, ed è chiaro che ogni tentativo di ingerenza esterna per “indirizzare” i processi di nation building non ottiene altro risultato che quello di complicare e rallentare il cammino verso l’autodeterminazione e la definizione di un sistema di valori condivisi e di identità forti, necessario per l’instaurazione in futuro di governi stabili e duraturi.
La presa di coscienza, da parte statunitense, del fallimento del proprio tentativo di “egemonizzare” la regione ha determinato un radicale cambiamento di scenario e, a partire dall’amministrazione Obama, gli Stati Uniti si stanno progressivamente defilando dal Medio Oriente, ridimensionando significativamente il proprio impegno militare, iniziando proprio dall’Iraq. Questo nuovo atteggiamento trae origine sia da considerazioni prese a livello puramente istituzionale e governativo che da un radicale cambiamento nell’opinione pubblica americana (e mondiale), che, con particolare riferimento all’Iraq, ha iniziato a vedere di cattivo occhio il conflitto armato, avviato al di fuori delle regole della carta delle Nazioni Unite.
Il disimpegno americano in Medio Oriente apre dunque nuovi e per certi versi imprevedibili scenari. Com’è evidente, la decisione di svincolarsi dal ruolo di “poliziotto della regione” crea una situazione in cui il rischio maggiore è che, agli occhi delle potenze rivali, ci sia una perdita di credibilità. Gli Stati Uniti hanno cercato così di tamponare la propria progressiva uscita di scena con una serie di mosse, per certi versi non del tutto coerenti tra di loro.
In primo luogo, si è assistito ad un tentativo di delegare a potenze ed attori regionali il perseguimento degli impegni presi, con risultati spesso deludenti e senza che ci fosse l’effettiva capacità di tenere totalmente sotto controllo l’azione dei potenziali partner che spesso sono stati usati in modo strumentale e con opportunismo (si veda il caso dei curdi e del Rojava).
Inoltre, gli Stati Uniti hanno cercato di normalizzare i rapporti con alcuni dei nemici regionali. Su tutti, è eclatante il caso dell’accordo per il nucleare con l’Iran (JCPOA), che secondo molti ha costituito il principale successo di politica estera dell’amministrazione Obama. Anche in questo caso, però, sono emerse una serie di contraddizioni ed effetti collaterali legati all’accordo. Da un lato si è manifestato il disappunto degli alleati storici regionali (Arabia Saudita e Israele), mentre dall’altro la mancanza di continuità nelle linee guida della politica estera americana, con l’arrivo alla Casa Bianca di Donald Trump, ha portato all’uscita unilaterale dall’accordo, all’imposizione di nuove sanzioni e a nuove tensioni con l’Iran (culminate con l’uccisione di Qasem Soleimani lo scorso gennaio).

Da sinistra a destra: la guida suprema iraniana Ali Khamenei, il segretario di Hezbollah Hassan Nasrallah e il defunto capo della Forza Quds Qasem Soleimani
Infine, per quel riguarda la Siria, teatro del dossier più caldo a livello globale dell’ultimo decennio, gli Stati Uniti hanno scelto una linea di pressoché totale estraneità al conflitto. Questo genere di approccio ha determinato, forse per la prima volta dalla fine della Guerra Fredda, la possibilità di potenze terze di inserirsi nello “spazio vuoto” lasciato dalla scelta di defilarsi da parte della superpotenza. L’opportunità è stata prontamente colta dalla Russia, che di fatto nel giro di pochi anni è diventato l’attore più forte e determinante in Siria, tramite il proprio supporto al presidente Bashar al-Assad e al fronte comune costruito con Iran e Hezbollah libanese.
Gli Stati Uniti hanno deciso di abdicare dal proprio ruolo di garanti dell’ordine liberale e di difensori dei valori sociali e civili, lasciando uno spazio che la Russia non ha esitato ad occupare.
Va notato come, soprattutto negli anni della presidenza Trump, il massiccio ricorso a sanzioni economiche nei confronti dei paesi considerati ostili sembra aver preso il posto del tradizionale interventismo militare nella regione. E così, se all’uscita dall’accordo sul nucleare con l’Iran ha fatto seguito l’imposizione di dure sanzioni economiche, in tempi ben più recenti l’adozione del Caesar act rischia di colpire duramente la già fragile economia siriana così come quella del vicino Libano.

Questo trend di disimpegno americano va senz’altro inserito in un contesto globale di mutamento del mercato dell’energia che si trova ora nell’età dell’abbondanza, in cui gli Stati Uniti hanno decisamente diminuito il proprio grado di dipendenza dall’OPEC e dai paesi del Medio Oriente (anche grazie alla rivoluzione dello “shale oil” e dello “shale gas”). Le decisioni prese da parte americana vanno lette anche alla luce di questo dato di politica energetica.
Una caratteristica paradossale della situazione attuale del Medio Oriente è che, in una regione che viene generalmente (ed erroneamente) fatta coincidere con il mondo arabo, gli attori fondamentali sono potenze non arabe che si trovano, anche geograficamente, ai margini della regione.
In primis, la Russia sta cercando di rilanciare il proprio ruolo di grande potenza e si è gettata nel “grande gioco mediorientale” avviando un dialogo aperto con praticamente tutti gli altri attori regionali, e ricopre a oggi un ruolo cruciale in due dei principali fronti dell’area (la Libia, dove supporta Khalifa Haftar, e Siria, dove supporta Bashr al-Assad in un rapporto che ultimamente ha vissuto di qualche luci ed ombra).
L’Iran ricopre senza dubbio un ruolo centrale nella regione in cui è il principale paese sciita. Intorno al paese degli Ayatollah si creano le principali fratture del Medio Oriente, e uno dei tentativi di Teheran è quello di dare luogo alla cosiddetta “mezzaluna sciita” fino al Libano. La strategia iraniana è quella della deterrenza attraverso la “difesa avanzata”; il paese ha vissuto in modo traumatico il confitto con l’Iraq degli anni ’80, e questo ha determinato la scelta di rinunciare totalmente ad attacchi convenzionali e di creare una rete di satelliti: in questo modo, un eventuale attacco nemico su suolo iraniano esporrebbe i nemici a possibili ritorsioni iraniane ovunque. Inoltre, l’utilizzo dei proxies permette all’Iran la plausibile deniability, la mancata attribuzione di responsabilità e quindi la capacità di sottrarsi ad eventuali contrattacchi. Nella strategia iraniana, la Siria riveste un ruolo cruciale: “se perdiamo Damasco, non saremo in grado di tenere Teheran”. Per l’Iran, la Siria rappresenta l’unico paese arabo che storicamente è stato un alleato, oltre a rivestire un’importanza strategica nella costruzione della già citata “mezzaluna sciita”. Una questione non di politica estera, ma di sicurezza nazionale. L’Iran ha sì un atteggiamento aggressivo a livello regionale, ma è chiaro che senza un allentamento delle sanzioni è impossibile aspettarsi un cambio di registro da parte di Teheran.
Nel contesto della guerra civile siriana, un fattore di novità rispetto al passato recente è costituito dal Processo di Pace di Astana, parallelo rispetto al canale ufficiale di Ginevra. Iran, Russia e Turchia si sono riunite in Kazakistan per decidere le sorti della Siria, segnando di fatto la completa esclusione dalla questione sia di Stati Uniti che di Unione Europea. La gestione delle crisi con approccio “regionale” rappresenta, senza dubbio, un ulteriore segnale del venir meno dell’egemonia statunitense e del tramonto dell’unipolarismo.

Hassan Rouhani, Vladimir Putin e Recep Tayyp Erdogan
Il ricorso alla proxy war, alla guerra per procura, è sempre più diffuso in Medio Oriente. Ne è un triste esempio lo Yemen, dove da anni è in corso un conflitto che sta dando luogo alla peggior crisi umanitaria a livello globale. In Yemen l’Iran sostiene militarmente, da anni, i ribelli sciiti Houti, e molti dei combattimenti sono stati combattuti per ottenere il controllo della zona dello stretto di Bab el-Mandeb, che apre l’accesso al Mar Rosso. Uno dei motivi del sostegno iraniano gli Houti sarebbe quindi la volontà di ottenere il controllo dello stretto e guadagnare così lo stesso potere di deterrenza che Teheran è in grado di esercitare tramite il controllo dello stretto di Hormuz che regola l’accesso al golfo Persico. Sfruttamento delle risorse energetiche e rendita energetica sono infatti fattori alla base di molti dei conflitti che hanno caratterizzato la regione negli ultimi decenni.
Negli ultimi due decenni si è assistito alla perdita di efficacia e di coerenza dell’intervento esterno nella regione mediorientale. L’avvio del processo di disimpegno americano e la totale mancanza di una politica europea verso la regione aprono il campo all’inserimento di altre potenze extra-regionali. Il comune impegno nella lotta allo Stato Islamico ha costituito un effimero punto di contatto tra i principali attori in campo; in un contesto ancor più frammentato rispetto al passato sembra ora riaccendersi la lotta per l’egemonia nella regione, con un numero sempre maggiore di protagonisti.