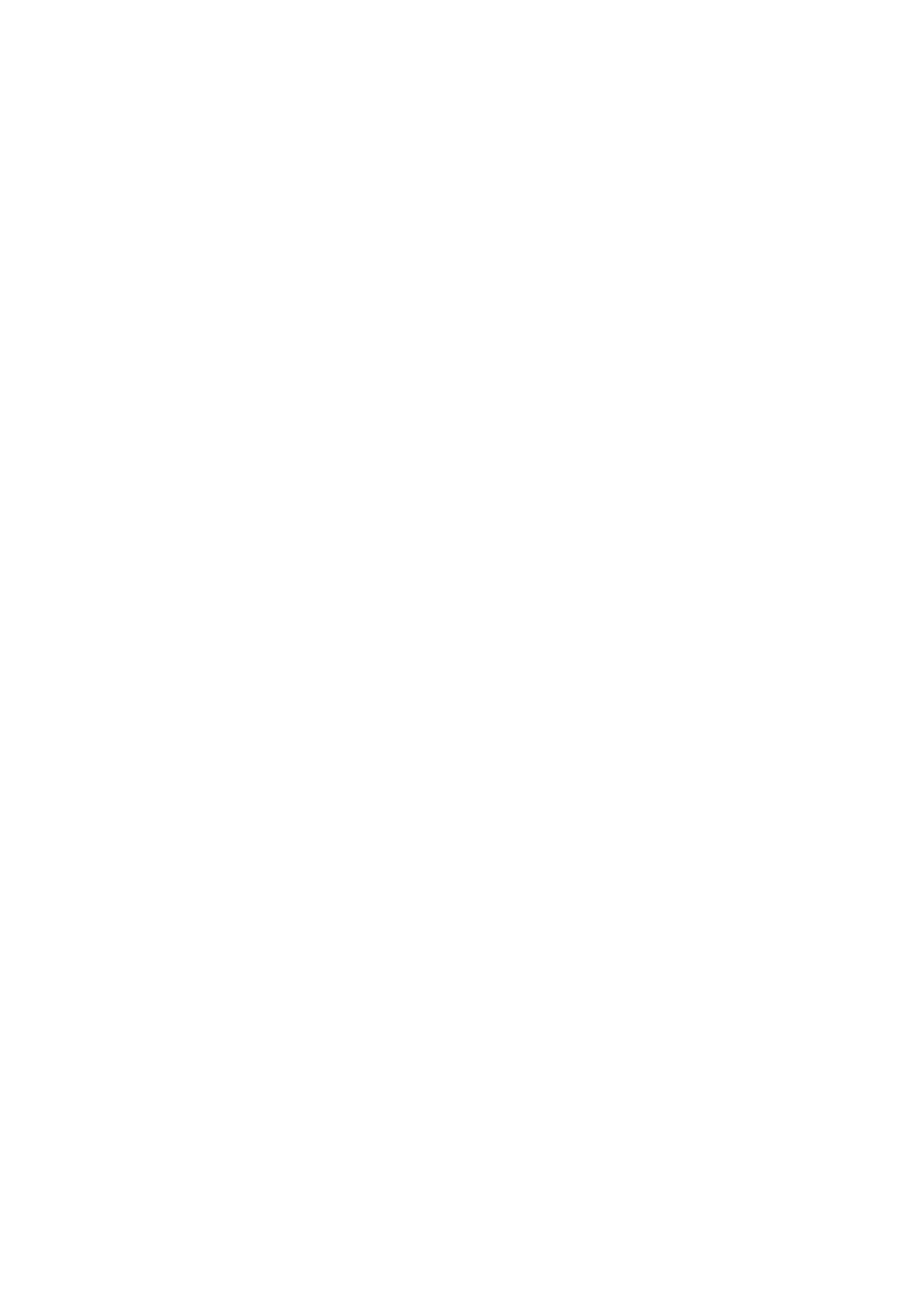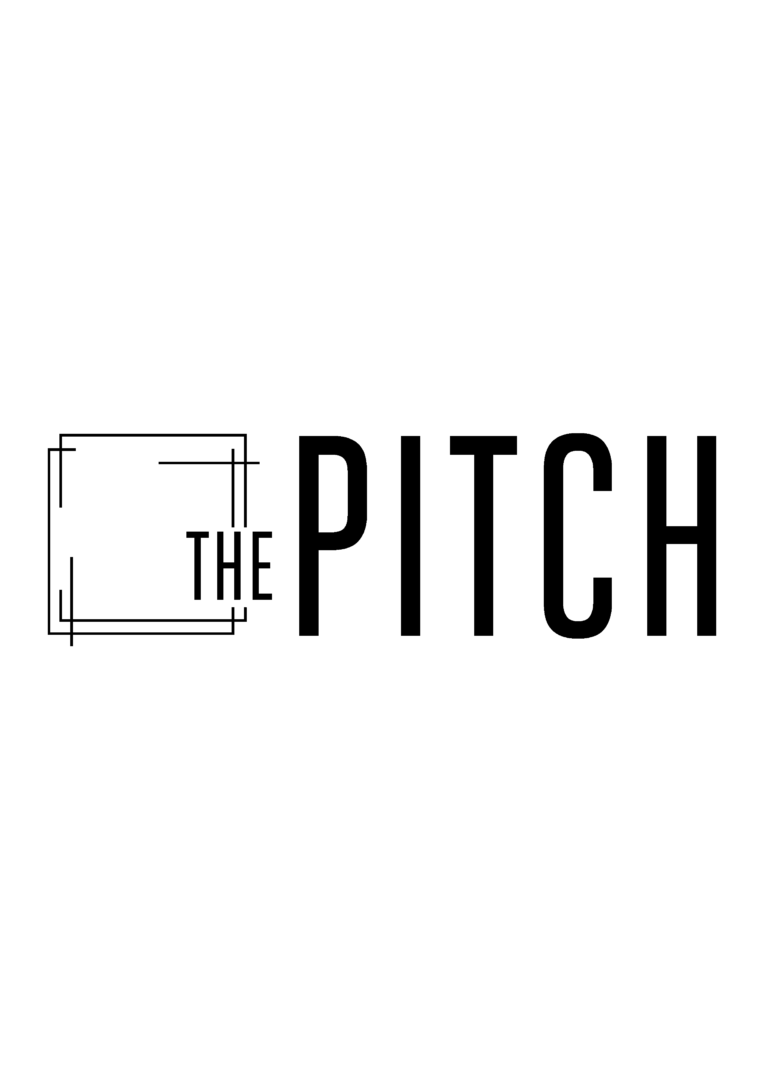Skip INDRO
Alla base di ogni espansione, il desiderio sessuale
Ennio Flaiano
Memoria e Storia non sono la stessa cosa. Sono “lungi dall’essere sinonime”, secondo lo storico, forse un po’ troppo citato a sproposito in questi giorni, Pierre Nora:
Memoria e storia: lungi dall’essere sinonime, noi ci rendiamo conto che tutto le oppone. La memoria è la vita, sempre prodotta da gruppi umani e perciò permanentemente in evoluzione, aperta alla dialettica del ricorso e dell’amnesia, inconsapevole delle sue deformazioni successive, soggetta a tutte le utilizzazioni e manipolazioni, suscettibile di lunghe latenze e improvvisi risvegli. La storia è la ricostruzione, sempre problematico e incompleta di ciò che non c’è più. La memoria è un fenomeno sempre attuale. Un legame vissuto nell’eterno presente; la storia una rappresentazione del passato. In quanto carica di sentimenti e di magia, la memoria si concilia con dettagli che la confortano; essa si nutre di ricordi sfumati, specifici o simbolici, sensibile. a tutte le trasformazioni, filtri, censure o proiezioni. La storia in quanto operazione intellettuale e laicizzante, richiede analisi e discorso critico. La memoria colloca il ricordo nell’ambito del sacro, la storia lo stana e lo rende prosaico. La memoria fuoriesce da un gruppo che essa unifica, ciò che equivale a dire che ci sono tante memorie quanti gruppi; che essa è, per sua stessa natura, molteplice e riduttiva, collettiva, plurale e individualizzata. La storia, al contrario, appartiene a tutti e a ciascuno, aspetto che le conferisce una vocazione all’universale. La memoria si radica nel concreto, nello spazio, nel gesto, nell’immagine, in un oggetto. La storia si installa nelle continuità temporali, nelle evoluzioni e nei rapporti tra le cose. La memoria è un assoluto mentre la storia non conosce che il relativo.
Negli ultimi giorni il dibattito pubblico ha chiamato di nuovo in causa Indro Montanelli e la natura della sua relazione con una giovanissima ragazzina abissina. Come spesso accade, ci si concentra sul sintomo, tralasciando la radice del male.
Sia chiaro: ridiscutere simboli e monumenti è un’operazione lecita di memoria collettiva.
In questi giorni si è spesse volte invocato il bisogno di un’opera di “contestualizzazione”. Ma cosa significa contestualizzare? Significa entrare nel cuore della questione: i crimini commessi dallo stato italiano in Africa. Una questione sistemica, storica e nazionale.
E’ fondamentale ricalibrare il discorso pubblico dalla vita sessuale del sottotenente Montanelli nel 1935-36, alla politica di aggressione e occupazione portata avanti in Africa dal governo italiano per oltre mezzo secolo. Madamato, matrimonio forzato, violenza coloniale non sono una questione privata.
Il colonialismo non è stato una parentesi nella storia nazionale, ma un processo culturale con salde radici, ancora mascherato dietro miti auto assolutori come “Italiani bravi gente” o il “colonialismo all’acqua di rose”, la cui eredità non è stata adeguatamente affrontata.

L’esperienza coloniale italiana è durata circa sessant’anni: dal 1882, con l’acquisto della baia di Assab, al 1943, con la fine del Ventennio fascista. Il progetto coloniale nasce in seno all’Italia liberale ed esplode negli anni del regime; l’apice del consenso popolare si ebbe durante la guerra d’Etiopia, che avrebbe riconsegnato l’Italia alla grandezza dell’impero.
Ogni progetto politico ha bisogno di una buona storia: molto ha fatto la propaganda fascista, molto hanno fatto gli intellettuali. Nei sessant’anni di impresa coloniale, l’Africa ha abitato l’immaginario italiano; il moltiplicarsi delle suggestioni coloniali nella vita quotidiana arriva a influenzare profondamente la sensibilità nazionale arrivando non solo a dare pieno sostegno alla politica espansionista, ma soprattutto a strutturare specifici rapporti di genere, di superiorità e inferiorità. L’Africa era presentata come territorio di libera conquista, in tutte le declinazioni del termine: geopolitiche, economiche, culturali, sessuali. Paradossalmente – nota il filosofo Valentin-Yves Mudimbe nel suo saggio del 2007 L’invenzione dell’Africa – nella storia delle relazioni tra Africa e Europa, più si esplorano i territori africani, più crescono anche i rapporti economici tra Europa e Africa, più il racconto si cristallizza in stereotipi, invece che articolarsi in una conoscenza reciproca. L’idea della supremazia bianca precede, non segue, l’incontro. La posizione dell’europeo nei confronti dell’africano è di dominio per diritto. L’osservazione del contesto è guidata a priori da pregiudizi che non si riconoscono come tali, ma come incontrovertibili evidenze scientifiche. Negli stessi anni di esplosione coloniale, infatti, la scienza, attraverso bizzarri protocolli di ricerca e di misurazione, aveva definitivamente sancito l’inferiorità delle razze non europee, e la necessità di civilizzarle e sfruttarle per il luminoso progresso dell’Occidente.
Per il fascismo, il colonialismo era un elemento strutturale che, nei progetti rigeneratori del regime, doveva avere il maggiore impatto possibile sulla vita della nazione. La macchina della propaganda fascista lavorò senza risparmiarsi – e con successo – per costruire il cosiddetto consenso coloniale; Mussolini orientò da subito una politica culturale coerente. Scrittori e intellettuali dovevano essere i profeti dell’imperialismo spirituale, per esportare nel mondo il nuovo italiano progettato dal regime e imporre l’Italia e la cultura italiana fascista come guida naturale per tutte le altre nazioni. La cultura era, nella prospettiva di Mussolini, a tutti gli effetti un mezzo di conquista. Esisteva, certo, in Italia un pensiero anti coloniale, ma coincideva con il pensiero antifascista e come tale veniva soppresso.

Il cinema ebbe un ruolo fondamentale, l’Istituto Luce fu dotato di mezzi straordinari e di un reparto specifico per raccontare soprattutto le imprese in Africa orientale. Lo stesso fecero a cascata i giornali, che mandarono le migliori penne di quegli anni a documentare l’azione del regime e la vita nelle colonie. Tra il 1924 e il 1927 furono fondate diverse riviste ad argomento coloniale, tra cui Esotica, che aveva come missione programmatica diffondere una letteratura coloniale di stampo fascista.
«Bisogna fare la letteratura coloniale, partire, vedere, amare, descrivere ; […] un pugno di giovani vuole l’Italia grande anche al di là del mare».
Paesi di più antica tradizione espansionista, come Inghilterra e Francia, avevano visto nascere già da diversi decenni una vasta produzione di romanzi di ambientazione coloniale. Occorreva anche in Italia una letteratura d’evasione capace di stimolare spirito d’avventura e interesse per le nuove terre da occupare. Lo scrittore Mario Dei Gaslini fu il vincitore del primo concorso per la letteratura coloniale indetto dal ministero delle colonie, con il romanzo Piccolo amore beduino. Il titolo lascia immaginare esattamente ciò che l’opera è: un romanzo meno che mediocre e vagamente pornografico. E’ interessante perché introduce uno dei topoi più praticati nella costruzione dell’immaginario italiano sull’Africa: la donna africana come sessualmente disponibile, oggetto pronto a sottomettersi alla volontà dell’uomo, Venere nera che promette « lascive nudità e orgiastici godimenti », come suggerivano anche le numerose cartoline pornografiche che avevano come soggetto discinte donne africane. Le donne venivano rappresentate come merce da comprare, vendere o conquistare; gli uomini africani come animali infidi o inerti, prede di esperti cacciatori (leggi: gli invasori); senza forza, né intelligenza, né capacità, né principi morali.
La donna araba è una prigioniera silenziosa che non ha armi per i suoi amori: può essere rapita dal primo uomo: può essere vinta dal primo sogno: ma sa chiudersi nel suo silenzio e nascondersi così, poveramente, come in un gran mantello o in gran dolore. Anche al dolore la donna dice sommessamente di sì, perché il suo destino di regina imprigionata è ancora questo: essere un’anima piccola che obbedisce timidamente: null’altro.
Così scrive il nostro Mario Dei Gaslini. Ma non è solo in questa balda impresa. Nel 1927 Guido Milanesi scrive La sperduta di Allah, romanzo fieramente razzista ambientato nella Libia coloniale. Racconta di un uomo che si innamora di una donna indigena ma, illuminato dagli ideali fascisti, si rende conto che appartengono a due mondi diversi. E che il suo è il migliore.
Soltanto la donna orientale, ch’è abituata alla sottomissione e all’assoluta docilità, può far della propria voce una carezza così. (..) L’animaletto prezioso del piacere, senz’altro diritto che il capriccio d’un maschio.
Milanesi si improvvisa anche etnologo, passando l’informazione che la riduzione della donna ad oggetto è legittimata dal fatto che avveniva già nel nativo contesto patriarcale musulmano. L’uomo italiano – buono e civile – si trova per le mani un esserino docile che chiede solo di essere sfruttata.
Creata unicamente per rimaner murata e non aver altro scopo alla vita che il piacere d’un uomo. (..)Sa bene ch’ella non può essere altro che una cosa, abbandonata alla lussuria d’un uomo. (..)Sapevo che la donna araba s’abitua sin da bambina ad essere la cosa, la schiava del maschio, la femina che soddisfa l’erotismo animale tra l’impastatura d’una polenta ed una macinatura d’orzo.
Un altro narratore dell’amore esotico, Gino Mitrani Sani, che scrive nel 1926 E pei solchi millenarii delle carovaniere, tratteggia una figura esemplare del rapporto uomo/donna in contesto africano:
Io mi prenderò quella donna. E poi me ne andrò ancora per le interminabili carovaniere. Ed Aurìa sarà stata una cosa nuova che si prova per curiosità, come i balocchi nuovi che da ragazzi si rompevano per vederne i misteriosi meccanismi che li facevano muovere, e che poi rimanevano abbandonati, perduti in un canto, in un ripostiglio pieno di polvere od in una soffitta di vecchie cose. Perché Aurìa l’avrei lasciata così. Col solito mio disgusto.
Sono brevi esempi di una narrativa che lavora sulla sessualità, sull’immaginario libidinoso, che inventa un mondo da sottomettere per la volontà di potenza dell’uomo fascista. Le rappresentazioni della donna sono mirate a creare desiderio sessuale in un universo esotico, dove i tabù e la morale della borghesia occidentale sono sospesi. A queste narrazioni, di dubbio valore letterario ma capillarmente diffuse ed esaltate dalla politica culturale fascista, si affianca un’iconografia dell’Africa e della donna africana di cui le cartoline del disegnatore Enrico De Seta sono il corollario visivo. Un incentivo per la gioventù italiana esaltata da un’ ideologia machista e razzista.
Analoga funzione di raccontare le colonie come terre di avventure e meraviglie hanno (con una direzione assolutamente diversa) i reportage giornalistici. Nel 1939 Curzio Malaparte e Dino Buzzati sono inviati dal Corriere della Sera in Etiopia e in Libia. L’obbligo è celebrare l’espansionismo fascista, pena la censura. Malaparte scrive pezzi entusiastici e dai titoli suggestivi come L’Africa non è nera, Città d’Impero bianco, Le Dolomiti d’Europa, Alle frontiere della tradizione bianca, Nella Romagna d’Etiopia; esalta l’eroismo dei coloni civili e delle azioni militari italiane; parla degli ascari come semplici di spirito, che diventano feroci combattenti se addestrati dagli italiani; i nemici sono dipinti come bande di ladri di bestiame, briganti e non civilizzati. Buzzati, invece, limita il più possibile l’adesione ideologica, non mette l’accento sulle vicende militari, si concentra su aspetti culturali e descrizioni di paesaggi. Anni dopo, nel 1952, scriverà nel racconto Un’udienza: « In Africa orientale il lavoro giornalistico era difficilissimo perché tutti i problemi interessanti – e dio sa se ce n’erano – erano tabù e bisognava girarci intorno con estrema precauzione. […] Bisognava astenersi dalle sdolcinature e tenerezza riguardo gli Abissini, nessuna fraternizzazione. Assoluta e netta divisione tra la razza che domina e quella che è dominata». Nonostante la cautela professionale, e nonostante Buzzati non fosse uno scrittore politico, dei settantatré articoli che scrisse in Africa, tredici gli furono censurati. Molto diversi nello stile e nella visione, stupisce vedere che, quando si parla di guerra, i due scrittori rivelano qualcosa in comune. Un bambinesco entusiasmo, un languore romantico nel guardare alle azioni belliche, nel raccontare la propria eccitazione a partecipare «a un autentico episodio di guerra. E’ stata una cosa bellissima. Sembrava uno dei racconti di cosacchi o qualche episodio delle guerre dell’Ottocento. Romanticamente perfetto!… L’ambiente, gli spari, la galoppata… Una cosa stupenda!». Son parole di Buzzati. Appare in filigrana il mondo in cui sono immersi, che inneggia alla violenza e alla sopraffazione, che aveva fatto dell’Africa una terra dove tutto è lecito, dove i cadaveri del nemico sono ammassi di carne senza ricordo né valore, senza forma d’umano.
Nel 1936 viene pubblicato in Italia il romanzo XX Battaglione eritreo del giovane Indro Montanelli, che ottiene subito un grande successo. Lo scrittore Ugo Ojetti loda il taglio anti retorico della narrazione, annunciando un nuovo Kipling italiano. Montanelli, in Africa, di guerra non ne vide molta: il suo battaglione di ascari aveva compiti secondari e, in ogni caso, fu presto assegnato a servizi amministrativi per motivi di salute. Se lo stile è più misurato rispetto agli entusiastici resoconti a cui era abituato il pubblico dell’epoca, lo sguardo sul nemico e sulla realtà africana è allineato al proprio tempo. Dal racconto non emerge alcuna considerazione umana verso gli avversari né interesse o curiosità intellettuale nei loro confronti; Montanelli è certo della superiorità dell’uomo bianco e i diritti dei conquistatori non sono messi in discussione.
C’era un branco di pidocchiosi che venivano avanti col randello e coi fucili che avrebbero fatto arrossir di vergogna un caporale di Franceschiello. La mitraglia, lì in mezzo, scavava come un piccone nella zolla fresca. […] Quando finì, andai a vedere i morti. C’erano arrivati a pochi passi e lì s’ammucchiavano. Anche questa di avvezzarmi a veder sangue senza lasciarmene sconvolgere è una ginnastica che m’è mancata. Cento morti non sono uno spettacolo più impressionante di un solo morto.
Negli anni Montanelli denuncerà l’errore politico e storico dell’impresa in Abissinia: «Tutto ciò che noi vi cercavamo – la gloria militare, il Lebensraum economico e demografico – erano valori scaduti in via di scadimento perché risultavano troppo costosi, e lo stesso concetto di colonia stava entrando in crisi perché incompatibile coi rapporti verso cui il nuovo mondo si stava avviando.» Non parla di errore umano, o di errore culturale. Il sottinteso in questo tipo di revisione dell’esperienza coloniale è che il colonialismo non sia un male in sé, ma che sia stato un problema di calcolo. Di opportunità economica e politica. Il discorso di Montanelli è sintomatico della coscienza di una nazione intera. Non c’è denuncia, non c’è presa di coscienza della modalità violenta, appropriativa, che è dell’Italia, dell’Europa, del mondo occidentale tutto. Una violenza strutturale che ha preso la forma storica del colonialismo ma che continua a operare tramite le nostre categorie, finché non le decostruiamo. La mentalità coloniale non muore con il fascismo, molte rappresentazioni si sono cristallizzate nel nostro immaginario collettivo, annacquate in un linguaggio politically correct. Finché sceglieremo di relegarle alla vicenda di un singolo perderemo l’occasione di affrontare le conseguenze sociali e culturali della rimozione della nostra esperienza coloniale.
Su qualsiasi tentazione auto assolutoria, al di là di qualsiasi scusa e relativizzazione di contesto, scende il racconto tagliente e illuminante di Ennio Flaiano:
Il 7 marzo ad Adi Onfitò arriva il gruppo Spahis del II Corpo d’Armata, ispeziona qualche tucul. Gli abitanti, che avevano già ottenuto da altre truppe il permesso di libera circolazione vengono uccisi in massa. Le donne e gli uomini asserragliati nella chiesa sono trucidati. Una donna, la più avvenente, viene posseduta in circolo e poi nel suo sesso è introdotto un tizzone[…] Poi la chiesa viene sgomberata dei cadaveri. Si decide di bruciarli. Alcuni militi della 1078 si accingono all’impresa disgustosa. In una cassa viene trovata, gli occhi sbarrati dal terrore, una povera malata. Vien messa insieme agli altri vicino al rogo. Un centurione la scorge e urla: ‘Ma è viva!’. Risponde il milite: ‘No, signor capitano, è quasi morta’. Ad ogni modo, la donna, salvata dal fuoco la sera, vi andò l’indomani. Era morta nella nottata.