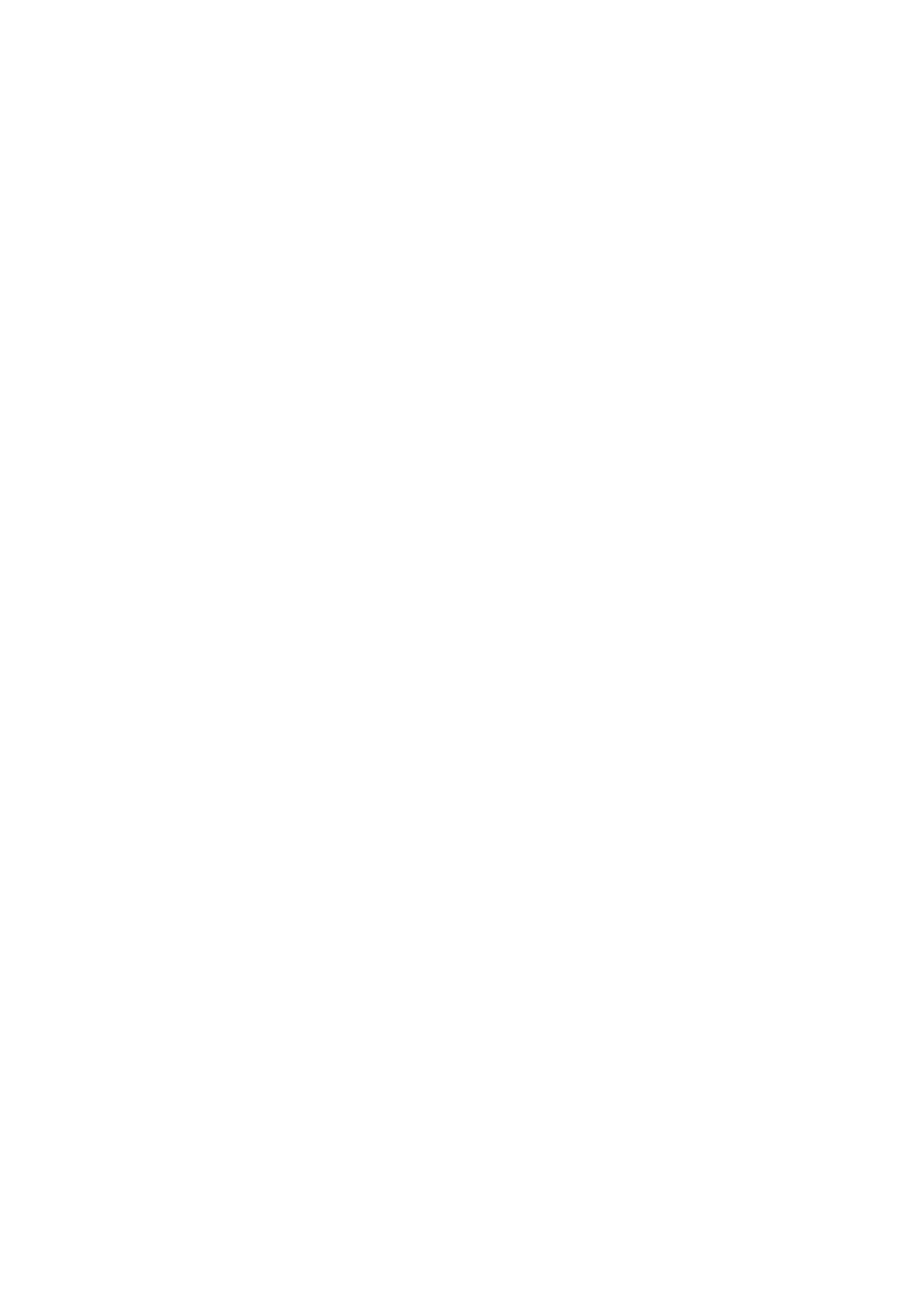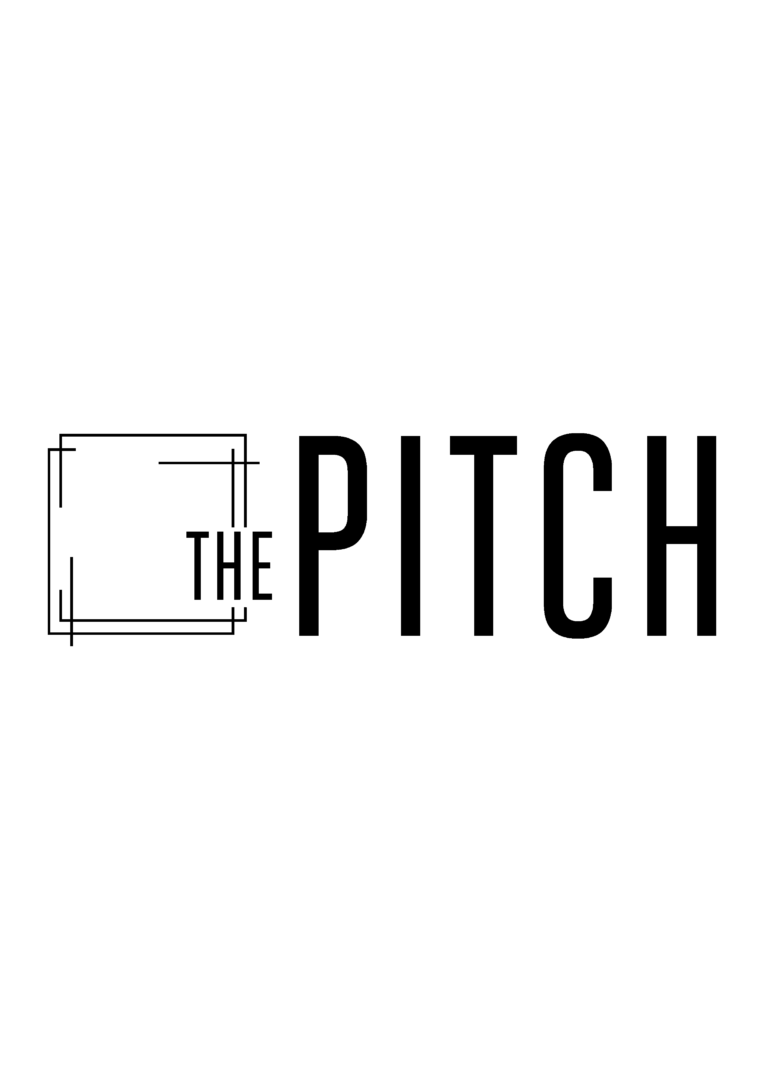Aleksandr Sokurov. Il cinema oltre il tempo
C’è qualcosa nel cinema di Sokurov che riesce andare oltre il tempo, a scardinarlo, a passargli oltre. Lo attraversa e lo supera, lo penetra e lo fa suo. È un altro tempo, che cambia forma e passo, che si “stira” come le sue immagini, che si fa quadro e pittura, espressività che mescola visione, colori e suoni. Il suo è un cinema fluttuante: mette tra parentesi il tempo per porlo in risalto. E se Arca Russa, forse il suo film più celebre, è di fatto un film sul tempo, in gran parte dei suoi lavori Sokurov ha mostrato il tempo attraverso la lentezza, mostrandone la densità.
Avvicinare Aleksandr Sokurov all’idea di Slow Cinema è perciò quasi naturale, per il modo in cui i suoi film riescono a incarnare quell’esigenza di contemplazione e di ingresso nelle immagini, per vivere ciò che si sta guardando.

Il discorso portato avanti dal regista russo ha tanto da condividere con l’idea di un cinema lento e contemplativo ed è stato affrontato in svariate forme: dal cinema di finzione al cinema documentario, sino ad arrivare al genere a sé delle elegie, caratterizzate da un tono lirico e riflessivo. Il lavoro sulla consistenza del tempo e delle immagini è stato portato avanti con attenzione soprattutto negli anni ’90, quando il cinema di Sokurov si è fatto via via sempre più rarefatto, sottraendo il più possibile elementi dall’immagine, riducendo l’azione e lasciando i suoi personaggi in una dimensione a metà tra il pensiero e la realtà. È la grande apertura verso il tempo interiore: del dolore e dell’addio in Salva e custodisci (1989), con la lunga scena del funerale di Emma Bovary che si presenta senza stacchi, e proietta al suo interno lo spettatore, come se fosse presente. È il tempo che lascia spazio al ritorno, all’ombra, come in Pietra (1992), dove un Čechov tornato in vita vive fisicamente lo spazio e la consistenza delle cose come se fosse la prima volta. È il tempo interiore del dilemma, quello di Pagine sommesse (1994), in cui la rarefazione dell’immagine raggiunge il suo estremo, fa scomparire i personaggi rendendoli invisibili, un tutt’uno con lo sfondo, una cosa sola con la materia: acqua, nebbia, fumo, le rifrazioni della luce diventano estensione e incarnazione del dentro e del fuori (un processo che abbiamo visto, in altri termini, anche in Tsai Ming-liang, che in Goodbye, Dragon Inn nascondeva i personaggi e li rendeva invisibili, come fantasmi).


Ma è forse Madre e figlio (Mat y sin, 1997) l’esempio più lampante di cosa significhi andare verso un cinema dello spazio interiore e della lentezza; una lentezza dove, grazie alla dilatazione dello spazio e delle immagini, irrompe il tempo.
Lo spazio temporale della storia è esiguo, sia da un punto di vista esterno – il film dura un’ora e dieci minuti – sia da un punto di vista interno: è la storia di un figlio e di sua madre, nell’ultima ora della sua vita. Madre e figlio racconta l’affacciarsi all’incombenza della morte, la difficile accettazione da parte del protagonista di staccarsi dalla figura materna, di lasciarla andare. E per raccontare il difficile lavoro interiore Sokurov ci racconta il silenzio: la dimensione della cura, dell’ascolto: la passeggiata tra i boschi con in braccio la madre, che chiede di fare un’ultima camminata all’aria aperta; la profonda attenzione di esaudire e accogliere i suoi ultimi desideri. Ma è anche il vuoto, il silenzio che separa dal momento della morte, la richiesta di una messa tra parentesi del tempo, come se quel momento, in fondo, non dovesse mai arrivare.

L’immagine in Madre e figlio si fonde col silenzio, il silenzio col tempo. Sokurov dipinge con la macchina da presa, e per dare una dimensione pittorica all’immagine la “stira”, la deforma, rendendola piatta e bidimensionale. È il cosiddetto processo dell’anamorfosi. Portare l’immagine a due dimensioni, senza una profondità, rende il tempo ancora più distante. Ma è anche deformare l’immagine per dilatarla, aprirla a una dimensione ulteriore, quella interna, che funziona con una temporalità e una spazialità diversa.
Il fuori diventa perciò espressione del dentro. Se il tempo interiore segue un altro corso, con regole differenti, il tempo raccontato da Sokurov in Madre e figlio si fa un flusso che lascia spazio al silenzio e muta forma, una flessione del tempo che passa attraverso l’immagine. E se l’immagine può apparire all’apparenza deformata, questa è in realtà dipanata nel suo manifestarsi interiore, svolta come un tappeto srotolato che mostra l’interno delle sue pieghe. Un po’ come se il tempo interno, ripiegato e condensato, venisse “aperto”, appiattito su una superficie e per questo mostrato secondo una forma distorta e allungata.


In Sokurov c’è una profonda attenzione e studio nei confronti dell’immagine, ma ciò non significa dare un peso sostanzialmente superiore alla tecnica rispetto al contenuto, il contrario: «Le idee devono sempre e comunque prevalere sulla tecnica, proprio perché sono esse a determinare la costruzione dell’immagine». E per come emerge dalle pagine dei diari e dei quaderni di lavoro (materiale prezioso che si può trovare nel libro Nel centro dell’oceano) il lavoro sull’immagine ha via via teso sempre più verso una “profondità della superficie”, e la ricerca di una densità del tempo: «Mi pare che oggi la mia percezione del tempo sia cambiata. […] Vorrei far sì che la reale durata dei miei film fosse minore, ma che l’immagine diventasse sempre più “densa”».
Il processo di distorsione dell’immagine, che è processo attivo nella ricerca della “densità”, va di pari passo con l’idea dell’immagine-quadro: inquadrature sostenute, molto spesso in totale, dove lo sguardo fa ingresso nell’immagine e ha tempo per ambientarsi rispetto a ciò che sta vedendo, per guardare. Così, all’interno del quadro, le variazioni delle immagini e dei suoni assumono un significato molto più forte: il sibilo del vento che muove i campi, lo stagliarsi lontano dello sbuffo della locomotiva, non visibile perché troppo lontana. E poi, il lento affacciarsi e allontanarsi del treno stesso, quando il protagonista ne contemplerà il suo passaggio, come se fosse metafora della condizione di sua madre e del suo stesso modo di viverne la perdita.


In un passaggio del racconto cinematografico che Sokurov fa di un altro suo film, Alexandra, troviamo la sintesi della sua poetica, che è in qualche modo anche la poetica dello Slow Cinema: «Questo silenzio altera il tempo, lo rende prezioso».