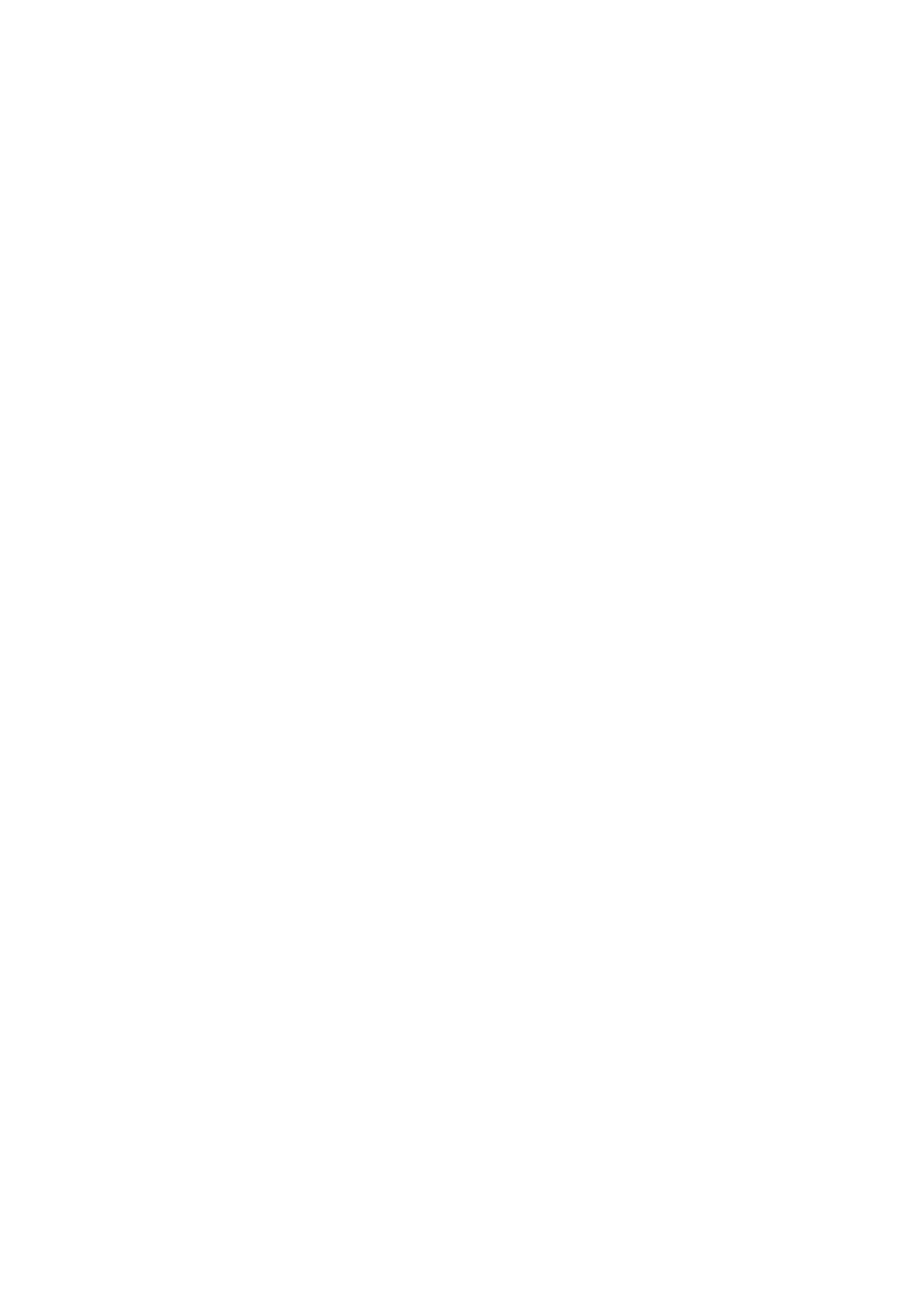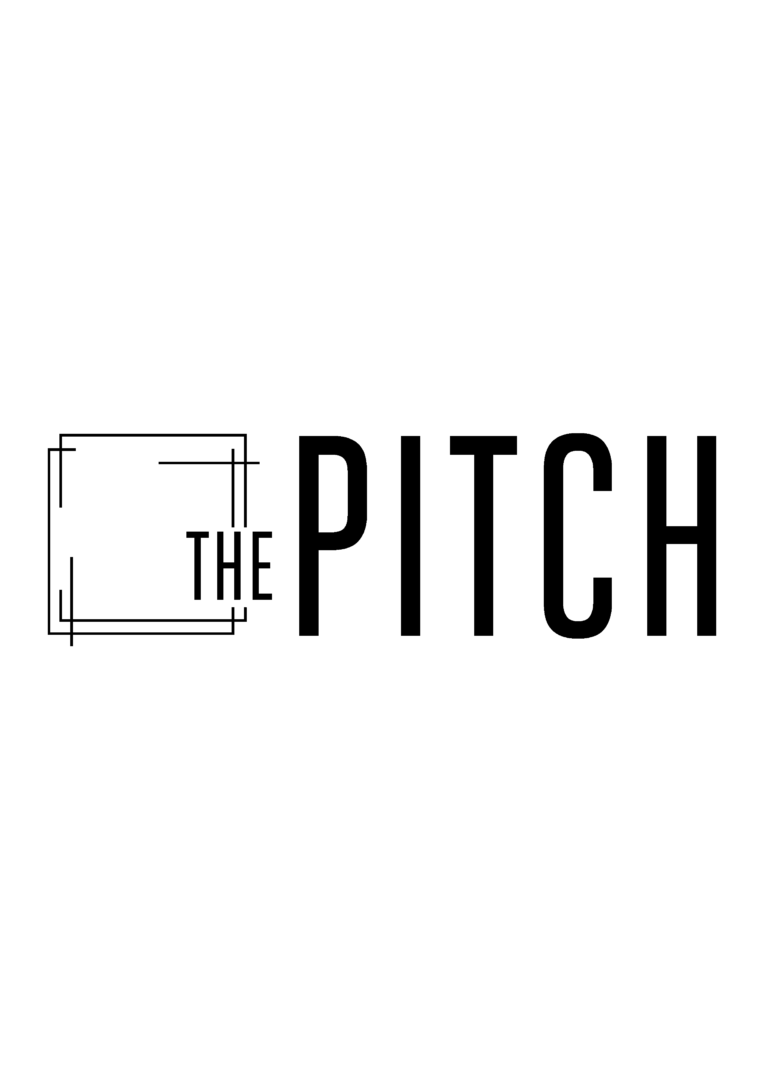Quello che resta di The Last of Us
A cura di Jacopo E. Molè
¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar
Eduardo Galeano
Potrei non piacervi, non mi stupirebbe. Ma cercate di starmi almeno a sentire. Ve lo dico perché è raro che si dia ascolto a un qualcuno che d’emblèe si mette a parlare, davanti a un calice di vino, del più importante evento fumettistico nella storia recente dei super eroi: la Civil War di mamma Marvel. Eppure anche a distanza di tredici anni è un tema interessante, e apre davvero ampie possibilità di dibattito costruttivo. Ma la storia si fa con i fatti, e in quel caso, parlo per esperienza, conviene buttar giù l’amaro calice di chi, al posto di parlare di filosofia coi supereroi di mezzo, parla di filosofia e basta.

Ma qui non stiamo parlando. Qui non si tratta di discutere, per quanto ami il confronto tanto quanto lo pseudo-Voltaire che morirebbe per farvi dire la vostra idea. No, qui morirei affinché possiate rendervi conto che tutto quello di cui sto per parlarvi, a poco meno di una settimana dal suo approdo al mondo, rappresenta già un caso “editoriale” asceso all’Olimpo dell’entertainment, e privarsene per pregiudizio costituirebbe uno spregio alla cultura pop contemporanea. Qualcuno ha già provato a buttarlo giù dal suo giovane scranno, addirittura con alcuni tentativi di golpe preventivo; e in tutta risposta, il protagonista di queste pagine ha steso i detrattori con un machete, fedele in tutto alla sua linea e al suo spirito. Ma andiamo con ordine.
The Last of Us – Parte II è l’ultima fatica videoludica di Naughty Dog, un tempo piccolo studio salito alla ribalta nel 1996 quando si inventò un platform per PlayStation tanto semplice quanto efficace, che ebbe giusto un briciolo di successo ed eredità: Crash Bandicoot. Ne è passato parecchio, di tempo, le consolle si sono evolute, la internet ha rivoluzionato anche il mondo dei videogame, e complice la convergenza mediale, ha fatto sì che certe tematiche o fenomeni di costume rilasciassero spore contagiose e senza alcun tipo di repellente efficace. Non parlo di spore giusto per dire: nella nuova corsa al tema post-apocalittico degli anni 2005-2015, che faccio coincidere con il periodo a cavallo tra l’uscita del rivoluzionario 28 giorni dopo di Danny Boyle e il suo apice assoluto nel 2015 con Mad Max Fury Road di George Miller, tra le varie forze a falcidiare il genere umano, perlopiù devianze derivate da sconsiderati tentativi di venire a patti con il complesso di Dio, zombie, rabbiosi, insettoidi, biocostrutti, invasioni aliene e compagnia cantanti, a portare una ventata d’aria fresca (seppur altamente contaminata) è stato proprio lo scoprire che non servono grandi scienziati o eserciti di morti viventi per trovare l’orrore, e che, se volesse, Madre Natura potrebbe fustigarci senza che neppure ce ne accorgessimo, grazie ad una delle forme di vita più semplici e sottostimate del pianeta: i funghi.
ATTENZIONE: SEGUONO SPOILER DI QUALCHE ENTITÁ RIGUARDO THE LAST OF US, E MINIMI SPOILER RIGUARDO THE LAST OF US – PARTE II. MA OH, SUCCEDE.
É il 2013. Joel, un padre single di Austin, Texas, non ha mai pensato ai funghi se non nei momenti-barbecue tipici della sua nazione, e non sa che il suo mondo sta per cambiare per sempre. Mentre la televisione stride a riguardo di una strana infezione data da una particolare specie di fungo amazzonico, la città cade in poco tempo preda degli infetti, e in qualche decina di minuti è tutto nella morsa del Caos. In una rocambolesca fuga dalla città al fianco di sua figlia Sara e il fratello, Tommy, tra checkpoint e schermaglie di pazzoidi rabbiosi, la piccola compagnia si spacca ancora prima di uscire dalla città. Padre e figlia vengono separati dallo zio. Quando poi un giovane soldato spara a Sara, uccidendola, assieme a lei muore anche Joel, e il mondo per come l’aveva conosciuto.

Venti anni dopo, il mondo è una sequela di avamposti quarantenati da un governo al tracollo, e Joel, dopo un passato tra le schiere delle Luci, movimento di stampo partigiano in perenne contrasto con la dittatura militare, si guadagna oggi la vita come contrabbandiere. I sopravvissuti vivono con difficoltà in città divise in blocchi stagni, impossibili da valicare senza un lasciapassare, o senza il fegato e l’esperienza di Joel. L’uomo non lotta più, trascina dietro di sé una carcassa, quella della sua vecchia vita, impossibile da lasciar andare, ma che alimenta in lui un odio e una rabbia a volte difficili da comprendere. Tutto in quel nuovo mondo ruota intorno al controllo dell’infezione, che ovviamente è tutto fuorché controllata, e la città è divisa tra chi muore di fame, chi muore, o peggio, non muore, a causa dei morsi degli infetti, e le lotte intestine tra kingpin criminali e militari dalla mano pesante. Quando una vecchia conoscenza di Joel, Marlene, leader della resistenza, promette all’uomo e alla sua partner Tess una grossa ricompensa in cambio della scorta di una teenager, Ellie, verso la centrale operativa delle Luci a Salt Lake City, Joel, sebbene dubbioso, accetta. Ben presto Joel si ritroverà solo con la ragazzina, ad attraversare un paese che nessuno conosce più, dove anche una sosta refrigerante può diventare un’agguato, e dove non è più chiaro chi sia il mostro, se l’infetto, o chi prova a imporsi con la forza.
Parrebbe così su due piedi una trama già vista, il genere è pieno di road stories attraverso un paese, spesso gli Stati Uniti, in cui è andato tutto a̶̶ p̶̶u̶tta̶n̶e a farsi benedire; va ricordato in primis il romanzo The Road del 2007, che è valso il Premio Pulitzer a Cormac McCarthy, e a cui innegabilmente il gioco prova a fare da reboot spirituale. Bene, è così. É una trama apparentemente scontata e già vista, tutto già visto, una cosiddetta “avventura dinamica” in terza persona che sfrutta il motore grafico e la giocabilità di un’altro titolo made by il Cane Malandrino, vale a dire Uncharted, titolo simile dall’inflessione adventure con all’epoca due capitoli all’attivo. Cos’ha di speciale dunque? L’idea.
C’è una grande idea alla base, che traspare fin da subito dal titolo, a primo impatto traducibile con un poco introspettivo “gli ultimi di noi”, “gli ultimi rimasti”, ma mi si conceda la licenza di uccidere la lettera e di passare al fulcro che rende incredibile un gioco incredibile: QUELLO CHE RESTA. E ai due personaggi principali, apparentemente, non resta niente, se non attraversare il paese con una speranza non del tutto chiara, né tantomeno sicura; “e qualcosa rimane”, tra una fucilata a un infetto e un antro oscuro. Lungo mesi di cammino, dove Ellie si guarda attorno spaesata, confusa dai lasciti di un vecchio mondo che non ha mai conosciuto, e che si prepara pian piano al tracollo, in cui, letteralmente e filosoficamente, di umanità è rimasto solo qualche sprazzo. I grattacieli resistono, distrutti e infestati, quasi come le “due enormi gambe di pietra si ergono imponenti e stroncate nel cuore del deserto” declamate da P.B. Shelley nel sonetto Ozymandias. Joel comprenderà a caro prezzo quanto quella ragazzina significhi per il mondo, fino a capire che non gli importa delle sorti della nazione tanto quanto lei conti per lui. Il percorso, e dunque le circa 30 ore di gioco garantite, è costellato di sequenze d’azione, esplorazione di scorci e cut scene di qualità (quando non di simil-quicktime event) che non possono limitare il titolo in questione alla semplice definizione di videogioco, bensì ad un maggiore legame con l’arte totale, tra quadro, esperienza interattiva, romanzo e film, che vedono un’interessantissima evoluzione dei protagonisti, inversamente proporzionale al continuo disgregamento della civiltà.

Quattro anni dopo i sanguinosi eventi del primo capitolo, – E QUI ATTACCA IL SECONDO CAPITOLO DELLA SAGA – Joel e Ellie vivono a Jackson, Wyoming, dove un nutrito gruppo di sopravvissuti, capeggiati da Tommy, ancora vivo, provano con tenacia e difficoltà a ripartire, improvvisando una normalità sempre precaria. Ellie è cresciuta, Joel è invecchiato, e i due non vanno più molto d’accordo. Quando quello che chiunque abbia giocato il primo titolo prega non accada, accade, Ellie si sentirà in dovere di partire alla ricerca dei responsabili di un evento che segnerà per sempre la vita della giovane, alla soglia dell’età adulta, alla scoperta di sè stessa, dei suoi sentimenti, delle sue pulsioni, sessuali, viscerali e violente, della sua forza, fisica e d’animo, e delle sue paure, il tutto in un mondo nuovo, che del vecchio mondo non ha più nulla, se non vaghi ricordi che faticano a morire. Le gambe della statua di Ramesse II sono proprio crollate, sulla civiltà del passato “le piatte sabbie solitarie si estendono oltre confine”, e coprono le grida di aiuto, i fischi di richiamo, i lamenti degli infetti, le grida di un paese che non esisterà mai più. QUELLO CHE RESTA, in questo secondo capitolo, è apparentemente il nulla. Solo un’illusoria ragione di vita. La vendetta.
Ma credo che voi stiate leggendo per avere l’ennesima recensione, giusto? Probabilmente è così. E allora vi accontento, indossate una maschera antigas e calatevi in questa metropolitana buia. Proverò a guidarvi. É l’unica umana consolazione che troverete, parlando di questo titolo. Perché se tutto il gioco è un inno all’arte, il sentimento che ne scaturisce è però la drammatica accettazione del male dipinta dall’espressionista danese Edvard Much, una condizione a cui non si può sfuggire, un homo homini lupus innato, raccontato anche da W. Golding nel suo Signore delle mosche, che ti rende preda e predatore in un continuo gioco al massacro dettato da prospettive, affetti e necessità diverse. Comincerò con un’operazione che non ho mai compiuto, ovvero il debunking delle molteplici voci intercorse in questi anni di spasmodica attesa riguardo questo sequel. Poi, se sarete ancora alle mie spalle e non preda di qualche Bloater furioso, continuerò a dirvi la mia. In questa prima fase non citerò le fonti, non per ignoranza, ma perché non credo che chi mi sta spingendo verso questa missione suicida, e voi con me, apprezzerebbe.

É UN OPEN WORLD?
Dove per open world game si intende, esempio su tutti, la saga di Grand Theft Auto (GTA), una varietà di ambienti esplorabili, missioni da affrontare, interazione con l’ambiente ampia e articolata; allora NO, non è un open world. La formula brevettata con Uncharted, migliorata con The Last of Us e riconfermata da tre seguiti dell’altro titolo, continua a suscitare fascino e hype. Un mondo lineare, dunque, con ambienti esplorabili in parte, anche visto il vasto numero di “collezionabili” all’interno dei titoli, e alcune zone più ampie per permettere sequenze action più godibili e interpretabili, per chi apprezza lo stealth più classico o per altri che, con in mano un mitra, sparano a qualsiasi cosa si muova e poi fanno domande; l’innovazione di questo seguito sta nel level design, studiato fino alla manìa, dove non è facile perdersi, bensì è facile PERDERE qualcosa, come armi, potenziamenti, materiali per il basico crafting (sfruttato, a mio parere, non al meglio, ma chi volesse di più può lanciarsi su titoli come Ark: Survival Evolved o il classicissimo Minecraft. Qui si gioca un altro sport. Le strade e i vicoli dello stato di Washington e della sua capitale morale, Seattle, sono un dedalo che apre spesso a punti completamente vuoti, ma ci insegnano che ogni angolo, ogni negozio, ogni vetrina può avere qualcosa da insegnare o raccontare sugli avvenimenti. Non servono grossi spiegoni da cattivo di film di James Bond, e non siamo di fronte all’ennesimo gioco con lore interpretabile (qualcuno ha detto From Software?). L’angolo buio in fondo al tunnel che scricchiola, e non per le mattonelle rotte, ma a causa del suono degli infetti di secondo stadio (Clicker) può condurci verso un arma bianca improvvisata, estremamente necessaria nelle sequenze di combattimento ravvicinato, o al biglietto di addio di un padre ai suoi figli, ma può portare anche al nulla più estremo; è lasciato al giocatore e al suo istinto di conservazione la voglia di scoprire. Certo, il respawning frequente rende tutto molto comodo, ma la scelta di una difficoltà maggiore a inizio del gioco (tra l’altro modificabile in corso d’opera) sprona davvero il giocatore a scegliere tra una risorsa in più o la salvezza.
É UNA STORIA DI VENDETTA?
Dove per vendetta si intende il far valere il proprio odio e la propria rabbia su quella degli altri, allora sì, è una storia di vendetta. É un altra di quelle cose che sono rimaste, la tempra dell’essere umano a rivalersi; e questo accade perché, nel momento in cui la tua quotidianità, già precaria e costantemente minacciata dalla quotidianità esterna, fatta di soldati, squilibrati e infetti, viene del tutto destabilizzata, quello che resta è la spinta autogena a cercare la pace interiore attraverso lo sfogo della violenza. Ma non pensiate che questo concetto venga sviscerato dal gioco con somma linearità: tutto il lungo percorso (o, meglio ancora, i percorsi) è costellate da situazioni al limite della sopportazione, che se i personaggi cercano di vivere con determinazione, lasciano dentro di noi dei sommari Mexican standoff culminanti nella coscienza dell’aver compiuto qualcosa che forse non avremmo voluto fare; e non parlo della sommaria violenza con cui ci si fa strada in quello che appare in tutto e per tutto un “nuovo far west”, bensì di dettami di trama e gameplay a cui dobbiamo sottostare, e che, se appaganti al termine delle sequenze più febbricitanti, non sono esenti da momenti “cos’ho appena fatto”. I vari nemici (sulla cui intelligenza artificiale si sarebbe certo potuto fare di più) hanno addirittura una vaga forma di background; quando spariamo senza remore in testa a un nemico umano, e non umanoide, sentirete davvero i suoi compari di ronda disperarsi, chiamarlo per nome, maledirvi, e la loro reazione incazzata non è che la mossa successiva di una partita a scacchi tra visioni divergenti. Tra i tanti in Jokes presenti, una delle protagoniste, Dina, personaggio certamente fondamentale ai fini della trama, porta un nome di origine ebraica che tra i suoi significati ha proprio VENDETTA. E se non fa per voi, dovrete venirci a patti, che vi piaccia o meno. Siamo in guerra. Una guerra intestina che qualcuno porterà al termine, anche se non è facile immaginare come.
É UN TITOLO CHE POTREBBE NON PIACERE?

Dove le parole di Neil Druckmann, regista del progetto, non danno facili spiegazioni; perché vendere un gioco che non garantirebbe apprezzamento globale? Per qualche scelta azzardata nel gameplay? Per la ripetitività dei “livelli”? Assolutamente no, se contate che la community di giochi come FIFA o CALL OF DUTY, che fanno del pattern di ripetitività il ferro su cui battere per migliorare le proprie skills, poichè come anche questo gioco cerca di insegnarci, il mondo, il nostro, fa schifo. Ancor prima del day one (ricordiamola come un nuovo anno 4.0 nella storia della narrativa in game, il 19 giugno 2020) il sito METACRITIC corrispondeva al titolo Naughty Dog un valore medio di recensioni del pubblico pari a 3.5 (oggi fermo comunque a 4.5), mentre il voto corrisposto dal sito stesso risulta essere 94/100.
Siamo ovviamente di fronte all’ennesimo caso di shitstorming, e non potrebbe essere diversamente, quando l’unico modo per ricostruire la civiltà sembra scardinare i valori fondativi della cultura statunitense: ARMI e FEDE. La protagonista, Ellie, che già avevamo visto scoprire sé stessa nel DLC del primo capitolo, intitolato Left Behind, ha oggi una relazione “interraziale” e omosessuale con una ragazza di cultura ebraica, Dina, appunto, che fino a poco tempo prima frequentava un ragazzo, Jesse, tanto asiatico quanto importante nello svolgimento della trama; e questo fatto, prontamente disprezzato da alcuni membri anziani della città di Jackson, viene velocemente affrontato da alcuni appartenenti alla comunità (perlopiù amici o conoscenti della protagonista) con un immenso GET-OVER-IT. Ma non solo. Tra le voci che raccontano questa storia, troveremo Abby, altra ragazza a cui la vita non ha certo sorriso, anche lei in cammino sul filo dell’antica frontiera statunitense, che, per dirla in maniera generale, non rispecchia proprio lo stereotipo di fanciulla in distress, ha abbandonato gli shorts e i “toppettini” della Lara Croft poligonale e ipersessualizzata per favorire la costruzione di un personaggio credibile, una ragazza “forte come un toro”, “dalle braccia grosse”, indipendente, spregiudicata, lontana anni luce dai vestitini porpora e scosciati di Ada Wong (uno dei volti femminili della classica saga horror di Resident Evil), E MENO MALE.
Un gran gioco, con protagoniste due donne molto diverse tra loro (ma sarà poi vero?) che si fanno beffe dei maschi e dei loro dettami patriarcali, retaggi di una società che non esiste più, e che si cerca di tenere in vita per aggrapparsi a QUELLO CHE RESTA. Ma, come adorano dire gli inglesi, “you can’t flog a dead horse”, non puoi frustare un cavallo morto e a zittire invasati e alt-right (che siano in game oppure off game) ci penseranno le nostre protagoniste, che si troveranno a far valere, appunto, QUELLO CHE per loro RESTA, contro due diverse fazioni di nemici: da una parte i Lupi (WLF, Washington Liberation Front, altro gruppo partigiano nato sullo stampo delle Fireflies presenti nel primo capitolo, e presto crollato sotto il peso delle armi verso una deriva autoritaria e militarista che non tarderemmo a definire dittatoriale; dall’altra le Iene, o Serafiti, una comunità cristiano-primitivista che ricorda quella di The Wicker Man o del recente Midsommar, dove i dogmi vengono fatti rispettare a suon di penitenze e percorsi di espiazione. Una lotta intestina tra bestie, quindi. Lupi contro Iene. Se queste due anime degli Stati Uniti sono le uniche a risultare maggioritarie e anacronistiche, allora ben vengano donne come Ellie ed Abby, a cui probabilmente avrei affidato la mia stessa vita. Pensate che gli attacchi al sistema odierno siano terminati qui? Vi sbagliate di grosso, ma non sta certo a me raccontarvi di come la riflessione sulla sessualità prenda corpo e anima di questo gioco, con somma pace dei detrattori alt-right che, tengo a ripetere, GET-OVER-IT. Il gioco è davvero scomodo, da questo punto di vista, per chi vede ancora in Duke Nukem e negli Schwarzenegger anni ’80 i protagonisti ideali del videogioco SPARA SPARA SPARA – CONQUISTA LA RAGAZZA un ennesimo modo per consolidare l’ideologia cisgender.

Proprio “a causa” di questa storyline, per cui tra l’altro sono anche partite inutili petizioni per chiedere a Naughty Dog un rewriting infattibile. IL GIOCO É VIETATO in Algeria, Egitto, Iraq, Iran, Giordania, Libano, Libia, Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Siria, Tunisia, Yemen, Emirati Arabi e Palestina; dove le recensioni non servono, interviene direttamente la censura. Ma penso che a suo modo Druckmann e il team di Naughty Dog abbiano proprio cercato di dire questo: è il vecchio mondo a dover cambiare, e appassire, sta all’essere umano di oggi ripopolarlo. E lo faranno ragazze come le nostre protagoniste, non certo uno dei tanti pazzi maniaci invasati che popolano le strade. Il gioco ha in questo senso fatto davvero un salto in avanti, pur non essendo nuovo a tematiche scomode. Indimenticabile la sequenza finale del primo capitolo, dove una Ellie poco più che bambina scampa a quello che, a tinte fosche, è un tentativo di stupro, da parte di un uomo adulto a capo di un clan di cannibali. Un tentativo di stupro, già. Come a dire: se nel primo capitolo il gioco mostrava una fallacia nel sistema-costituito ANCHE e soprattutto sul piano dei ruoli e dei generi, The Last of Us – Parte II conferma che, per quanto bigottismo e lobby siano solidi, il loro impero è destinato ad accartocciarsi su sé stessi proprio grazie a personaggi importanti, IMPORTANTI, come le nostre due protagoniste, talmente atipiche da venir considerate delle reiette anche dalla propria gente. Tutto il gioco vede continui riferimenti al grande Johnny Cash, certo non un sostenitore del socialismo genderfluid, ma comunque cantore americano degli ultimi, non certo di cardinali e generali. In un fanta-western come questo, miglior colonna sonora non si poteva chiedere.
PICCOLA RECENSIONE IN DUE PAROLE Il gioco SPACCA.
Le teste dei nemici, i limiti narrativi del videogioco, il nostro cuore. Avete apprezzato il primo? Apprezzerete sicuramente anche questo, e la sua narratività incrociata e spiazzante. Se il gameplay ha subito qualche piccolo restyling e implemento (come già accennato, qualche opzione di crafting maggiore, alcune ottime migliorie alle sessioni action…) per il resto sembra davvero di guardare il secondo capitolo di un titolo a noi molto caro, e dico guardare perché le sequenze non giocabili sono molte, e scorrono bene pur nella loro lentezza; chi accusa la trama di eccessivo patetismo o piattezza spero si dia un’occhiata intorno e poi mi faccia sapere, perché di fronte a certe sequenze (arrivate all’acquario con Ellie, e poi contattatemi) accusare The Last of Us – Parte II di piattezza sarebbe come dare del rettile a un koala. Forse manca la novità assoluta, l’innovazione vissuta col primo capitolo, ma quale sequel viene accusato di non mantenere al suo interno lo spirito originario, solo implementato? Il sequel brutto, e questo fortunatamente non lo è. Temo un po’ per quanto riguarda la rigiocabilità del titolo, imprescindibile una seconda run per trovare tutti i collezionatili e platinare il gioco, ma anche grazie all’ormai diffusissima possibilità di saltare i filmati, sarà come rivedere un western arrivando direttamente o quasi alle sparatorie. Di level design abbiamo già discusso, mancano i veri antagonisti della storia, quelli con cui tutto è cominciato: i funghi. Il cordyceps, tipologia realmente esistente che si comporta con gli insetti della foresta amazzonica analogamente a come visto sugli esseri umani nel gioco, si è evoluto e ha dato vita a nuove progenie “pustolose” e virulente; ma allora perché parlarne così poco? Perché basta poco a capire che essi siano ormai parte di un corollario, quasi in secondo piano. Come nel mondo reale qualcuno addita il 5g e i vaccini in un’ostentazione quasi divinatoria, o dove si chiede libertà di sparare indiscriminatamente a seconda del proprio metro di giudizio, qualcuno non vede negli animali dei wet market cinesi i colpevoli, bensì in chi i wet market continua a farli fruttare. Quello che appare chiaro è che SOLO LA COMUNITÁ e la RISCRITTURA DELLO STATUS QUO può sconfiggere l’infezione, isolandola fuori dalle zone sicure e lasciando, purtroppo o per fortuna, fuggitivi, reietti, fanatici, soldati e semplici essere umani ad una triste fine in solitudine. Il mostro più spaventoso è come al solito quello dentro di noi. Se cediamo alle pulsioni sbagliate, QUELLO CHE RESTA è solo il nulla. Miglior momento per far uscire un gioco simile, non si poteva trovare.
I’m just a poor wayfaring stranger/ Traveling through this world below/ There is no sickness, no toil, nor danger/ In that bright land to which I go
Johnny Cash