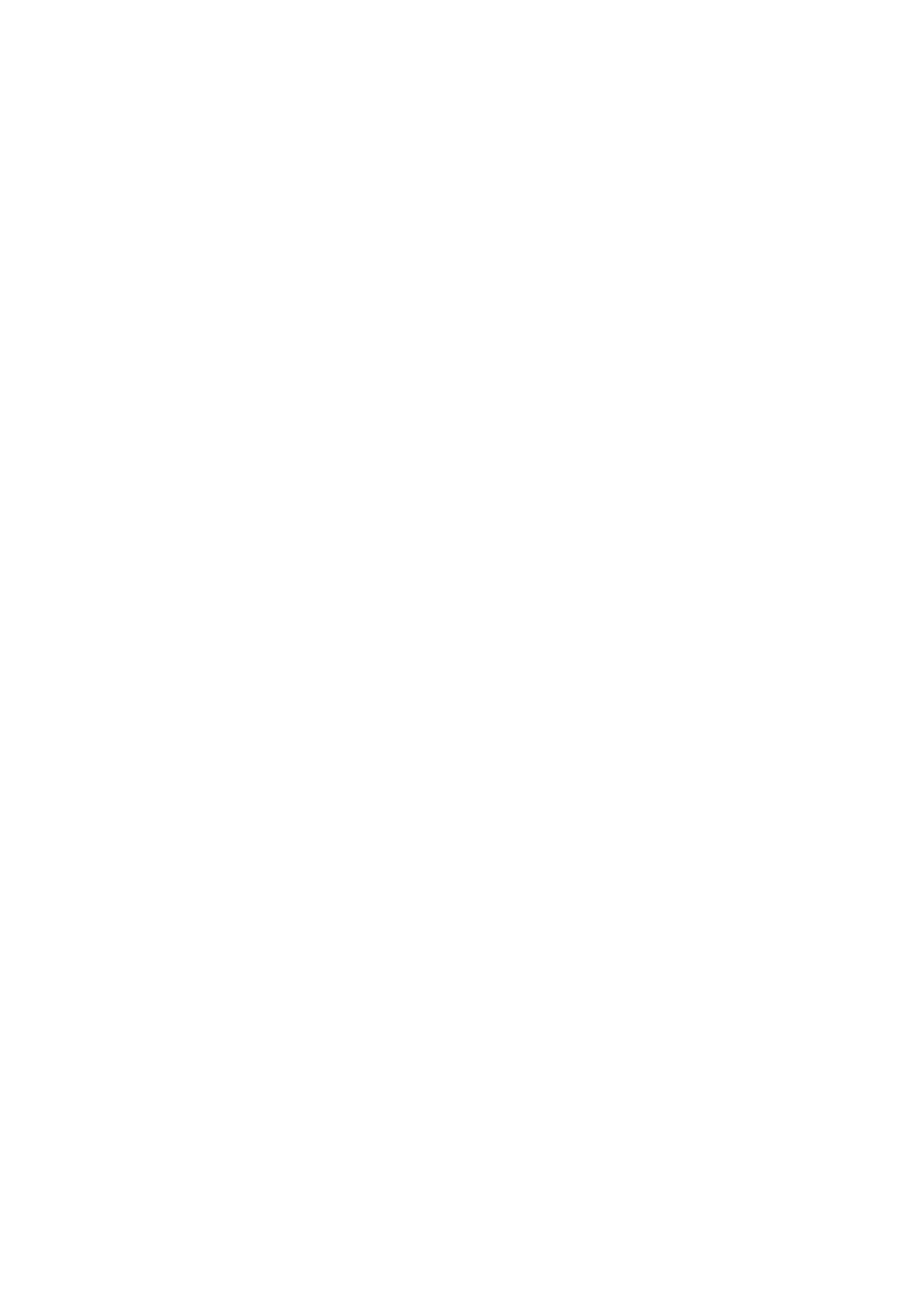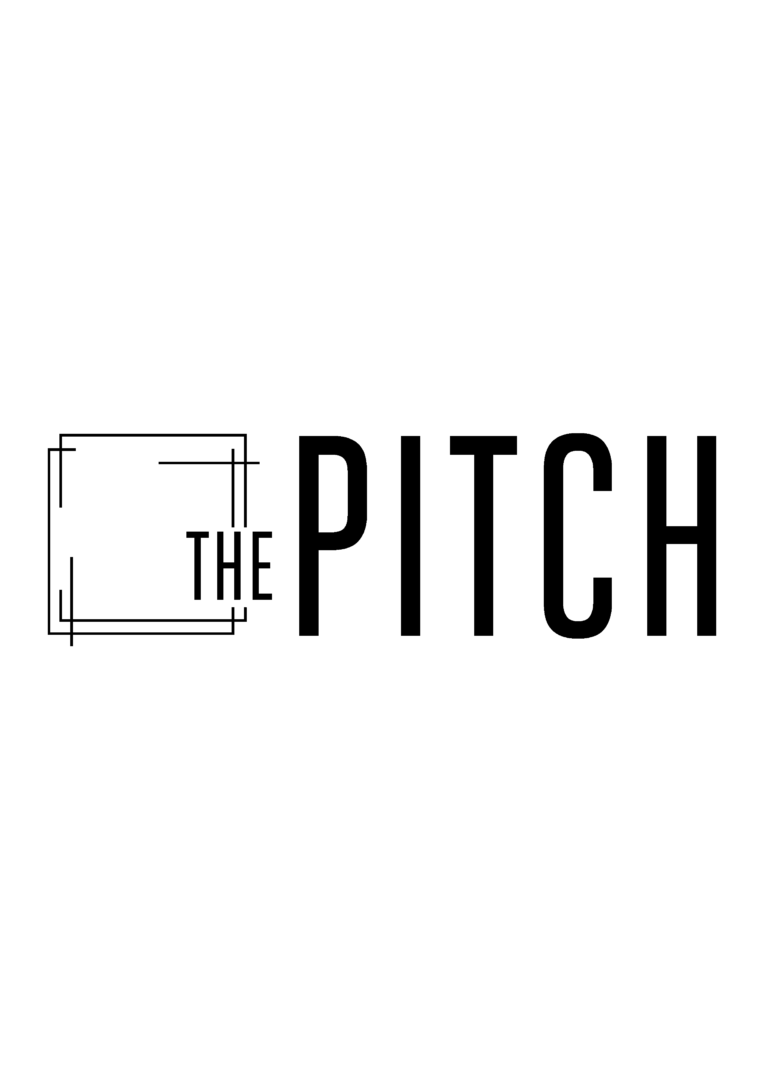Tsai Ming-Liang, un cinema in proiezione
Partiamo da due immagini. La prima è quella di una sala cinematografica deserta, popolata da spazi vuoti e qualche rara presenza umana – e se fossero soltanto presenze? La seconda una conseguenza della prima. Mentre imperversa il temporale, a coprire i manifesti e le locandine campeggia una scritta che non lascia spazio a interpretazioni: “chiusura temporanea”. Ora aggiungiamo un elemento: la lentezza. Una lentezza estrema, di quelle che ti fanno chiedere cosa stai guardando, dove il “cosa” diventa realmente un motore di senso. Uniamo i tre elementi e avremo la sintesi dello Slow Cinema, il suo esempio più significativo: Goodbye Dragon Inn.

Goodbye Dragon Inn (Bu San, 2003) di Tsai Ming-Liang oggi acquista un senso ulteriore di fronte allo spopolamento forzato dei cinema per via del Covid-19, senza contare lo strascico fisiologico che si è portato con sé.
I cinema oggi sono aperti, ma lo sono davvero? Gli spazi vuoti, di fatto, pretendono la loro voce. E quelli della sala cinematografica raccontata in Bu San sono spazi vuoti che chiedono di essere popolati, anche solo da passi zoppi che lentamente si trascinano dal fuori campo all’inquadratura, percorrono il nostro campo visivo e poi scompaiono nuovamente.
Il cinema proietta, ma chi guarda? C’è chi è in sala per scappare dal temporale, chi sgranocchia per automatismo, chi è lì solo per ricordare il suo passato di attore, in veste di fantasma – «Non ci guarda più nessuno».


Goodbye Dragon Inn è il film dell’attesa, anzi, è l’attesa del film, della sua fine, del momento in cui finirà la proiezione e la custode potrà pulire la sala e chiudere i battenti. La materia del film, di per sé, è proiettata da un’altra parte, gioca di rimando verso qualcosa che non stiamo vedendo, agendo per sottrazione estrema, togliendo all’apparenza forma ma dando densità allo spazio. Potrebbe sembrare un discorso astratto e privo di un precipitato sul senso stesso del film, eppure la filosofia dello Slow Cinema sta tutta qui: diamo consistenza al tempo e allo spazio, lasciamo che lo spettatore si interroghi su ciò che sta guardando, non bombardiamolo di immagini ma offriamogli una possibilità di significato, che passa silenziosa “dentro” la pellicola, in profondità, penetrandola.

Il silenzio chiama l’attesa, l’inazione espande il senso della pur minima azione, quando questa finalmente prende forma. La prima battuta arriva dopo 45 minuti. Ma è solo una questione formale? Un vezzo estetico? La realtà è che l’assenza di parole e azione genera un senso di attesa e di assunzione da parte dello spettatore di un significato che verrà. Non andremmo al cinema per vedere spazi vuoti o tele bianche e silenziose; andiamo al cinema perché cerchiamo storie, un arricchimento personale, qualcosa da portar via con noi. Dopo 45 minuti, fuori dalla sala, a proiezione in corso, un uomo parla al ragazzo sfuggito al temporale: «Sai che questo cinema è infestato? Fantasmi». Una singola battuta proietta sul film un significato nuovo, lo riqualifica e trasforma ciò abbiamo visto nella prima metà, ponendo un nuovo senso di visione per ciò che ancora dovremo vedere nella seconda. Dragon Inn – il film “cappa e spada” proiettato – è destinato a finire, e con lui è destinato a chiudere il cinema, perché «al cinema non ci va più nessuno», perché la sala è vuota e le poche sedie piene sono sedie di fantasmi. Di fatto, nel totale della sala, i posti occupati nemmeno si vedono.

Torniamo così alla nostra prima immagine: le luci della sala vuota si accendono, si sentono i passi lenti e faticosi di una donna claudicante, la custode tuttofare che abbiamo avuto modo di conoscere durante la proiezione del film nel film, la sua attesa, l’attesa della fine. La donna entra e percorre la sala, sale e scende le scale, pulisce. La scena è lunga, sostenuta. L’azione, pur ridotta all’essenzialità, è presente. Ma la custode esce e i suoi passi si perdono in lontananza. Rimane la sala vuota. Michelangelo Frammartino a proposito di questa scena ha detto: «Il piano rimane vuoto per dieci secondi, venti, trenta, un minuto. Ok, pensi, l’ha fatta un po’ lunga, ma ora taglia. Dopo un minuto e mezzo capisci che stai guardando qualcos’altro. Ed è folgorante».
La lentezza ha una grande arma dalla sua parte: l’attenzione. L’occhio distratto che passa da un’inquadratura all’altra può perdersi pezzi senza rimproverarsi più di tanto: i dettagli scorrono via nel flusso e in fondo ci sono i personaggi e la storia ad aiutare – o al peggio c’è l’amico vicino a cui chiedere. Non è solo l’occhio a essere distratto, ma anche l’immagine a distrarre. L’inquadratura lenta, persistente e per certi versi anche invadente, obbliga all’attenzione: perché siamo ancora qui? Che succede? Cosa c’è da vedere? Ed ecco che qualcosa è successo: siamo davvero dentro all’immagine, tutt’a un tratto.
fonte immagine copertina: quinlan.it