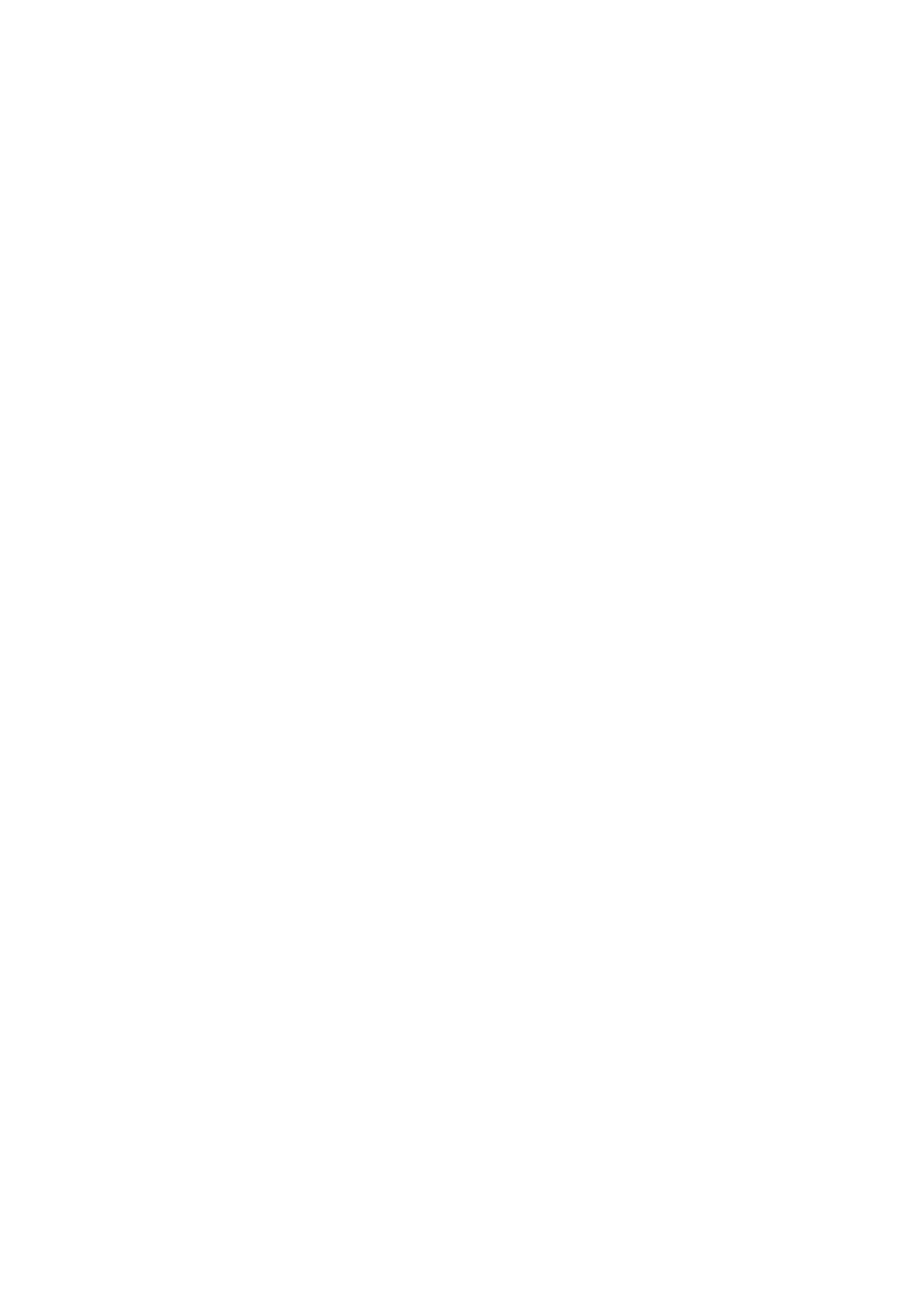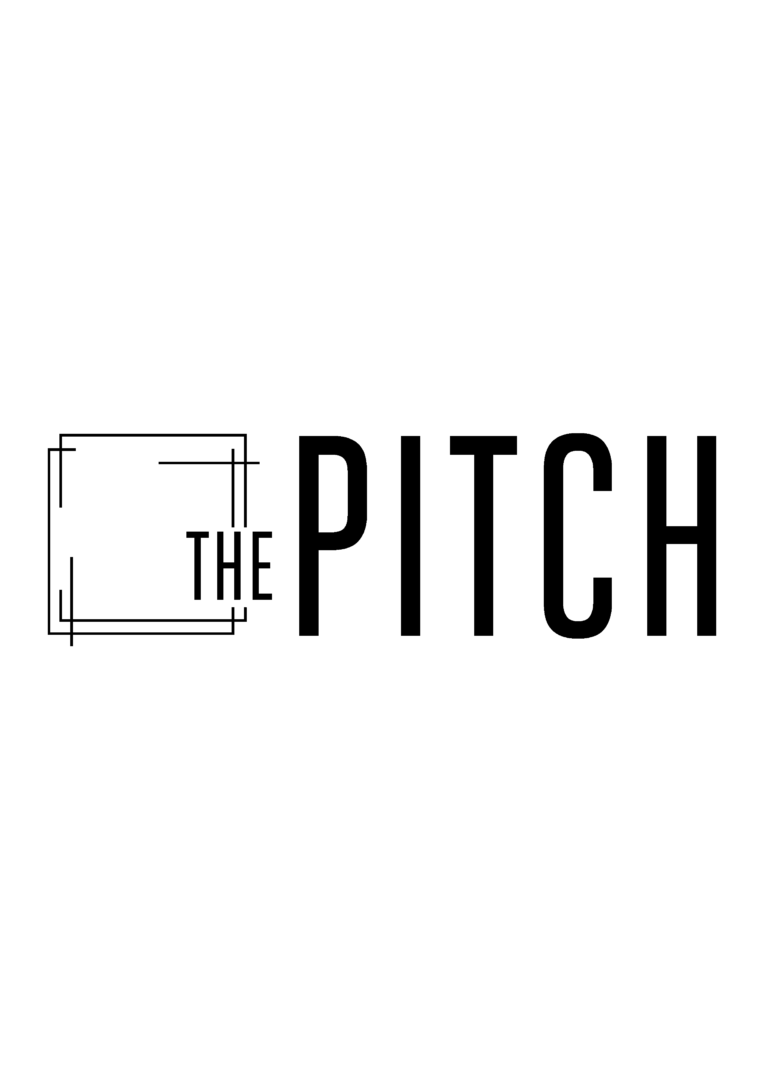Quando il mondo (del calcio) scoprì l’Olanda
Un fulmine a ciel sereno, una cosa mai vista, una rivoluzione. Chiunque avesse più di 10 anni nel giugno del 1974 ricorda così la nazionale olandese ai mondiali di Germania, quella del totaalvoetbal, del terzino che «correva in avanti e andava al posto del centravanti», del portiere col numero 8 e del 10 che faceva il libero. Su quella squadra bellissima e maledetta, sulla sua incompiutezza così perfetta ed epocale e sul suo principale cantore – numero 14 in un mondo ancora capace di contare solo da 1 a 11, macchina da soldi in un calcio ancora operaio ma anche genio visionario in uno sport ancora fermo al dogma del catenaccio – sono stati versati fiumi d’inchiostro e consumati chilometri di cellulosa. Discorso analogo riguarda l’Ajax di Rinus Michels, principale serbatoio di quella nazionale da sogno e insieme tomba – galeotta la fascia di capitano – del sogno stesso.
Una squadra, quella, capace di imporsi per tre volte consecutive sul tetto d’Europa e di portare alla ribalta una nazione, i Paesi Bassi, fin lì relegata ai margini della geografia del pallone. A ben vedere, però, i primi a portare il paese dei tulipani nella sala dei bottoni non furono gli ajacidi di Amsterdam. Per ritrovare i «fiori della prima volta» bisogna andare qualche decina di chilometri più a sud, là dove Reno, Mosa e Schelda si confondono in un unico delta divenuto nei secoli sede del più grande porto del continente: Rotterdam. E precisamente allo Stadion Feijenoord, soprannominato bonariamente De Kuip, “la vasca”. Lo stesso in cui vent’anni fa un golden goal di Trezeguet tarpò le ali ai sogni di gloria di un esercito di giovani millennials calciofili ancora ignari di esserlo (millennials, sulla calciofilia avevamo qualche sospetto). Ma tranquilli: in questa storia non ci sarà nessun golden goal.

D’oro nel nostro caso sono solo le proverbiali uova della gallina. E la gallina ha un nome e un cognome: Ernst Happel. Nato a Vienna nel 1925 e talmente sfortunato da esordire con la maglia del Rapid in piena guerra nel 1942, si rifà con gli interessi prima sul campo con una medaglia di bronzo conquistata con la nazionale ai mondiali tedeschi del ’54 e poi, soprattutto, in panchina. E pensare che nell’estate del 1969, al momento della chiamata dei biancorossi di Rotterdam freschi campioni d’Olanda, il “Mozart del pallone” è reduce da nove stagioni alla guida del modesto ADO Den Haag che gli hanno fruttato solo una Coppa nazionale. Eppure il numero uno del Feyenoord Guus Couwenberg crede in lui: sa che gli austriaci in panchina (Happel è il quinto) hanno sempre portato bene al club. Quello che non sa è che quell’uomo austero e torvo dagli occhi incavati sta per far saltare il banco.
«L’utilizzo intelligente e singolare che gli olandesi fecero dello spazio sul campo da gioco – scrive David Winner, autore di Brilliant Orange: il genio nevrotico del calcio olandese – rispecchiava secoli di gestione e sfruttamento dello spazio limitato di cui il loro paese disponeva». Non è un caso che la prima affermazione di quel modo rivoluzionario di guardare a un campo di calcio si sia palesata proprio a Rotterdam, là dove l’uomo si è dovuto difendere dal mare per poi arrivare a dominarlo e a trasformarlo nella propria ricchezza. Lo spazio come ossessione: strappare terreno all’acqua per costruirci la vita, rubare campo agli avversari per avvolgerli. «Il catenaccio è come un dipinto di Tiziano – azzarda lo storico dell’arte Rudi Fuchs – morbido, seducente e languido. Gli italiani ti accolgono, ti blandiscono e ti cullano in un morbido abbraccio, per poi segnare un gol che sembra una pugnalata. Gli olandesi, come in un Vermeer, costruiscono schemi geometrici».


Sotto i colpi del Feyenoord di Happel, dopo il KR Reykjavik, cadono nell’ordine i campioni in carica del Milan, i tedeschi orientali del Vorwärts Berlin e i polacchi del Legia Varsavia. In tutti e tre i casi gli olandesi ribaltano tra le mura amiche il risultato sfavorevole dell’andata, attaccando con una costanza e una sistematicità fino ad allora sconosciute a gran parte delle squadre del continente. In finale, davanti ai 53 mila di San Siro, il 6 maggio 1970 va in scena uno scontro ideologico prima ancora che calcistico: il Celtic, campione tre anni prima, è britannico fino al midollo. Non solo negli interpreti – tutti scozzesi gli undici in campo, scozzese il tecnico Jock Stein, scozzese la panchina – ma anche e soprattutto nella maniera di intendere il football: i pronostici sono tutti per i biancoverdi di Glasgow. E invece quella sera, collegato in Eurovisione, tutto il Vecchio Continente assiste al cambio di passo.
Scopre che il pallone si può far girare finché non s’individua il varco buono. Scopre che sfruttare sistematicamente il fuorigioco impedisce alle punte di ricevere palloni giocabili. Scopre che se le linee si compattano, gli spazi per attaccare si moltiplicano e quelli per essere attaccati si riducono. Insomma, scopre il calcio totale. Forse ancora acerbo, forse non ancora armonico e armonioso come quello che incanterà il mondo quattro anni dopo, ma di sicuro nuovo. E vincente, nonostante per avere la meglio sugli scozzesi alla squadra di Happel servirà un regalo del libero Billy McNeill quando alla lotteria dei rigori mancano solo quattro minuti. Autore del goal partita è lo svedese Ove Kindvall ma la mente di quella squadra, il suo Cruijff, è Willem van Hanegem che del Profeta sarà compagno di reparto e alter ego nella (splendidamente) perdente spedizione di Germania – in quella successiva in Argentina il Profeta del gol non ci è andato, ma questa è un’altra storia.

Il Feyenoord riesce dove l’Ajax ha fallito l’anno precedente e porta in Olanda una coppa che fino a quel momento è stata appannaggio di italiani, spagnoli, portoghesi e britannici. È allora che un paese nel quale il calcio professionistico è arrivato solo nel 1954 si avvia a diventare un vero e proprio laboratorio tattico a cielo aperto. Ma se del filo rosso che lega il totalvoetbal al tiki taka, la Amsterdam Arena al Camp Nou e Michels a Guardiola si sono riempite le cronache degli ultimi decenni, inspiegabilmente la figura di Happel – il primo a dipanare di fronte al mondo quel filo – è rimasta, almeno in Italia, sempre abbastanza in ombra. E dire che il tecnico austriaco sarà anche il primo, nel 1983, a laurearsi campione d’Europa alla guida di due squadre diverse. Negli anni lo eguaglieranno Hitzfeld, Mourinho, Heynckes e Ancelotti ma l’impresa compiuta con Feyenoord e Amburgo resta epica.
Cos’è rimasto, a distanza di mezzo secolo, di quel laboratorio tattico a cielo aperto? Per usare ancora una volta le parole di David Winner, «gli olandesi oggi stanno sperimentando a livello calcistico quello che agli inglesi è successo in ambito geopolitico», scrive tradendo i suoi natali l’autore di Brilliant Orange. «Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo gli inglesi diedero vita alla rivoluzione industriale. All’inizio, l’invenzione delle ferrovie, delle tecniche di produzione della ghisa e delle fabbriche di cotone procurarono alla Gran Bretagna un potere economico e un vantaggio strategico nei confronti dei rivali. Ben presto, però, questi ultimi copiarono e migliorarono le tecnologie britanniche fino a superarle. Gli olandesi hanno esportato la loro idea di calcio nel mondo. Il mondo ora ha appreso la lezione e li ha superati». Di certo un austriaco era già allora più avanti di loro. Forse di tutti.