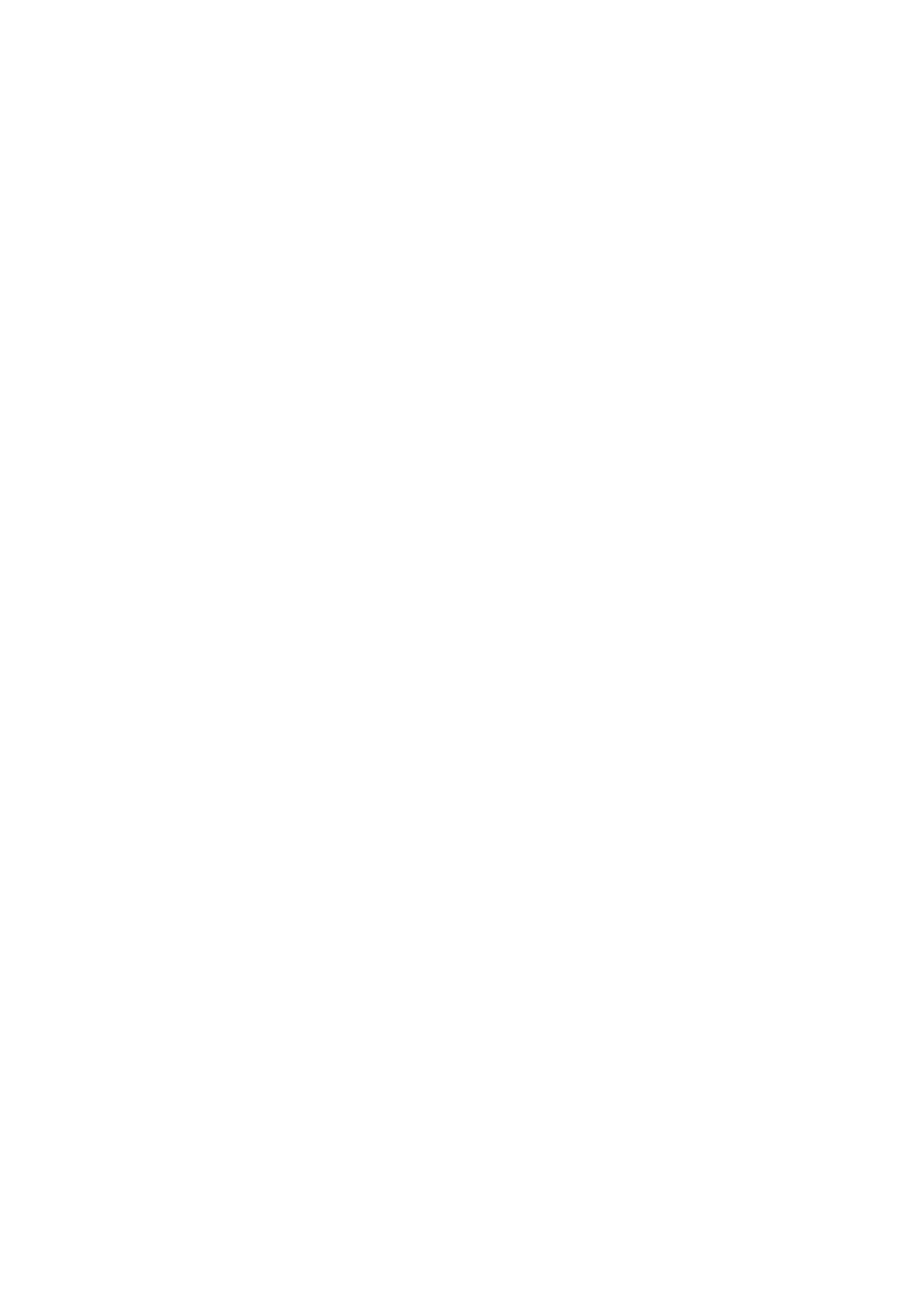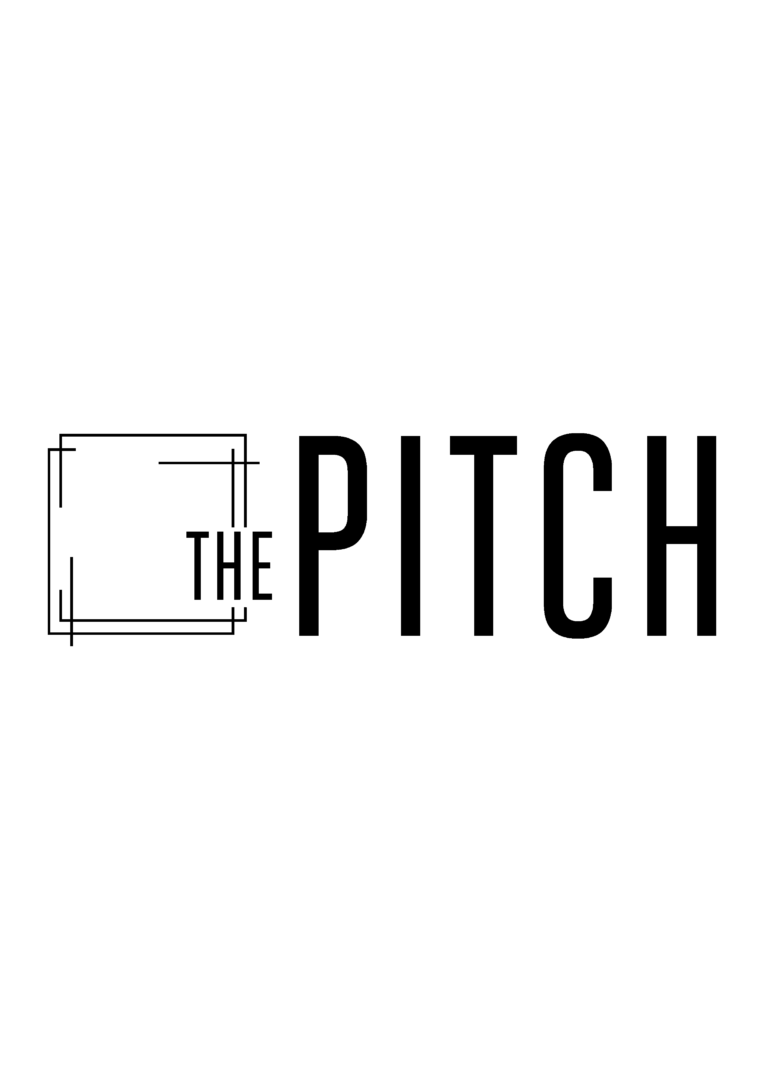Il lungo settembre del mondo dei videogiochi
Deserti mediorientali, spiegamento di forze americane, l’arabo come lingua nemica: una riflessione su un’intera era videoludica
“Di cosa possono parlare i videogiochi?” è una domanda complicata e dibattuta all’interno del settore da molti anni. Domanda che gli sviluppatori di grande portata affrontano coi piedi di piombo poichè trasformare una tragedia in un “gioco”, anche con le intenzioni migliori, è qualcosa che quasi nessuno ha intenzione di fare.
Parlare dell’impatto dell’undici settembre nel mondo dei videogiochi è contemporaneamente molto semplice e molto complicato. Per chi ha un’idea vaga dell’evoluzione del mondo degli sparatutto realistici a tema guerrafondaio, e questo è il genere più impattato dall’evento, c’è stato un netto momento di distacco in cui il settore si è completamente trasformato. Chi lo conosce per bene sa che la situazione è più complessa di quanto sembri.
Ma andiamo con ordine. Molto semplice perché la reazione immediata è stata quella più comprensibile: una operazione che ha attraversato l’intero settore, una operazione di distruzione e ricostruzione votata a rivedere molti giochi in via d’uscita per garantire che non commettessero scelte di pessimo gusto. Dalle cose più ovvie, come cancellare le torri gemelle dalla skyline di parecchi titoli o rivedere materiale pubblicitario che le mostrava in primo piano, fino a lavori molto più dispendiosi — due fra tutti, i tagli significativi fatti al finale di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, in cui una portaerei futuristica si schianta contro la costa e i palazzi di New York, e la revisione di buona parte della trama e del setting di Grand Theft Auto 3 per rimuovere somiglianze con New York e sottotrame legate al terrorismo.
Per parafrasare una famosa citazione, ora che tutti gli americani avevano visto un grattacielo che crollava in mezzo a un quartiere abitato, inventarselo da zero come spettacolo di esplosioni e fiamme sembrava quantomeno di pessimo gusto.
Complesso perché, tolte queste reazioni comprensibili, il mondo dei videogiochi ci mise anni prima di far sentire pienamente l’impatto epocale dell’evento nel settore. I motivi sono molteplici, passando dal fatto che trasformare in gioco l’undici settembre è un’idea sfortunata, per dirla eufemisticamente (non che qualcuno non ci abbia provato), alla fedeltà grafica non ancora considerata al punto giusto per poter coprire queste vicende. Da considerare che non si tratta di un mondo che segue particolarmente la cronaca, preferendo trarre ispirazione da fantasia e immaginazione — e spesso ferocemente criticato quando succede, come nel caso dell’appropriazione dei simboli di Black Lives Matter da parte di Ubisoft per un gruppo terrorista, subito rimossi.
Ma il motivo principale è che mancava un apripista, qualcosa che sfruttasse l’ondata di emotività popolare creando qualcosa di così potente da diventare, sia impossibile da ignorare, che seguito da tutta l’industria. Il mondo dei videogiochi ci mise anni ad assorbire il cambiamento, ma furono anni molto significativi — anni in cui gli Stati Uniti si imbarcarono in una guerra che sarebbe durata decenni, mentre l’intero filone dei videogiochi sulla Seconda Guerra Mondiale si sviluppava, esplodeva e finiva per diventare stantio come il pane della settimana scorsa.
È a questo punto che i videogiochi atterrano in Medio Oriente.
La guerra è stato, perdonate il gioco di parole, il campo di battaglia preferito dei videogiochi sin dalla nascita di Spacewar! nel 1962. La Seconda guerra mondiale in particolare: non c’è bisogno di porsi scomode questioni morali quando si falciano nazisti a palate, l’unica domanda è quale sia l’arma migliore per farlo. Erano innegabilmente un pericolo esistenziale per il resto del mondo e un’ideologia mostruosa; il cattivo perfetto per chi fa parlare principalmente la sua mitragliatrice.
Ma la situazione in Medio Oriente non è mai stata bianca e nera. Lascio le discussioni sulle responsabilità delle varie potenze e sui crimini commessi contro la popolazione a colleghi ben più preparati di me; io mi occupo di videogiochi, e una cosa è innegabile: nella generazione di PlayStation 3 e Xbox 360, tantissimi giochi erano basati sull’uccidere un sacco di gente dalla pelle scura che parlava arabo.
Non è esagerato dire che Call of Duty 4: Modern Warfare sia uno degli sparatutto più importanti della storia, il primo gioco di enorme portata ambientato (anche) in Medio Oriente e subito imitato da decine di successori — tutti a copiare le immagini provenienti dai telegiornali e a mettere i giovani in contatto quasi diretto con l’esercito americano (un collegamento, quello tra videogiochi e esercito, su cui si potrebbero scrivere interi libri). Emblematico Six Days in Fallujah — un gioco che proponeva di raccontare la battaglia di Falluja nella maniera più “realistica” possibile, dal punto di vista dei soldati americani, che si attirò critiche feroci da ogni parte della sfera videoludica e che è stato soggetto di un recente revival accolto con freddezza glaciale dal pubblico.
Un interesse per lo scenario basato unicamente sul punto di vista americano, quasi mai interessato a mostrare quei luoghi in un modo che non fosse come sfondo per il passaggio di elicotteri. Una piattezza che ha sollevato molte critiche — una fra tutte isthisarabic.com, un sito web creato dallo sviluppatore arabo-olandese Rami Ismail in risposta all’enorme numero di giochi che presentavano la lingua araba come decorazione, scrivendo testi grammaticalmente sbagliati se non completamente senza senso.
Con il tempo però tutto passa di moda, anche nei videogiochi. Come la Seconda guerra mondiale l’ondata finì, spostandosi verso lidi più fantascientifici — e generando opere critiche e riflessioni come il celebrato Spec Ops: The Line, ferocemente critico nei confronti dell’operato americano e dell’intero genere sparatutto. Le ambientazioni moderne restano, ma l’ossessione per i deserti e le città impolverate di quel tipo sembra essersi chiusa, almeno per ora. Resta un’intera generazione di videogiocatori mediorientali cresciuti con un genere in cui le uniche persone col loro aspetto erano quelle a cui si sparava, e la speranza che il ciclo non si ripeta con il “nemico” del momento in futuro.